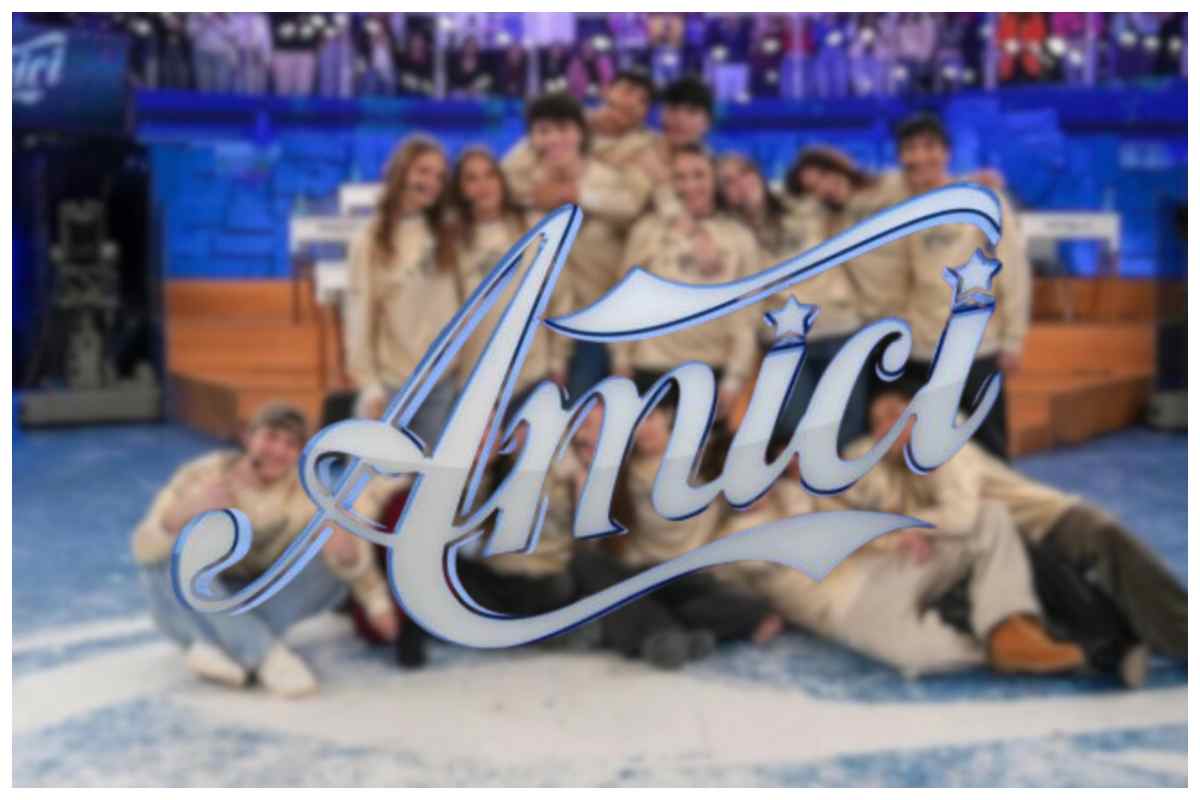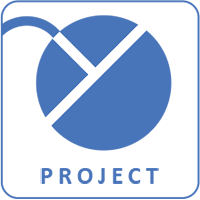“Siamo stelle che brillano”. La stella sotto le coperte
Un romanzo di formazione queer tra memoria e metamorfosi, tra resistenza e rinascita. E' "Siamo stelle che brillano" di Schisano e Piccirillo L'articolo “Siamo stelle che brillano”. La stella sotto le coperte proviene da Globalist.it.

di Alessia de Antoniis
Ci sono sempre dei libri sul comodino che attendono di essere letti. Restano lì, pazienti, in attesa che tu li apra per scoprire che sono la porta di un viaggio che attendeva solo che tu la varcassi. Uno di questi è Siamo stelle che brillano di Vittoria Schisano e Alessio Piccirillo, La Corte Editore. Un libro, una porta, che sono felice di aver aperto.
In un’Italia ancora cieca alla diversità, Siamo stelle che brillano si presenta come un romanzo di formazione potente, intimo e insieme politico. È il racconto di una crescita queer narrata con dolcezza e rabbia, lirismo e crudezza, dove la scrittura stessa diventa atto di resistenza, coming out stilistico e identitario.
Al centro Cristiano, detto Crilù, bambino di dieci anni nella Tarquinia degli anni Ottanta. Fin dalle prime pagine è evidente che qualcosa in lui devia dalla norma: ama Heather Parisi, balla “Cicale” nel salotto, è ipnotizzato dal luccichio della TV. Il mondo fuori, però, lo vede come un’anomalia da correggere. La scuola è un campo minato; i compagni lo deridono, lo perseguitano, i professori lo ignorano o, peggio, lo scherniscono. A casa, la madre è presente ma stanca, il padre distante. L’unica zona franca è sotto le coperte, dove Crilù può reinventarsi: balla, canta, sogna. E resiste.
Il romanzo si muove come una lunga immersione nella memoria, dove l’infanzia è tanto una trincea quanto un laboratorio d’identità. La violenza è concreta: scherni, insulti, un trauma scolastico filmato e diffuso. Ma lo è anche la resilienza: la scrittura dà voce a un bambino “triste, ma non rassegnato” che costruisce sé stesso pezzo dopo pezzo, e che a un certo punto decide che non si farà più calpestare.
Cruciale la figura della zia Delia: donna libera, anticonformista, ex cantante, vive sola a Ischia, isola che per Crilù diventa simbolo di rifugio e possibile rinascita. È lei a battezzarlo con il nomignolo Crilù, quasi fosse un rituale d’iniziazione verso la verità più profonda di sé. – “Crilù è un nome più bello di Cristiano e secondo lei mi si addice di più… Che nome strano Crilù, né da maschio né da femmina, non ha un colore, non ha un’identità”. – Delia è la “madre altra”, colei che ascolta, accoglie e legittima – “Fai tutto ciò che ti renderà felice… anche le cose più leggere e divertenti possono essere cose serie”. Incarna la libertà possibile, quella che si sceglie. E Ischia diventa il luogo dove la diversità non è più peso ma promessa.
Se l’infanzia è la stagione del dolore, Bologna è quella della trasformazione – “Bologna mi attende con i suoi locali pieni di studenti… da oggi è la mia nuova casa” – . La città è descritta come un organismo vivo, aperto, in fermento. Crilù la raggiunge su esortazione della zia: “Lì non c’è futuro per quelli come noi. Devi costruire la tua strada adesso.” Il Cassero, centro LGBTQ+ e rifugio comunitario, diventa una nuova famiglia. Lì incontra personaggi complessi, dolenti, combattivi: Yu, Vanessa, Terry, Virgilio, Lorenzo. Figure reali e simboliche che insegnano come resistere insieme sia diverso dal sopravvivere soli.
Ma nemmeno Bologna è un Eden: c’è un’aggressione al Cassero, un pestaggio brutale, un’eco di odio che sembra non estinguersi. Eppure, la risposta della comunità è collettiva, forte: si fonda una linea amica, si trasformano manifesti omofobi in arte, si continua a cantare. Anche quando fa male.
Nel cuore del romanzo pulsa il rapporto tra identità di genere e visibilità. Il momento della transizione – preparato dal progetto Radio Stelle e culminato nel concorso televisivo Fantastica Italiana – è narrato con coraggio e verità. Crilù è un personaggio che non chiede permesso: “Sono ancora un ragazzo, ma diventerò Crilù al 100% tra non molto.” È un gesto politico, poetico e pubblico.
Non è un semplice romanzo di formazione, quello raccontato in Siamo stelle che brillano. È un bildungsroman, sì, ma anomalo, deviante, coraggiosamente fuori traiettoria. Lo è perché al centro non c’è un percorso di adattamento, ma di trasformazione radicale. Crilù non si piega al mondo: si riscrive, si ridefinisce, si reinventa. Lo è perché l’identità in gioco non è solo psicologica, ma corporea, simbolica, di genere. La metamorfosi non è metafora: è reale. Lo è perché la famiglia non è quella d’origine, ma quella trovata e scelta. E perché la ferita dell’infanzia non si rimargina: si sublima nell’arte, nella voce, nella visibilità.
In questo senso, Siamo stelle che brillano riscrive la tradizione del romanzo di formazione dal punto di vista di chi, per troppo tempo, è stato escluso dalla narrazione centrale. È un racconto che si forma nel buio, ma che non chiede permesso per brillare.
Il linguaggio è diretto, spesso ruvido, ma mai compiaciuto: la voce narrante è quella di chi ha vissuto e vuole raccontare non per esibirsi, ma per resistere. C’è una struttura episodica, certo, e la forma ricalca a tratti quella dei memoir. Ma il risultato è letterario. I personaggi hanno carne, sangue, e futuro.
Siamo stelle che brillano non è solo la storia di Crilù. È la storia di chiunque sia stato escluso, umiliato, invisibile. È un romanzo sull’amicizia, sulla comunità, sulla possibilità concreta di trasformare il dolore in luce. È letteratura come atto di giustizia simbolica. E come suggerisce il titolo stesso, e come l’esperienza di Schisano conferma, ognuno di noi possiede dentro di sé una luce unica: basta il coraggio di attraversare la notte per scoprire che siamo stelle che brillano.
“Nel cielo le stelle brillano e io finalmente adesso mi sento come una di loro.”
L'articolo “Siamo stelle che brillano”. La stella sotto le coperte proviene da Globalist.it.