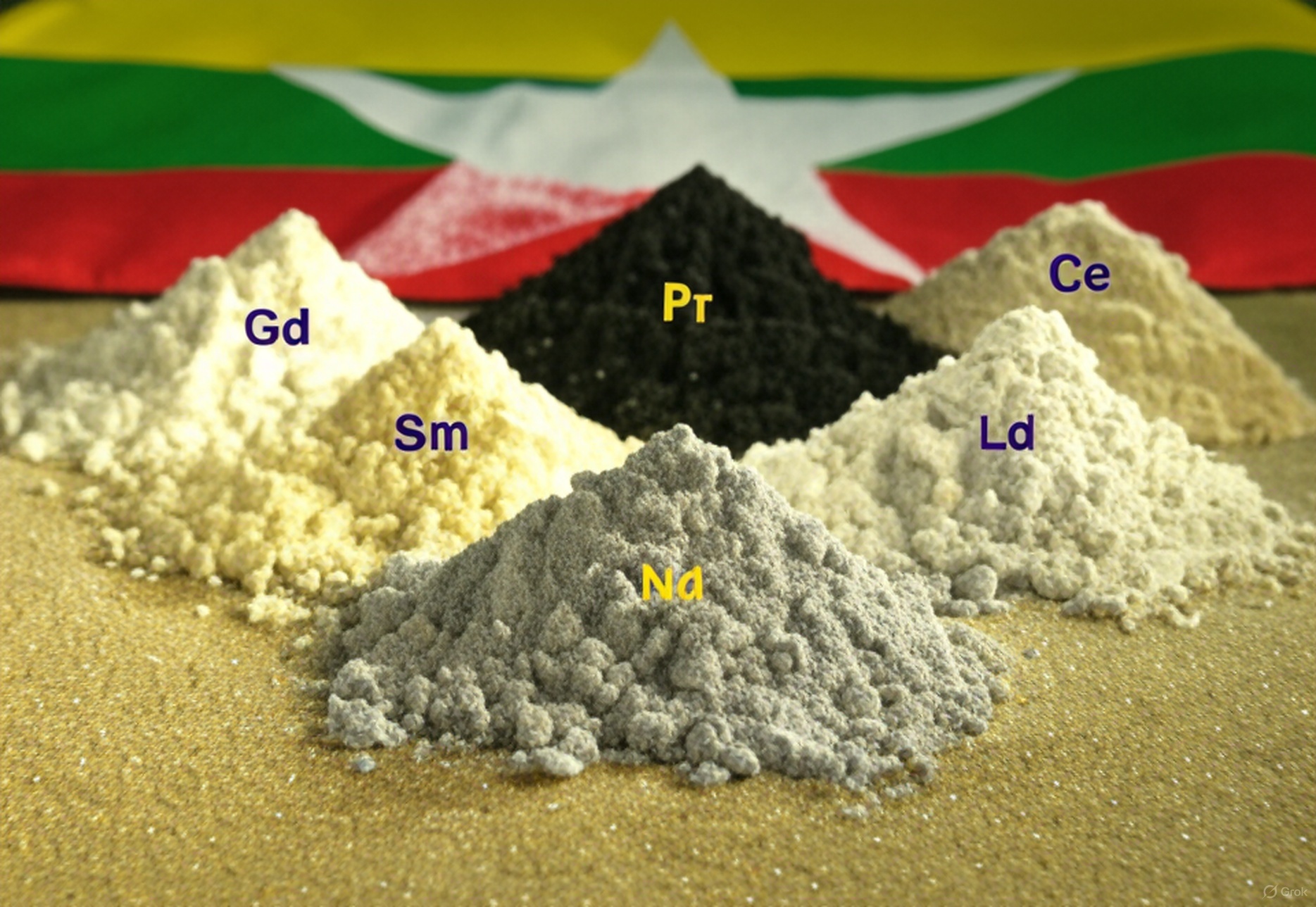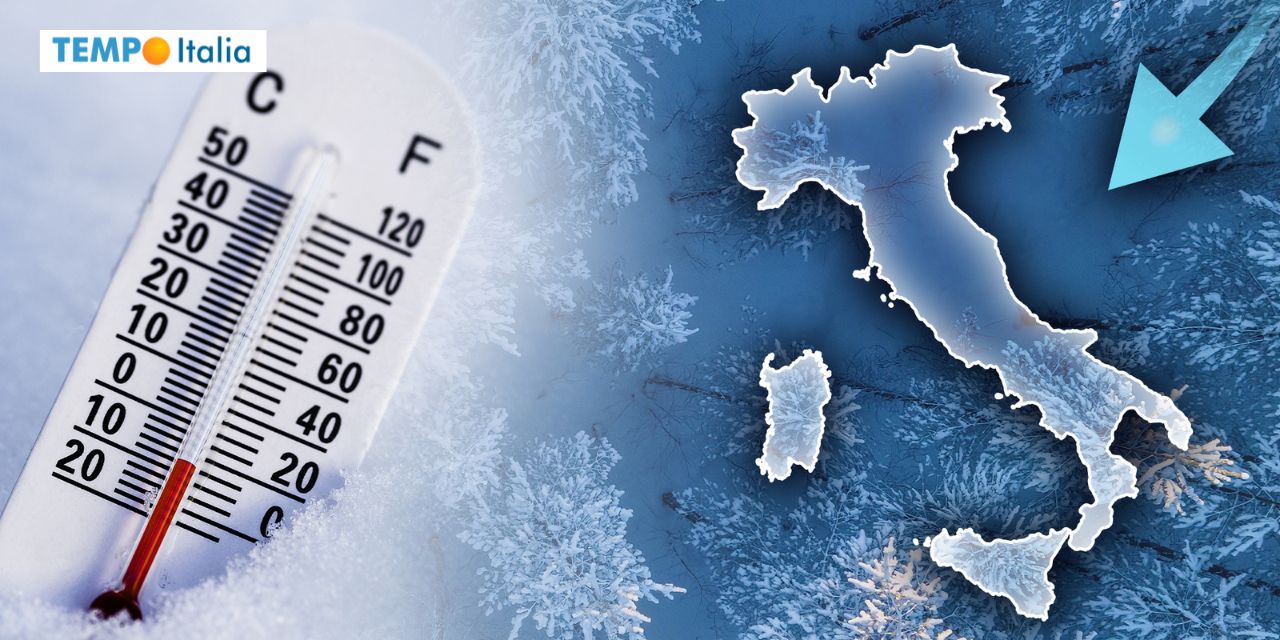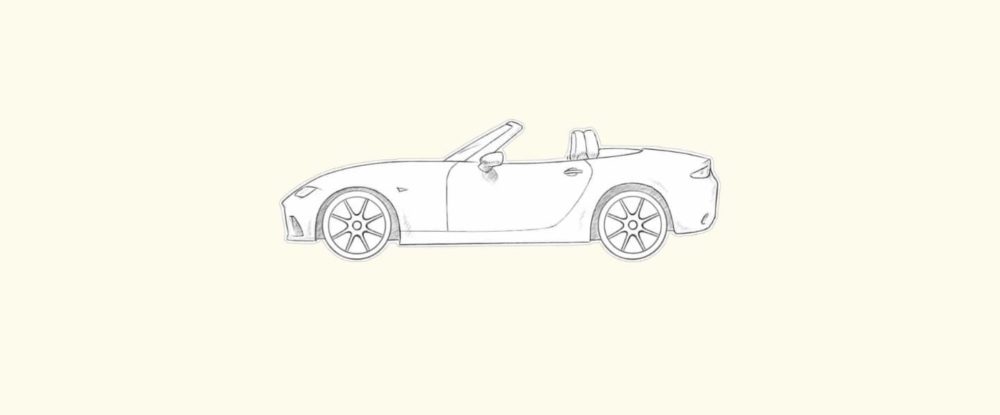“ReArm Europe”: la difesa come progetto politico, non solo militare
In un’epoca segnata da guerre ibride e crisi della verità, l’Europa si trova al centro di un confronto esistenziale che va ben oltre le armi e i bilanci della difesa. La minaccia rappresentata da Vladimir Putin — e da altri autocrati come Xi Jinping — non si manifesta solo sui campi di battaglia, ma si […] L'articolo “ReArm Europe”: la difesa come progetto politico, non solo militare proviene da Economy Magazine.

In un’epoca segnata da guerre ibride e crisi della verità, l’Europa si trova al centro di un confronto esistenziale che va ben oltre le armi e i bilanci della difesa. La minaccia rappresentata da Vladimir Putin — e da altri autocrati come Xi Jinping — non si manifesta solo sui campi di battaglia, ma si insinua nei meccanismi delle nostre democrazie, sfruttandone le crepe e le debolezze.
L’ex segretaria di Stato americana Madeleine Albright, con la sua lucida visione del totalitarismo, ci ricorda che la fiducia cieca nella solidità delle istituzioni democratiche può diventare un punto debole: la libertà si perde nell’inerzia quotidiana. E mentre noi ci adagiamo in questa apparente stabilità, i regimi autoritari ci studiano, avanzano.
Putin non vuole semplicemente annettere territori: vuole riscrivere l’ordine mondiale, affermare una zona d’influenza russa a ovest, sradicare i valori democratici europei e dimostrare che le democrazie sono deboli, divise, manipolabili. Lo fa con la guerra in Ucraina, ma anche con il finanziamento di movimenti estremisti, la disinformazione digitale, gli attacchi cibernetici, la cooptazione di leader sovranisti e l’intossicazione del dibattito pubblico.
Per citare un esempio recente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante un discorso tenuto a Marsiglia il 5 febbraio 2025, aveva paragonato l’invasione russa dell’Ucraina alle “guerre di conquista” della Germania nazista, affermando che “l’aggressione russa contro l’Europa è di questa natura”. Questa condivisibilissima considerazione, non solo ha suscitato scomposte reazioni da parte del Cremlino, ma, soprattutto, una serie di attacchi DDoS (che mirano a rendere un sito o servizio online inutilizzabile inondandolo di traffico di dati inutili) contro diversi siti web governativi italiani, tra cui quelli dei Ministeri della difesa, dell’interno e dei trasporti, nonché di alcune forze dell’ordine, da parte del gruppo di hacker filorusso NoName057.
Eppure, già nel giugno 2024, durante una visita ufficiale in Moldavia, il Presidente della Repubblica aveva denunciato una “diffusa tempesta di fake news” in Italia attribuibile alla disinformazione russa, sottolineando la necessità di affrontare tale fenomeno a livello europeo e nell’ambito della NATO.
Putin ha un’ossessione: evitare alla Russia la fine dell’Urss ed entrare nella storia come “il grande raccoglitore delle terre russe”. E vuole farlo, sul piano territoriale, recuperando quanto possibile dell’ex spazio sovietico (a cominciare dall’intera Bielorussia e da gran parte dell’Ucraina) e, sul piano identitario, sostenendo la continuità della propria missione con quella millenaria dello zarismo che vedeva nella Russia la “Terza Roma”. Non a caso Putin disprezza Karl Marx, che ritiene ebreo renano visceralmente russofobo ed è convinto che Lenin sia stato un “virus” iniettato dal Kaiser di Germania nel corpo russo (in questo concordando con Churchill). Putin, dell’esperienza sovietica, apprezza solo la estensione territoriale, la politica di potenza ed il prestigio internazionale.
Perciò, l’invasione dell’Ucraina non ha il solo scopo di ricondurre all’ordine un Paese ribelle (oltretutto, per Putin l’Ucraina è “Piccola Russia”, proprietà dello zar, sorella minore, con la Bielorussia, di Madre Russia), bensì dimostrare all’occidente di essere in grado di modificare gli equilibri geo politici in Europa e farsene parte essenziale, anzi arbitro.
E dimostrare al potenziale alleato cinese che le autocrazie possono essere modelli vincenti in un mondo che ha abbandonato la cooperazione per la competizione.
Avrebbe potuto ottenere qualcosa di simile diplomaticamente? Certamente si: ma non sarebbe bastato. Occorreva una prova di potenza.
Per questo, Putin accetterà una tregua completa solo quando sarà sicuro di poter raggiungere quegli obiettivi.
Il caso rumeno è emblematico: un candidato oscuro, cresciuto a dismisura grazie ai social e a fondi di dubbia provenienza, con legami diretti con la Russia e un bodyguard ex Brigata Wagner. Fermarlo con decisione non è solo legittimo: è necessario. Ma in un clima avvelenato, anche la difesa della legalità viene presentata come “golpe” da opinionisti e politici occidentali simpatizzanti del Cremlino.
La guerra che Putin conduce contro l’Europa è quindi anche culturale e simbolica. E non è da solo. Le convergenze con i settori più radicali del trumpismo e con personaggi influenti come Elon Musk mostrano l’esistenza di un fronte trasversale, ostile all’Europa dei diritti e delle libertà. L’attacco non è frontale, ma subdolo. Mira a erodere la fiducia, distorcere la percezione, indebolire le istituzioni dall’interno.
L’Unione Europea risponde a queste sfide con il piano “ReArm Europe”, un’iniziativa da 800 miliardi di euro per potenziare la difesa comune. Il piano si articola in:
150 miliardi di prestiti per la difesa congiunta, concentrati su sistemi di difesa aerea e missilistica;
650 miliardi derivanti dalla sospensione del Patto di Stabilità, consentendo agli Stati membri di investire nella difesa senza che queste spese incidano sui parametri di deficit;
rimodulazione dei fondi europei, con una possibile riallocazione di risorse destinate alla coesione economica e sociale verso il settore della difesa;
coinvolgimento della Banca Europea per gli Investimenti, che dovrebbe finanziare l’industria della difesa con strumenti dedicati.
Il piano, inoltre, prevede la razionalizzazione come elemento chiave: più coordinamento, meno sprechi, più interoperabilità, con l’obiettivo finale di costruire una difesa europea credibile e sostenibile.
È una risposta adeguata? In questo contesto, parlare solo di riarmo è miope.
Anche il termine “ReArm Europe” può risultare fuorviante per tre motivi:
sottolinea il “riarmo”, non l’integrazione. Manca il richiamo esplicito a coesione, interoperabilità e strategia comune, che sono invece i veri nodi da affrontare;
rischia di alimentare diffidenza nell’opinione pubblica;
non comunica bene il progetto politico: se l’ambizione è una politica di difesa comune europea, allora il nome dovrebbe trasmettere visione, integrazione, autonomia. “ReArm Europe” invece trasmette solo la dimensione finanziaria (riarmo = soldi in armi), non quella strategica o istituzionale.
Il riarmo europeo può essere necessario ma non sufficiente: serve anche una presa di coscienza collettiva e una campagna di informazione per svelare la natura reale dell’attacco in corso, che non è una rivoluzione culturale, ma un’aggressione mascherata ai valori democratici.
Sgombriamo quindi il campo dall’ipotesi di possibili invasioni: Putin oggi non vuole e non può. Il vero pericolo è l’irrilevanza europea, a cominciare dai propri valori democratici.
Nel nuovo scenario geopolitico, con gli Stati Uniti (versione Trump) che si disimpegnano dagli affari internazionali, Putin mira a espandere la sua sfera d’influenza a Ovest per non restare schiacciato dalla Cina, da cui dipende tecnologicamente. La Russia, in questo ordine tripolare (Usa-Cina-Russia), rischia comunque di diventare il “vice manesco” della Cina, mentre l’Europa, se non agisce, rischia l’irrilevanza politica e strategica.
È vero che c’è un cambiamento nella politica di sicurezza americana. Già dai tempi di Obama, gli Stati Uniti hanno richiesto agli alleati europei un contributo maggiore alla propria sicurezza. La crescente sfida della Cina nel Pacifico ha spostato le priorità strategiche di Washington, rendendo meno sostenibile un impegno massiccio nella difesa europea. Con Donald Trump, la richiesta è diventata un vero e proprio ultimatum: gli USA non garantiranno più la sicurezza dell’Europa senza un coinvolgimento economico diretto dei partner europei.
Ma dietro questa posizione c’è anche una problematica economica: il debito pubblico americano è cresciuto a livelli tali da richiedere una quota eccessiva del risparmio mondiale per essere rifinanziato.
Gli Stati Uniti, infatti, stanno incontrando crescenti difficoltà nel rifinanziare il proprio debito pubblico, che ha ormai superato il 124% del PIL. Il volume del debito, unito all’aumento dei tassi di interesse, sta facendo lievitare il costo del servizio del debito, rendendo sempre più oneroso attrarre investitori.
Tradizionalmente, gli USA potevano contare sul risparmio mondiale per collocare i propri titoli del Tesoro. Oggi, però, la domanda internazionale è in calo: Cina e Giappone stanno riducendo i propri acquisti e la competizione globale per il risparmio si è intensificata. In un contesto in cui anche l’Europa e altri Stati cercano capitali per finanziare il debito e le proprie priorità strategiche, gli Stati Uniti non possono più assorbire da soli la maggior parte del risparmio globale senza aumentare drasticamente i rendimenti.
Questa situazione contribuisce a spiegare perché Washington insista sempre più sul fatto che l’Europa debba investire in modo autonomo nella propria sicurezza, riducendo la dipendenza dal supporto americano.
Sì, serve una maggiore capacità difensiva europea. Ma non è sufficiente. Serve uno “scudo democratico” fatto di consapevolezza civica, trasparenza, resilienza istituzionale. Serve una potente campagna di informazione che spieghi ai cittadini che cosa è davvero in gioco: non solo l’Ucraina, ma il futuro della libertà in Europa.
L’Europa non rischia l’invasione fisica, ma la marginalizzazione politica e culturale. Se non agisce, finirà schiacciata in un mondo tripolare dominato da Stati Uniti, Cina e Russia.
In questo scenario, l’unica risposta possibile è affermare l’Europa come soggetto politico globale, capace di autodifesa, ma anche di proposta. Capace di rispondere alla forza con la forza, ma anche all’inganno con la verità, alla propaganda con la cultura, al cinismo con la memoria dei propri valori fondativi.
Perché — come ci ricordava Popper — difendere una società tollerante richiede, talvolta, l’intolleranza verso gli intolleranti. Ma sempre e soprattutto, richiede coraggio, lucidità e visione.
Se tutto questo è vero e se “La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi” (“Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln”), massima di Carl von Clausewitz, generale e teorico militare prussiano del XIX secolo, allora la risposta di oggi dev’essere una risposta “politica” che si chiama “difesa europea” e presuppone due elementi:
una politica estera comune;
un’integrazione politica più profonda, perché la difesa comune impone una maggiore cessione di sovranità (a partire da una catena di comando sovranazionale).
Sono dinamiche difficili, di lungo periodo, ma inevitabili: il cammino “federale” va ripreso.
“ReArm Europe”, allora, può essere accettabile solo come primo passo in questa direzione, ma corretto di svariate incoerenze con tale obiettivo.
Anzitutto, per funzionare il piano dev’essere governato politicamente e sostenuto dagli Stati membri, superando resistenze nazionali e frammentazioni industriali.
Spese attuali della difesa UE. L’Europa spende ogni anno circa 312 miliardi di euro per la difesa:
di questi, 70-80 miliardi sono destinati direttamente agli armamenti;
di questi, 50 miliardi vengono spesi per armamenti americani, segno della dipendenza dall’industria USA.
Gli Stati Uniti, in confronto, spendono 877 miliardi di dollari annui per la difesa, circa il 3,45% del PIL.
Criticità e interrogativi sollevati. L’allocazione di 800 miliardi di euro non garantisce automaticamente la costruzione di una politica di difesa comune. Senza una strategia condivisa, l’aumento delle spese rischia di tradursi in duplicazioni, inefficienze e sprechi. La semplice creazione di fondi o lo stimolo al procurement militare coordinato non bastano a costituire una “difesa europea”.
Occorre un chiaro indirizzo politico: definizione delle missioni, ripartizione dei compiti tra le forze armate, interoperabilità, priorità strategiche, coordinamento con la NATO. La mancanza di chiarezza su questi aspetti rischia di minare alla base l’efficacia del piano.
Coordinamento UE-NATO e autonomia strategica. La sovrapposizione tra molti Stati membri dell’UE e della NATO crea potenziali conflitti di competenza. È essenziale chiarire come i fondi e le capacità verranno ripartiti, per evitare una duplicazione delle strutture di comando e di spesa. La proposta di Mario Draghi di istituire una catena di comando sovranazionale mira proprio a superare queste criticità.
L’illusione di una difesa comune senza debito comune. Un punto critico del piano riguarda il finanziamento: senza l’emissione di titoli di debito comune europeo, il progetto rischia di non essere sostenibile. Nessun bilancio nazionale europeo, infatti, è in grado di sostenere una spesa così elevata senza impatti sulle finanze pubbliche.
L’idea di finanziare la difesa utilizzando fondi di coesione europea (es. per il Sud Italia) è problematica perché sottrarrebbe risorse a settori già sottofinanziati come sanità, istruzione, welfare sociale. La BEI, che finora non ha mai finanziato spese militari, potrebbe entrare nel processo, ma modificando i limiti attuali, per i quali le spese ammissibili devono essere “dual use” ed avere per almeno il 60% impiego civile.
Il debito condiviso consentirebbe non solo di distribuire equamente i costi, ma anche di condizionare il finanziamento all’adozione di programmi comuni, evitando sprechi e duplicazioni tra i singoli Stati: un coordinamento “dal basso”, basato sull’autodisciplina dei singoli Paesi, non pare credibile.
Impatto economico-industriale e mercato della difesa. La crescita della spesa militare può rappresentare un’opportunità per l’industria europea della difesa. Tuttavia, l’attuale frammentazione dell’apparato industriale rischia di vanificare questi sforzi. Senza un vero “mercato unico della difesa”, senza l’aggregazione della domanda, la standardizzazione e la promozione di un mercato integrato sono condizioni imprescindibili per massimizzare l’efficienza degli investimenti.
Questo presuppone il coordinamento delle aziende della difesa a livello dei singoli Stati ed a livello UE. Senza strutture centrali od una attribuzione di fondi condizionata agli obiettivi, come detto, la razionalizzazione delle spese per la difesa pare poco credibile. Ma anche per valorizzare le ricadute dell’industria militare sul settore civile. Aspetto che tratteremo di seguito.
Opinione pubblica e sostenibilità sociale. Recenti manifestazioni in Italia e in altri Paesi UE mostrano come parte dell’opinione pubblica sia critica verso un riarmo europeo massiccio, temendo ripercussioni su welfare e indebitamento pubblico. La legittimità democratica del progetto dipenderà dalla capacità dell’UE di comunicare l’utilità strategica di queste spese e di garantirne la sostenibilità sociale.
L’integrazione dell’industria militare europea: un processo necessario. L’industria della difesa europea soffre di un’eccessiva frammentazione:
l’UE ha in uso 12 modelli diversi di carri armati da battaglia (Main Battle Tanks – MBT);
gli USA impiegano 1 solo modello principale: l’M1 “Abrams”;
l’UE ha 17 tipi di fregate, 29 tipi di veicoli blindati, 20 modelli diversi di caccia;
gli USA producono 1 tipo di fregata, 6 tipi di veicoli blindati e 4 caccia da combattimento.
Questo determina manutenzione frammentata, difficoltà nei pezzi di ricambio, addestramento più costoso.
Riprendendo il tema della razionalizzazione della spesa, non si tratta solo di spendere di più, ma di spendere meglio, attraverso:
riduzione delle duplicazioni tra eserciti nazionali;
acquisti congiunti e coordinati (procurement comune);
standardizzazione dei sistemi d’arma (meno modelli diversi, più interoperabilità);
rafforzamento del mercato unico della difesa, per aumentare efficienza e competitività dell’industria europea;
integrazione logistica e catene di approvvigionamento condivise;
riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti che resta elevata.
Per risolvere queste criticità, l’UE deve:
aggregare la domanda militare, attraverso un’acquisizione congiunta;
standardizzare logistica e interoperabilità;
sostenere un’industria competitiva, investendo in tecnologie avanzate, che hanno una ricaduta notevole anche sull’industria civile.
È chiaro che senza un progetto politico tutto questo appare aleatorio.
Il problema dei programmi spaziali europei. Uno degli aspetti più critici della sicurezza tecnologica europea riguarda i programmi spaziali. Attualmente, l’Europa non dispone di un sistema autonomo di posizionamento satellitare efficace quanto il GPS americano o il Beidou cinese. Galileo, Copernicus, IRIS e Secure Connectivity sono ancora in fase di consolidamento.
L’assenza di un sistema satellitare europeo pienamente operativo lascia l’UE vulnerabile alla dipendenza dagli USA per navigazione e comunicazione militare. Ma non si tratta solo di autonomia: le tecnologie spaziali sono oggi una componente strategica essenziale per la superiorità nella difesa, probabilmente persino più determinante della supremazia aerea o terrestre. Chi controlla lo spazio controlla l’informazione, la logistica, la capacità di comando e di reazione. Rafforzare lo spazio europeo significa, dunque, non solo ridurre una dipendenza, ma dotarsi degli strumenti fondamentali per operare in scenari ad alta complessità, dove l’infrastruttura orbitale è ormai parte integrante del teatro operativo. Rafforzare lo spazio europeo è condizione necessaria per una vera autonomia strategica.
La competizione per la tecnologia: l’Europa non può più permettersi di rincorrere. In un’epoca segnata da un’accelerazione tecnologica senza precedenti, l’Europa si trova ad affrontare una sfida esistenziale: non restare indietro sulle cosiddette tecnologie “dirompenti”. Si tratta di ambiti come il Cloud computing, l’intelligenza artificiale, i computer quantistici e i sistemi cyber-fisici per l’industria — tecnologie che non solo plasmeranno l’economia del futuro, ma che saranno centrali anche per la difesa e la sicurezza del continente.
Il progetto ReArm Europe va corretto anche per essere il catalizzatore di una consapevolezza più ampia: senza un’infrastruttura comune, senza una rete europea di ricerca, sviluppo e produzione, l’Europa rischia di restare vassali in un mondo dove la leadership si gioca sull’autonomia tecnologica.
Un esempio lampante di questa fragilità strutturale è la cybersicurezza. Lungi dall’essere un semplice “scudo” per difendere i dati e il know-how strategico, la sicurezza cibernetica è oggi un vero e proprio fattore abilitante. Nessun sistema basato su AI, nessun ambiente industriale connesso, nessun servizio pubblico digitalizzato può funzionare senza una base solida di sicurezza informatica.
La crescita costante degli attacchi cibernetici segnala una nuova guerra ibrida, dove la vulnerabilità digitale equivale alla vulnerabilità strategica.
Se l’Europa vuole davvero una difesa comune, deve farlo anche sul fronte digitale. Serve un progetto comune, serve una politica industriale e scientifica integrata, che unisca le eccellenze nazionali in una strategia continentale. Non solo per sviluppare tecnologie proprietarie, ma per assicurare la resilienza, l’autonomia e l’affidabilità dei sistemi che ne derivano.
Difesa, economia, industria, ricerca, cyberspazio: sono ambiti che ormai non possono più essere trattati separatamente. La partita delle tecnologie dirompenti si gioca oggi. E l’Europa non può permettersi di perderla.
Con una avvertenza fondamentale: non si cresce più “per imitazione” (di chi è più efficiente). O si dispone di quelle tecnologie o si è marginalizzati.
Difesa e innovazione: la ricaduta possibile sull’industria civile richiede visione politica. Alla luce di quanto sinora esposto, possiamo svolgere un’ulteriore considerazione che condiziona la visione attuale di ReArm Europe. Gli investimenti nell’industria della difesa sono spesso valutati esclusivamente in termini strategico-militari o di bilancio pubblico. Tuttavia, esiste un’altra dimensione – meno visibile ma fondamentale per l’economia – che riguarda le ricadute potenziali sull’industria civile. Perché queste ricadute si realizzino in modo efficace e sostenibile, è però indispensabile una forte direzione politica.
Il caso di tecnologie oggi onnipresenti nella vita quotidiana – dal GPS a Internet – dimostra come le innovazioni nate in ambito militare possano trasformarsi in strumenti centrali per la competitività industriale e l’efficienza dei servizi. Si tratta del fenomeno del “dual use”, ovvero l’uso duale delle tecnologie, che dai laboratori della difesa possono approdare nei mercati civili, generando valore economico e progresso tecnologico.
Il potenziale di spillover è elevato: i programmi militari spingono la ricerca in settori ad alta intensità di innovazione – materiali avanzati, intelligenza artificiale, robotica, cybersicurezza – creando conoscenze e capacità industriali che possono poi essere riutilizzate anche in ambito civile. Le industrie che lavorano per la difesa formano capitale umano altamente qualificato e attivano filiere tecnologiche che, se guidate da politiche industriali lungimiranti, possono contribuire alla competitività del sistema-Paese.
Tuttavia, questi effetti non sono automatici. Perché si producano, serve una governance pubblica capace di indirizzare gli investimenti, promuovere il trasferimento tecnologico, sostenere la collaborazione tra settore difesa, mondo accademico e imprese civili. In mancanza di una regia strategica, si rischia che gli investimenti si esauriscano nella logica della commessa pubblica, senza generare un impatto duraturo sul tessuto industriale nazionale.
Il tema, una volta in più, non è dunque “difesa sì o no”, ma “quale politica per la difesa”. Una politica industriale moderna, in grado di cogliere le potenzialità duali di ogni innovazione e di costruire ponti tra ricerca militare e mercato civile. In questo senso, la difesa può diventare non solo un capitolo di spesa, ma uno strumento di sviluppo.
Oltre la difesa: il futuro dell’Unione Europea. Il piano “Rearm Europe” sembra ambizioso ma poco realistico.
Ma per essere davvero credibile e coerente con l’ambizione di una difesa europea comune, ReArm Europe deve poggiare sin da subito su tre pilastri essenziali, come suggerito da Mario Draghi:
un debito comune europeo, che garantisca una base finanziaria condivisa e solidale;
la selezione strategica dei programmi che portino realmente verso una capacità difensiva integrata, evitando sprechi e duplicazioni, quale condizione per l’accesso ai finanziamenti;
comandi militari europei unificati, perché nessuna difesa comune è possibile senza una catena di comando sovranazionale.
Sono tre mosse iniziali, ma imprescindibili. E non sono tecnicismi: rappresentano il primo passo di un disegno più ampio, quello della ripresa del cammino verso l’integrazione europea, a partire da una vera politica estera comune.
Solo in questo quadro la difesa potrà diventare non un fine, ma lo strumento di una sovranità europea condivisa, credibile e democratica.
Ricordiamo allora il pensiero di Alcide De Gasperi che, nel contesto dell’integrazione europea, rappresenta un riferimento ancora attuale. Profondamente convinto che l’unità dell’Europa fosse la sola garanzia contro il ritorno dei nazionalismi e delle guerre, De Gasperi fu tra i promotori della Comunità Europea di Difesa (CED). Per lui, la difesa comune non era solo una questione militare, ma il fondamento stesso di un’Europa politica, capace di esprimere autonomia strategica e coesione democratica.
La CED avrebbe dovuto rappresentare il nucleo embrionale di un esercito europeo sotto il controllo di istituzioni sovranazionali. La sua mancata approvazione da parte dell’Assemblea nazionale francese nel 1954 fu vissuta da De Gasperi come un arretramento drammatico del processo d’integrazione. Tuttavia, il suo pensiero resta un monito e una guida: ogni progetto di difesa comune, come ReArm Europe, può avere senso solo se inserito in un disegno politico più ampio, orientato all’unità europea, alla solidarietà e alla difesa dei valori democratici che ne sono il fondamento.
Il percorso verso una vera unione politica ed una difesa comune è ancora lungo ma va ripreso. ReArm, rivisto e corretto, può essere solo un piccolo, seppur parziale, passo avanti.
L'articolo “ReArm Europe”: la difesa come progetto politico, non solo militare proviene da Economy Magazine.