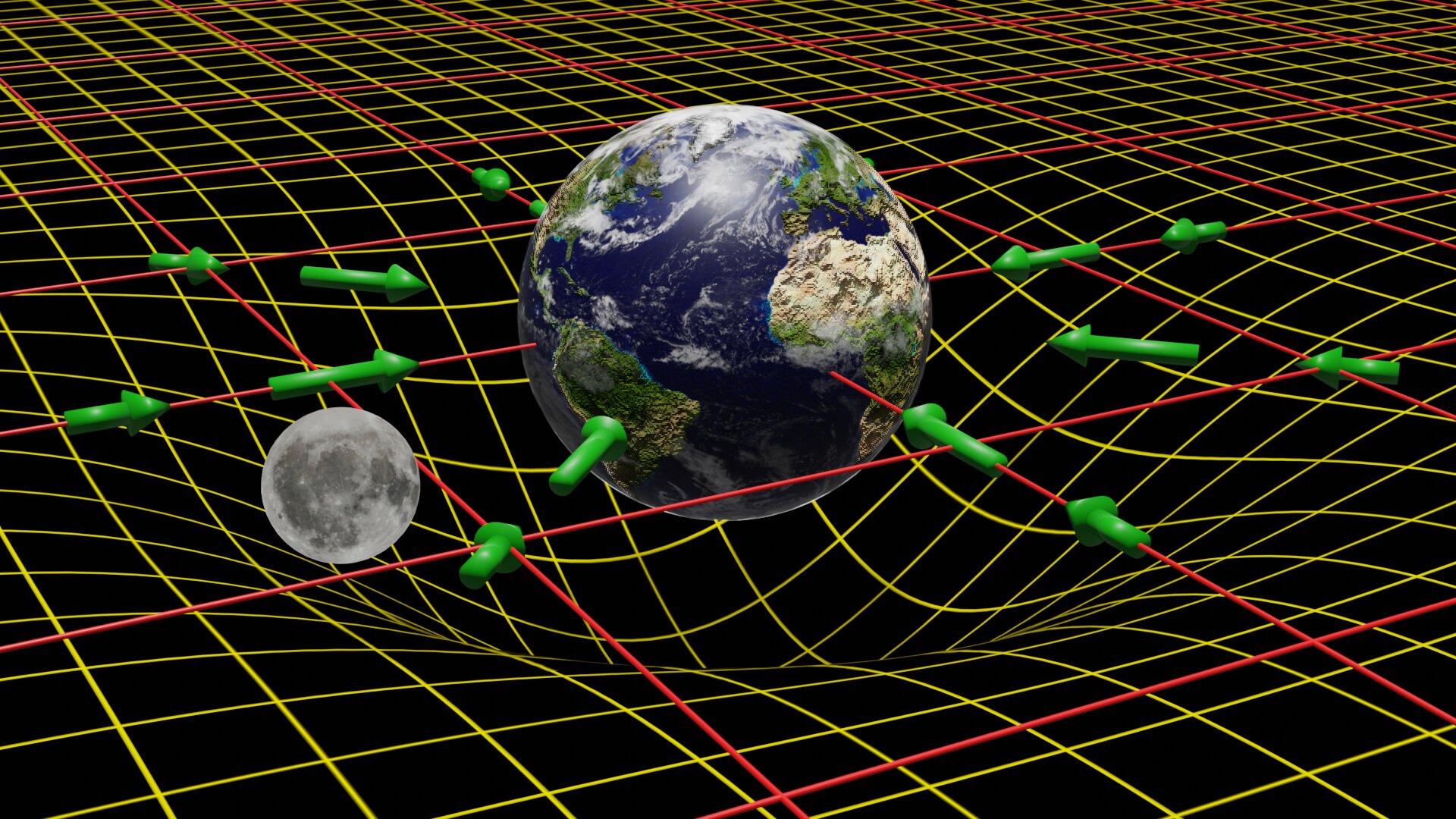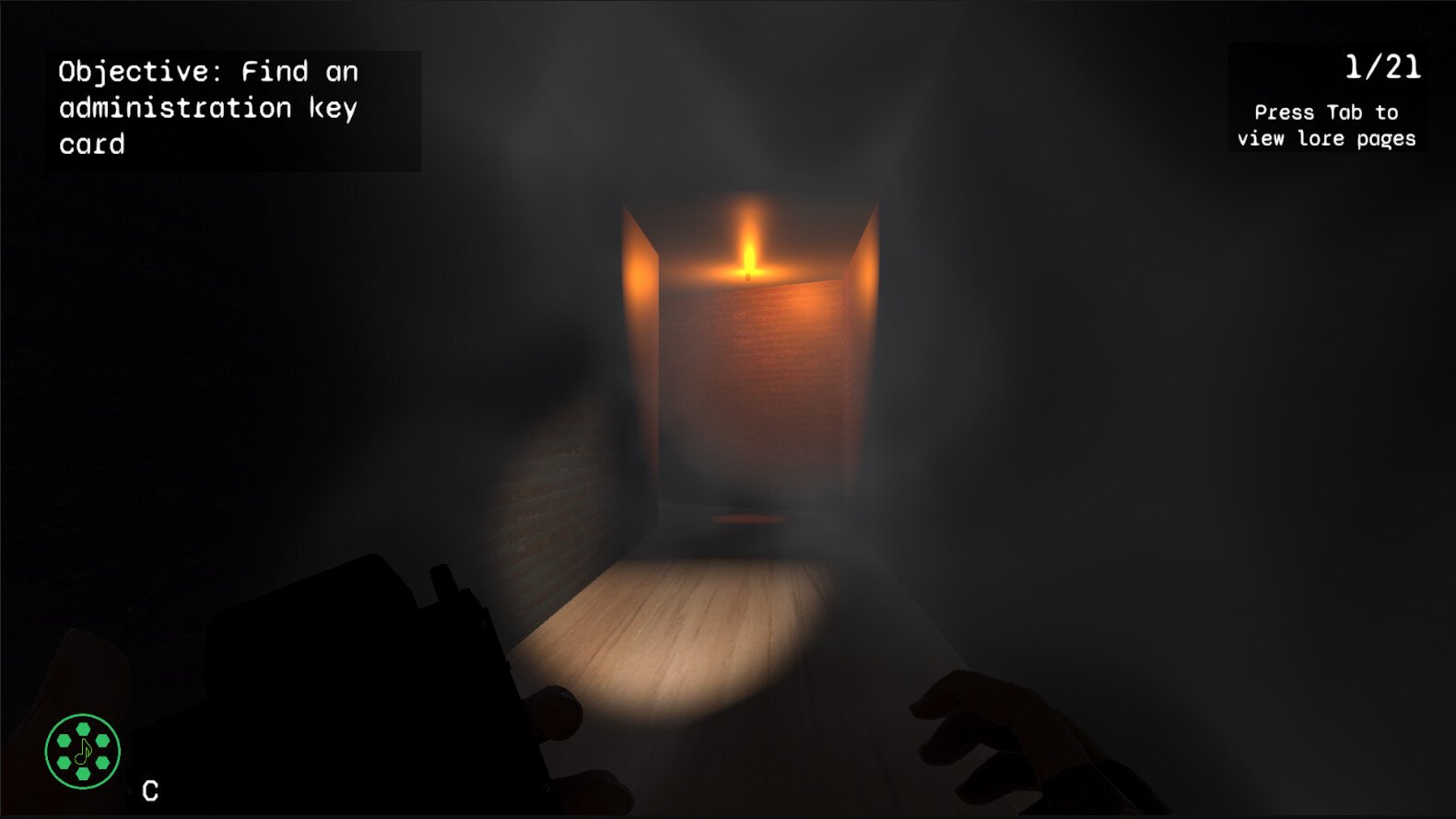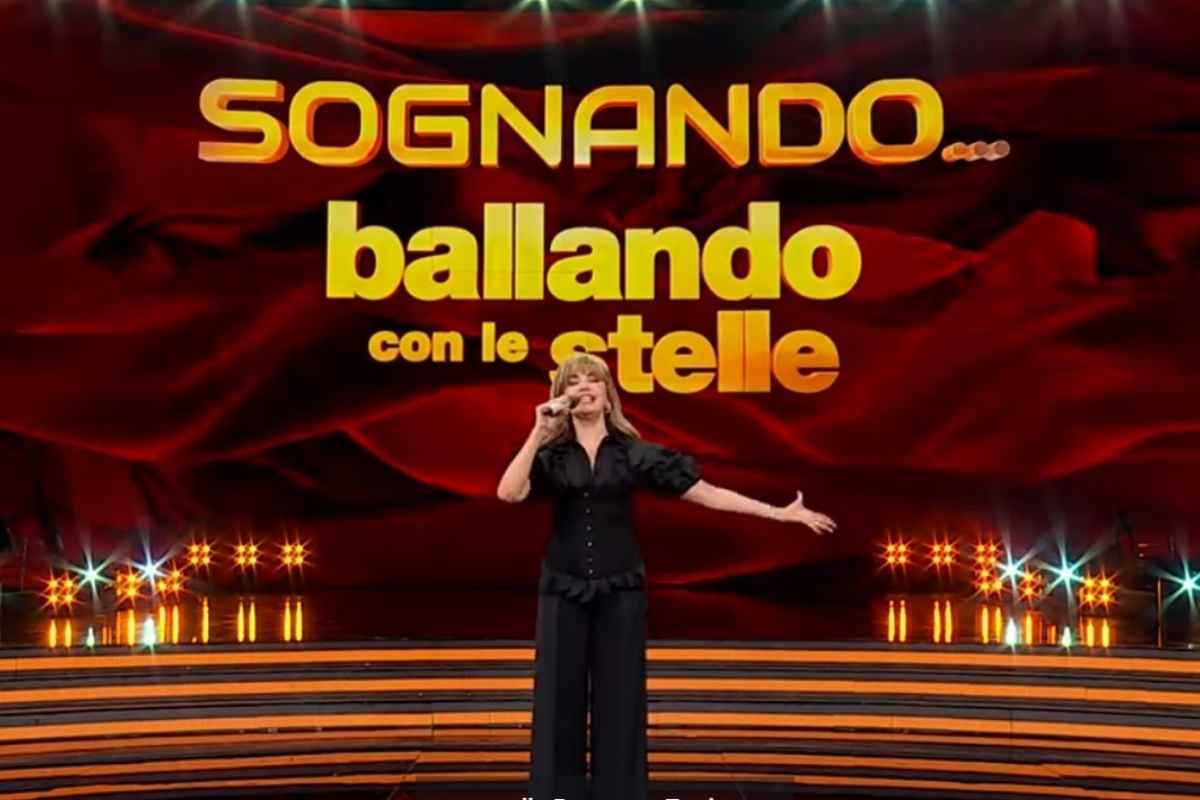Quando la critica d’arte si trasforma in guerra di religione: due amici divisi da un solo quadro
Ne L’Abisso di San Sebastiano, Mark Haber racconta l’ascesa e la rottura di due critici uniti da un capolavoro ossessivo. L'articolo Quando la critica d’arte si trasforma in guerra di religione: due amici divisi da un solo quadro proviene da Globalist.it.

di Rock Reynols
Provate a immaginare due critici d’arte di gran fama, due personalità forti – come si confà al ruolo – che, dopo essere andati d’amore e d’accordo o quasi per una vita, pur tra dichiarazioni roboanti e prese di posizione divisive, improvvisamente si ritrovano completamente antitetici, in aperta polemica l’uno con l’altro. Insomma, dalla parte opposta della barricata del pensiero critico, arroccati su contrafforti ideologici incrollabili, pronti a duelli rusticani all’insegna di un dogmatismo assoluto, seppur – a loro dire, s’intende – motivato da ragionamenti logicissimi o, viceversa, improntati all’irrazionalità pura. In fondo, sono in tanti a ritenere che la vera arte sia, sì, frutto di studio e osservazione, ma più ancora materia di insondabile provenienza, natura cosmica allo stato puro. No, non stavo pensando a Vittorio Sgarbi e ad Achille Bonito Oliva, anche se qualche vaga analogia la si potrebbe pure tracciare.
Per capire a chi mi sto riferendo basta leggere un interessante, davvero inusuale romanzo americano, un piccolo caso editoriale.
L’Abisso di San Sebastiano (Marcos y Marcos, traduzione di Marco Zapparoli, pagg 177, euro 17) è la seconda fatica di Mark Haber, per lungo tempo libraio, appassionato dei grandi classici della letteratura internazionale, lontanissimo dalle tematiche e dallo stile narrativo generalmente associati alla letteratura contemporanea a stelle e strisce.
Il tedesco Schmidt e il Narratore americano si incontrano, ancora giovani, a Oxford e, dove studiano l’arte pittorica del Secolo d’Oro olandese e si ritrovano sulla stessa lunghezza d’onda, ponendo le basi per un sodalizio che sembra a prova di bomba. A saldare quel legame quasi inscindibile, in quanto fondato su basi di elaborazione critica tale da elevarli decisamente al di sopra della media dei colleghi, è la quasi casuale scoperta di un piccolo quadro, L’Abisso di San Sebastiano, appunto, capolavoro del Rinascimento mitteleuropeo, che stravolge il concetto stesso dell’arte come l’umanità lo conosceva prima che l’opera di tale oscuro artista balzasse agli onori delle cronache.
Il conte Hugo Beckenbauer, gaudente, incline agli eccessi e malato di sesso – «quello che oggi definiremmo un erotomane», al punto che sarà stata proprio la sifilide a stroncarlo dopo immani sofferenze – è stato preda delle sue stesse pulsioni insopprimibili e pare aver concentrato la sua potenza descrittiva in quell’unico quadro, anche perché le altre sue due opere restanti, definite con disprezzo compiaciuto da Schmidt e dal Narratore, i dipinti delle scimmie – perché, secondo il giudizio tranchant di Schimdt, anche «una scimmia avrebbe potuto dipingerli» – gli fanno da contorno come i Ladroni accanto alla croce del Cristo, sul Golgota, in un trittico contraddittorio. Ed è proprio per la straordinaria espressività de L’Abisso di San Sebastiano che il resto dell’universo dell’arte, a partire da quei due ridicoli dipinti dello stesso artista, si fa piccolo. Quasi mai in una sola opera un essere umano è riuscito a concentrare il senso disperato della fine del mondo, l’angoscia di un male oscuro incombente come nel capolavoro di Beckenbauer, coevo di Pieter Bruegel il Vecchio. La sua figura è nota soprattutto nei bordelli presso cui, spesso squattrinato, è solito offrire qualche sua opera mediocre in cambio di un rapporto intimo, al punto che viene «da chiedersi se dipingesse per fare sesso o se fare sesso lo stimolasse a dar forma alle opere che si era prefigurato». Perché una di quelle opere, «capaci di turbare e deliziare allo stesso tempo», è proprio L’Abisso di San Sebastiano.
La profondità terrificante di tale dipinto ha il potere di rinchiudere i due critici in un baccello indistruttibile. Invitati a discettare di tale scoperta epocale in tutto il mondo, i due colleghi scrivono opere su opere al riguardo, inseguendosi in un continuum che li porta ai vertici di quel mondo accademico che disprezzano con gusto. In fondo, lo stesso conte Beckenbauer farebbe fatto beffe dei critici, come loro guardano con uno snobismo quasi ostentato certi colleghi che reputano platealmente inferiori. La vita stessa dei due amici pare avvitata intorno a discussioni interminabili sugli aspetti più insondabili di quel quadro e sul tema in esso espresso, la fine del mondo, una vera ossessione.
Eppure, anche le storie di amicizia più solide, più incrollabili, possono giungere a una fine inattesa. Il rapporto fra Schmidt e il Narratore si incrina per via di poche parole sfuggite inopinatamente di bocca all’americano nel corso di una tavola rotonda in patria, ovvero «che l’arte è un fatto soggettivo… in pratica che l’opinione di un profano è pari a quella di un esperto». Da questo momento in poi, anche fra Schmidt e il Narratore si apre un abisso, una voragine che l’americano tenterà se non di colmare, quantomeno di sondare per giungere a un minimo accomodamento, dato che Schmidt pare essere sul suo letto di morte.
Senza lesinare su commenti al vetriolo riguardo al mondo dell’arte e persino allo stato miserando della cultura negli USA, Haber costruisce una storia semplicissima che, però, riesce a catturare il lettore. Prese individualmente, certe frasi del libro rischiano di sembrare pensierini delle elementari quando, in realtà, sono il collante perfetto per una narrazione in bilico tra ironia e profondità. Come dice il Narratore, «essendo io nato e cresciuto negli Stati Uniti – inequivocabilmente una nazione di serie B, una società letargicamente infantile, una cultura da drive-in per bimbi balbettanti –, anche le mie opinioni non potevano che essere infantili».
Gli insaziabili appetiti sessuali di Beckenbauer sono la cartina di tornasole di una poetica non del tutto insolita nell’ambiente dell’arte, ma certo estremizzata, con il conte che se ne va in città dopo aver realizzato il suo capolavoro, spinto da un’insopprimibile desiderio di fornicazione e da insaziabili appetiti sessuali. Quasi una scena da commedia all’italiana.
Come talvolta succede nell’arte, un’opera nata dalla creatività contorta di una mente sfrenata contiene elementi che negano il divino al punto da renderlo necessario. In fondo, i due critici un tempo amici sono «atei convinti» e il loro non credere, come quello sferzato dalle pennellate di Beckenbauer, è «una forma superiore di fede».
C’è persino chi, nel mondo dei critici d’arte, non può fare a meno di trattenersi dallo schierarsi con questo o con quello dei due ex-amici, ora contendenti. Sono i perfetti idioti che non possono mancare.
Nel complesso, un romanzo divertente, certamente non convenzionale, a tratti spassoso.
L'articolo Quando la critica d’arte si trasforma in guerra di religione: due amici divisi da un solo quadro proviene da Globalist.it.