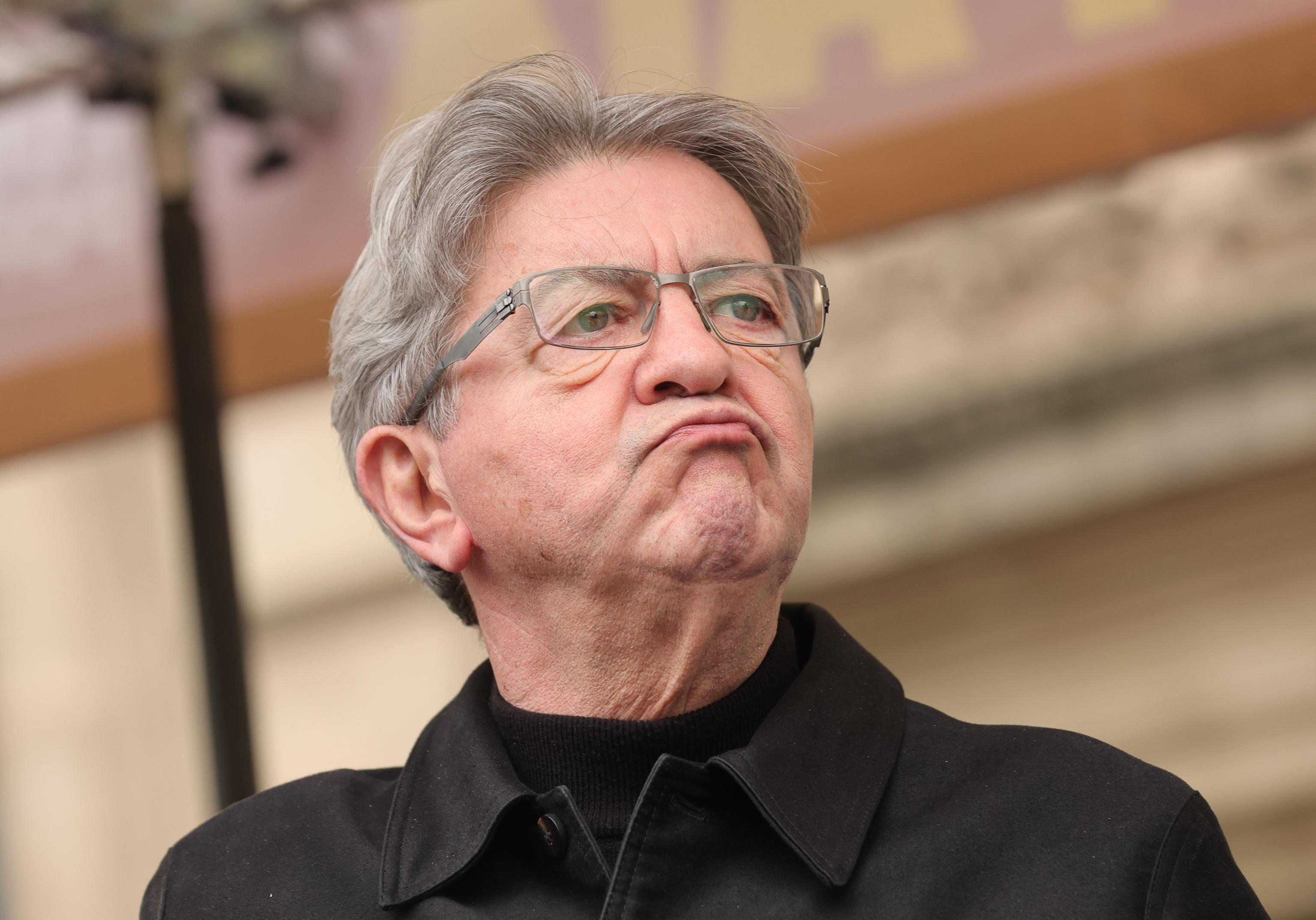Smart Cities, siamo sicuri che i Comuni siano connessi? E quanto vale il mercato? Report PoliMi
Secondo il Politecnico di Milano, le aree principali di investimento sono l’Illuminazione pubblica e la mobilità intelligente, ma tra le iniziative più diffuse, con investimenti minori, ci sono anche progetti di sicurezza e sorveglianza e le comunità energetiche rinnovabili

Nel 2024, il mercato italiano delle Smart City ha raggiunto 1,05 miliardi di euro, con una crescita del +5%, inferiore alla media europea (+9%). Le aree principali di investimento sono l’Illuminazione pubblica (circa 240 milioni di euro, 23% del totale) e la mobilità intelligente (circa 215 milioni di euro, 20% del totale), ma tra le iniziative più diffuse, con investimenti minori, ci sono anche progetti di sicurezza e sorveglianza (adottati dal 27% dei comuni nel biennio 2023-24) e Comunità Energetiche Rinnovabili (sempre 27%). Sono alcuni risultati della ricerca dell’Osservatorio Smart City del Politecnico di Milano.
Leggi anche: Quando anche i robot si ribellano. Ecco il video che ha fatto il giro del mondo
A che punto siamo in Italia?
Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, le smart city stanno diventando imprescindibili nelle agende delle amministrazioni locali italiane: il 42% dei comuni ha avviato progetti nel 2024 e il 91% vuole farlo nei prossimi due anni. E si stanno affermando come opportunità concreta per coniugare tecnologia e sostenibilità, utilizzando l’innovazione per perseguire obiettivi ambientali, economici e sociali.
Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, metà degli italiani valuta il comune di residenza “insufficiente” sotto il profilo dell’inclusività, dell’accessibilità dei servizi pubblici offerti e del dinamismo economico-sociale. Da un punto di vista della sostenibilità economica, si stanno identificando progetti in grado di trovare un connubio tra sostenibilità e innovazione: più di un comune italiano su tre (37%) ritiene le partnership tra pubblico e privato (PPP) molto utili per realizzare progetti Smart City, ma ad ora sono adottate solo da meno di un comune su 6 (16%).
L’intelligenza artificiale è conosciuta dal 92% dei cittadini, che è favorevole al suo uso in città per la sicurezza pubblica, il monitoraggio delle emergenze e la gestione dei guasti alle infrastrutture. Ma ad oggi solo il 4% dei Comuni adotta l’AI nei progetti smart, mentre il 35% la vuole sfruttare entro 2 anni. La principale barriera ai progetti Smart City è la carenza di personale, per il 71% dei comuni italiani, e quindi anche di competenze interne, soprattutto per gestire l’innovazione e per coinvolgere la cittadinanza.
Che ruolo giocano le Smart Cities?
La Smart Cities sono fondamentali in diversi settori come quello della sostenibilità ambientale: le città sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni globali di CO₂ e giocano un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico. A livello europeo questa esigenza è molto chiara e guida importanti iniziative di transizione ecologica come il Green Deal e la Missione Climate Neutral and Smart Cities, che coinvolge 112 città impegnate a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 abbattendo dell’80% le loro emissioni di gas climalteranti. Tra queste, ci sono ben 9 città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) che oggi emettono circa 3,6 tonnellate di CO₂ equivalente (CO₂e) pro capite, oltre il 90% dei quali imputabili ai settori degli edifici e dei trasporti urbani. Le principali iniziative per ridurre le emissioni includono modifiche strutturali agli edifici e l’adozione di fonti energetiche a bassa impronta carbonica. L’innovazione digitale è una leva fondamentale con sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria, sistemi di efficientamento energetico adattivi, immagini satellitari e Digital Twin per individuare il potenziale fotovoltaico degli edifici e la presenza di isole di calore.
Giocano un ruolo chiave anche nella sostenibilità sociale, con metà dei cittadini italiani che valuta il comune di residenza “insufficiente” sotto il profilo dell’inclusività (con una valutazione media di 5,2 su 10), dell’accessibilità dei servizi pubblici offerti (5,2) e del dinamismo economico-sociale (5,2). Le valutazioni scendono ancora di più quando sono chiamati a dare un giudizio sull’innovatività (4,4). La principale criticità dal punto di vista sociale è la mobilità nel comune (85%), inclusa la sicurezza stradale e l’accessibilità a trasporti alternativi all’auto a combustibile fossile, che rimane, anche per questo motivo, il mezzo preferito per gli spostamenti (60%).
Per quanto riguarda la sostenibilità economica, una via per rendere sostenibili da un punto di vista economico le Smart City passa da indentificare un nesso tra progetti e il loro beneficio economico (diminuzione di costi o aumento delle entrate). I benefici non sono sempre evidenti se si guarda alle singole soluzioni, ma possono emergere se si adotta una visione aggregata dei progetti, come spesso accade quando si parla di Project Financing e di Partnership Pubblico-Privato. Le Partnership Pubblico-Privato sono ritenute molto utili per la realizzazione delle progettualità Smart City da più di 1 comune italiano su 3 (37%), ma ad ora sono adottate solo da poco meno di un comune su 6 (16%).
Dall’analisi realizzata in collaborazione con BVA Doxa emerge che la sostenibilità è ormai un valore centrale nella vita quotidiana delle persone e solo il 4% dichiara di non avere contribuito con le proprie scelte al miglioramento della propria città. Si tratta, più che altro, di azioni rivolte alla riduzione dei consumi (56%) e alla corretta raccolta differenziata (56%), mentre altri ambiti, come ad esempio, la mobilità sostenibile rimangono ancora difficili da perseguire (23%).
Il digital divide
Trattando il tema del digital divide, nella digitalizzazione si evidenzia molto forte, soprattutto tra le generazioni più anziane e quelle più giovani. Le app più utilizzate per interfacciarsi con i servizi sul territorio sono quelle legate ai pagamenti digitali (74% Millennial vs 65% Boomers) e alla navigazione delle mappe cittadine (73% Gen Z vs 61% Boomers). Le applicazioni in cui la differenza tra generazioni è più forte sono quelle legate alla mobilità smart (es. sharing, trasporto pubblico, parking) e alla vita sociale (es. sport, scuola).
L’Intelligenza Artificiale è conosciuta dal 92% degli italiani, che si dicono favorevoli, in particolare, all’uso dell’AI per applicazioni legate alla sicurezza pubblica (46%), per il monitoraggio delle emergenze e la gestione dei guasti alle infrastrutture (46%) e, nei grandi comuni per la gestione intelligente del traffico (59%). Tuttavia, i cittadini temono un’eccessiva dipendenza tecnologica (41%) e l’esclusione digitale (39%). Un altro aspetto che preoccupa, soprattutto fra i giovani della Gen Z, è anche la perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione.
L’AI nei comuni
La ricerca ha evidenziato oltre 496 progetti di adozione dell’IA nei contesti urbani a livello mondiale tra il 2018 e il 2024, con applicazioni legate in particolare a con usi legati in particolare ad analisi immagini e video, elaborazione dei dati e supporto alle decisioni. Il Comune di Messina, ad esempio, ha sperimentato un sistema per ottimizzare lo smistamento dei rifiuti, mentre a Bari l’Acquedotto Pugliese ha integrato algoritmi predittivi nella Control Room per una gestione idrica più efficiente e sostenibile. Un progetto su tre prevede l’impiego di IA generativa, utilizzata ad esempio per valorizzare contenuti culturali o migliorare il dialogo con i cittadini, come nel caso di Julia, il chatbot di Roma Capitale.
Secondo il Politecnico di Milano, nonostante il crescente fermento, l’adozione dell’AI nei contesti urbani italiani resta ancora limitata: solo il 4% dei comuni ha avviato progetti in materia, principalmente su ambiti come la cittadinanza digitale e la sicurezza urbana, mentre il 35% dichiara l’intenzione di farlo nei prossimi due anni. L’implementazione attuale dell’IA risulta frammentata e senza un’infrastruttura organizzativa solida: solo due comuni su dieci hanno un team interno dedicato e appena uno su dieci ha avviato iniziative informative per la cittadinanza. Tra le criticità che ostacolano la diffusione dell’IA ci sono le preoccupazioni per la sicurezza dei dati e la tutela della privacy, seguite da limiti di governance, risorse finanziarie insufficienti e carenza di competenze tecniche.