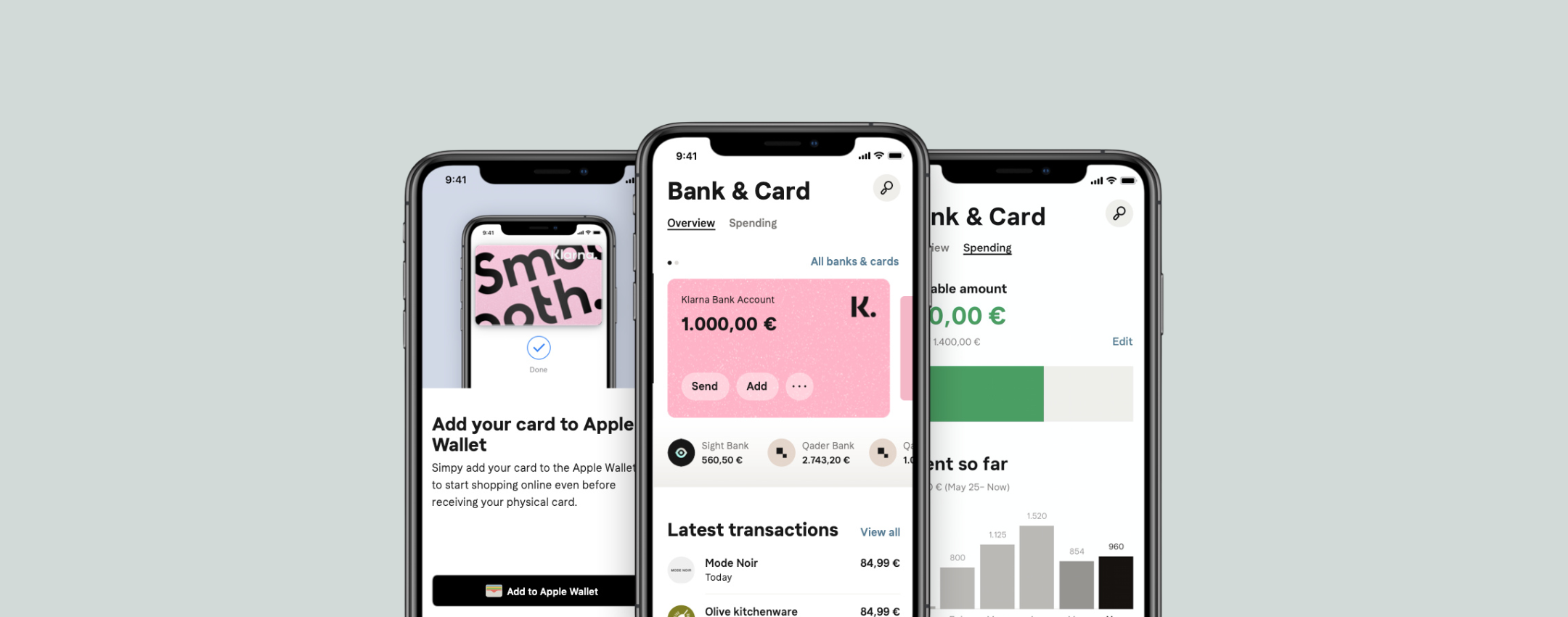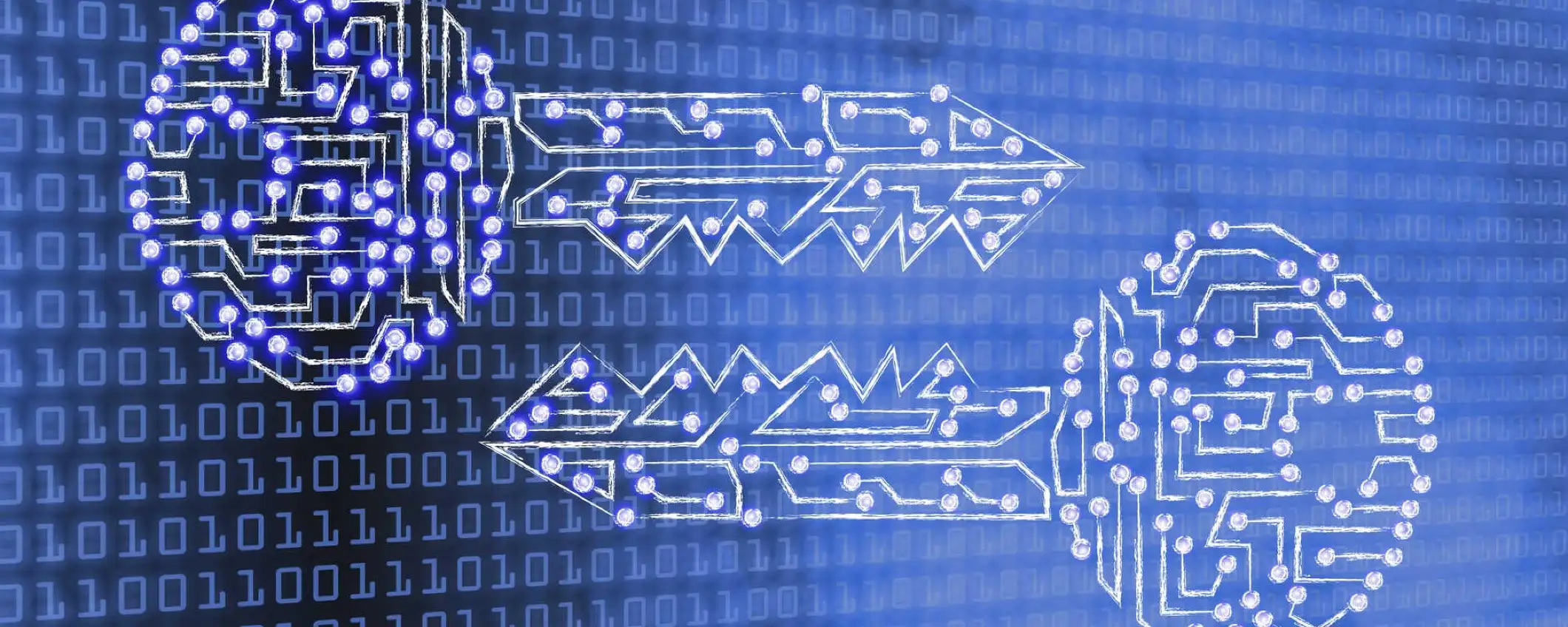L’Italia sostiene l’Ungheria anche nella repressione LGBT+, la storia mostra che non ne usciremo bene
Quando l’equilibrio sociale vacilla, non sono solo le dittature a colpire. Anche le democrazie, se svuotate dei loro principi, sono disposte a sacrificare la comunità LGBTQ+. Chi oggi in Italia minimizza la gravità del modello ungherese, sta preparando il terreno per seguirne le orme. La mancata firma dell’Italia contro il divieto del Pride non è stata una dimenticanza. È l’ennesimo atto deliberato di una politica che da anni riscrive la grammatica dei diritti trasformandoli in “provocazioni”. L'articolo L’Italia sostiene l’Ungheria anche nella repressione LGBT+, la storia mostra che non ne usciremo bene proviene da THE VISION.

Oltre venti ambasciate – tra cui Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e perfino l’Australia – hanno firmato un comunicato congiunto per condannare la decisione del parlamento ungherese di vietare la marcia del Pride. Una presa di posizione netta, che parla di violazione dei diritti umani, della libertà di espressione e di associazione. Una difesa chiara della comunità LGBTQ+ in un Paese che da anni reprime visibilità e dissenso, ricalcando decisioni e leggi che hanno messo in ginocchio le persone queer in Russia. E l’Italia? Assente, ancora una volta.
Questo ennesimo silenzio, però, non è casuale. Non è una distrazione diplomatica. È una scelta politica ben precisa, perfettamente allineata con l’asse internazionale che il governo Meloni ha deciso di rafforzare: quello dell’ultradestra illiberale. Ed è una mossa che sta ripagando. Mentre gran parte dell’opinione pubblica italiana sembra ignorare gli effetti che questa alleanza avrà sulla nostra società civile, gli equilibri internazionali si stanno spostando, a vantaggio proprio di quei gruppi di potere che, da sempre, osteggiano apertamente la comunità LGBTQ+. Nel 2024, l’Italia si era già rifiutata di firmare una lettera di condanna dell’ambasciatore USA in Ungheria, sottoscritta da 37 Paesi, che denunciava la persecuzione politicamente motivata delle persone queer e delle loro famiglie. Ora la storia non solo si ripete, ma peggiora: tra le ambasciate che hanno condannato il divieto del Pride, mancano anche gli Stati Uniti, che solo pochi mesi fa – ma con un’altra amministrazione – guidavano la denuncia. Il divieto di manifestare per i diritti non è più quindi solo una questione ungherese, ma riflette un modello culturale che sta mettendo radici anche da noi e che rivela, senza più margine di ambiguità, quale idea di democrazia, di libertà il governo italiano intenda davvero difendere.

Se ci fosse uno spazio, politico, culturale e istituzionale, per studiare la storia queer, oggi sapremmo che le dittature degli anni Trenta e Quaranta non furono le uniche a perseguitare le persone LGBTQ+. Il revisionismo storico che dipinge la repressione come esclusiva dei totalitarismi è comodo, rassicurante e profondamente falso. Prima del 1929, in diverse capitali europee e in alcuni contesti urbani americani, l’esistenza queer non era ancora sotto attacco sistematico. Era tollerata, spesso feticizzata, ma nei casi più fortunati era persino integrata. La Berlino degli anni Venti rappresentava per le persone omosessuali di allora probabilmente quello che rappresenta oggi per i contemporanei: l’amore era libero e disinibito, i locali erano alla moda e sulla bocca di tutti e grazie al professor Magnus Hirschfeld, ebreo e omosessuale, e al suo Istituto per la Sessualità, le persone transgender avevano la possibilità di avere dei documenti che permettevano loro di passeggiare per le strade della città, indossando abiti corrispondenti alla propria identità di genere. Era un’epoca fragile, certo, ma reale. E le persone queer di allora erano certi di un futuro migliore, con più diritti.
La crisi del 1929 stravolge tutto. Ovunque, in tutto l’Occidente, si comincia a identificare la libertà sessuale e di genere come una delle cause del presunto decadimento sociale, causa quest’ultimo della crisi economica. Lionel Nastorg, consigliere comunale di Parigi disse durante una seduta del 1933 che: “La società parigina mostra una vergognosa indulgenza per questi pazzi che si fanno un motivo di orgoglio nel mostrare pubblicamente il loro vizio, al punto che è oggi di moda, se cosí si può dire, non amare come tutti gli altri. Dobbiamo riconoscere che in qualche cosa questi regimi hanno operato bene a volte… Un giorno Hitler e Mussolini si sono svegliati e hanno detto: ‘Onestamente, lo scandalo è andato avanti abbastanza; le strade sono sporche e puzzano; dobbiamo fare una pulizia radicale’”. Queste parole, pronunciate nella patria dell’Illuminismo e in uno dei paesi che combatterà più strenuamente contro il nazifascismo, ci fanno comprendere quale fosse la percezione delle persone queer in quel decennio: la caccia alla diversità sessuale e di genere non era un’aberrazione ideologica confinata all’asse Roma-Berlino. Era parte di un più ampio consenso trasversale, condiviso anche in ambienti ritenuti progressisti. L’identità queer veniva percepita come il volto visibile di una modernità fuori controllo. L’urbanizzazione, la liberalizzazione dei costumi, la nuova economia instabile, la società di massa: tutti fenomeni nuovi, troppo rapidi, troppo complessi. E allora si cercava un colpevole semplice e una soluzione immediata: un veloce ritorno al passato, come oggi.

Il ristabilimento delle vecchie gerarchie patriarcali diventò la scorciatoia perfetta. La fine della breve stagione di visibilità e relative libertà LGBTQ+ – iniziata nel tardo Ottocento – fu rapida, violenta, globale. Negli Stati Uniti come in Europa, si aprì una nuova era fatta di censura, silenzi, diagnosi psichiatriche, prigione, internamento. Per un osservatore europeo, le crociate che Donald Trump e la sua nuova amministrazione stanno lanciando contro le persone trans possono sembrare, a prima vista, assurde o semplicemente l’ennesima espressione di transfobia istituzionale. Ma sarebbe un errore leggerle solo come boutade elettorali o frasi da comizio. Dietro lo spettacolo mediatico e il linguaggio incendiario, c’è una strategia culturale che affonda le sue radici in una lunga e oscura tradizione americana di repressione moralista e controllo identitario.
Qualche giorno fa, il presidente USA ha dichiarato senza mezzi termini: “Non importa quanti interventi chirurgici tu faccia, o quante sostanze chimiche ti inietti. Se sei nato con un DNA maschile in ogni cellula del tuo corpo, non diventerai mai una donna. Non sarai mai una donna.” Una dichiarazione che, oltre a risuonare piena di disprezzo e disinformazione, si inserisce perfettamente in linea con la sua scelta di escludere le donne trans dalle competizioni femminili e che si accoda con altre decisioni contro la comunità LGBTQ+ come il ban all’arte drag, fatto per “rendere le arti di nuovo grandi”. Il linguaggio è nuovo, l’aggressività è moderna, ma la sceneggiatura è già vista. Negli Stati Uniti, il tentativo di cancellare le soggettività queer dallo spazio pubblico risale almeno agli anni Venti del Novecento, quando le pressioni delle associazioni cristiane e cattoliche iniziarono a colpire direttamente le espressioni artistiche e performative delle identità di genere non conformi.

Ma fu solo nel clima post-crisi del 1929, con la società americana spinta verso un ritorno all’ordine, che queste posizioni trovarono sponda politica. A partire dagli anni Trenta, infatti, molti stati americani iniziarono a introdurre leggi che vietavano esplicitamente spettacoli in drag, accusandoli di rappresentare la degenerazione morale e la perversione sessuale. Sotto attacco finirono anche Broadway e Hollywood. Gli studios, impauriti dai possibili boicottaggi da parte delle associazioni religiose e conservatrici, sottoscrissero un rigido codice di autocensura: il celebre Production Code (meglio noto come Hays Code), che tra le sue regole vietava la rappresentazione di ciò che era considerato devianza sessuale e di qualsiasi relazione interrazziale. Il cinema americano, da quel momento, avrebbe raccontato un’America bianchissima, eterosessuale e ben allineata con il patriarcato cristiano.
Negli stessi anni, la crescente influenza della psichiatria diede un nuovo impulso alla patologizzazione delle persone queer. A favorire questa lettura fu anche un’interpretazione ampiamente diffusa del nazismo come regime guidato da un circolo di pederasti, un’idea che contribuì a identificare l’omosessualità maschile non solo come devianza morale, ma come minaccia diretta alla sicurezza nazionale. Una narrativa pericolosa, che aprì le porte a una persecuzione sistemica. Negli anni Cinquanta, in piena epoca maccartista, il nemico dell’America cambiò, ma non il volto che l’americano medio doveva temere ed odiare: le persone queer vennero associate al comunismo, viste come agenti del disordine ideologico e quindi probabili infiltrati russi. La storia anche qui si ripeté identica: repressione, schedature, espulsioni, discriminazione.

Insomma, non è la prima volta che l’identità queer viene etichettata come nemico interno da un’America spaventata dalla propria modernità. Trump non sta inventando nulla. Sta semplicemente ricalcando un copione già scritto, riattivando un dispositivo ben rodato: usare le vite trans e queer come carne da propaganda per rafforzare un’idea autoritaria, gerarchica e profondamente reazionaria della società.
Anche l’operato di Giorgia Meloni, grande alleata di Trump, va letto alla luce della storia LGBTQ+ del nostro paese. Il 23 agosto del 1927, in seconda pagina, il Corriere della Sera pubblicava un articolo sui lavori preparatori del nuovo codice penale che prospettava il carcere per chi avesse intrattenuto una relazione omosessuale. L’ipotesi di introdurre una norma specifica per criminalizzare l’omosessualità accese un forte dibattito, e alla fine non venne ratificata nel codice Rocco del 1930. Lo Stato fascista preferì mantenere il silenzio. Perché scrivere la parola “omosessualità” nella legge significava ammettere che esistesse, e per il regime era più efficace fingere che non ci fosse nulla da vedere.
Ma questo silenzio non deve trarre in inganno: negli anni successivi, centinaia di uomini omosessuali vennero schedati, pestati, mandati al confino, su di loro furono condotti esperimenti endocrinologici in istituti psichiatrici italiani con ormoni di animali. La patologizzazione delle persone queer, iniziata nei manuali medici e nei trattati criminologici, diventò così uno strumento di governo: un progetto politico per riportare all’ordine tutto ciò che la modernità aveva reso fluido e instabile. Le relazioni e i ruoli di genere dovevano tornare alla norma, anche con la forza. La morale cattolica e fascista preferiva raccontare l’Italia come un paese in cui erano tutti maschi, nascondendo il resto sotto una cappa di vergogna, fuori dallo sguardo pubblico, fuori dalla narrazione ufficiale.

E in questa stessa logica va letto oggi il provvedimento del governo Meloni contro ogni progettualità familiare che non sia quella della cosiddetta famiglia tradizionale. La legge “contro la maternità surrogata” non nasce per proteggere le donne da pratiche scorrette condotte all’estero – perché, infatti, quando si tratta di coppie eterosessuali, provare l’utilizzo della gestazione per altri diventa complicato. Questa legge colpisce in modo mirato le coppie omosessuali maschili. Lo scopo è evitare che l’opinione pubblica italiana entri in contatto con l’idea che due uomini possano crescere un figlio, costruire una famiglia, essere visibili come soggetti affettivi e genitoriali.
In linea con la nostra storia, l’attacco alla comunità LGBTQ+ dell’ultradestra italiana non è frontale, ma più subdolo: rendere invisibili, osteggiare la socialità queer, smontare la possibilità stessa di esistere pubblicamente. È una strategia d’emarginazione, che colpisce le famiglie omogenitoriali, ma anche i soggetti meno conformabili alla norma come le persone trans. E come fece l’Italia con il nazismo, Meloni stringe alleanze con figure più esplicite nell’aperta repressione dell’esistenza LGBTQ+, con il pretesto della tutela dei bambini e dei valori identitari e sovranisti.

Quando l’equilibrio sociale vacilla, non sono solo le dittature a colpire. Anche le democrazie, se svuotate dei loro principi, sono disposte a sacrificare i corpi più vulnerabili per dare un’illusione di ordine e forza. E il corpo queer, è il primo a pagarne il prezzo. Chi oggi in Italia minimizza la gravità del modello ungherese o finge che la questione non ci riguardi, sta preparando il terreno per seguirne le orme. La mancata firma al comunicato delle ambasciate in Ungheria non è stata una dimenticanza. È l’ennesimo atto deliberato di una politica che da anni riscrive la grammatica dei diritti: trasformandoli attraverso la narrazione di destra in richieste provocatorie, e la libertà in un premio riservato solo a chi resta dentro i confini della norma. Serve memoria, ma anche consapevolezza: se non si aiuta l’Ungheria oggi, l’Italia sarà la prossima della lista. E questa volta, non potremo dire di non averlo visto arrivare.
L'articolo L’Italia sostiene l’Ungheria anche nella repressione LGBT+, la storia mostra che non ne usciremo bene proviene da THE VISION.