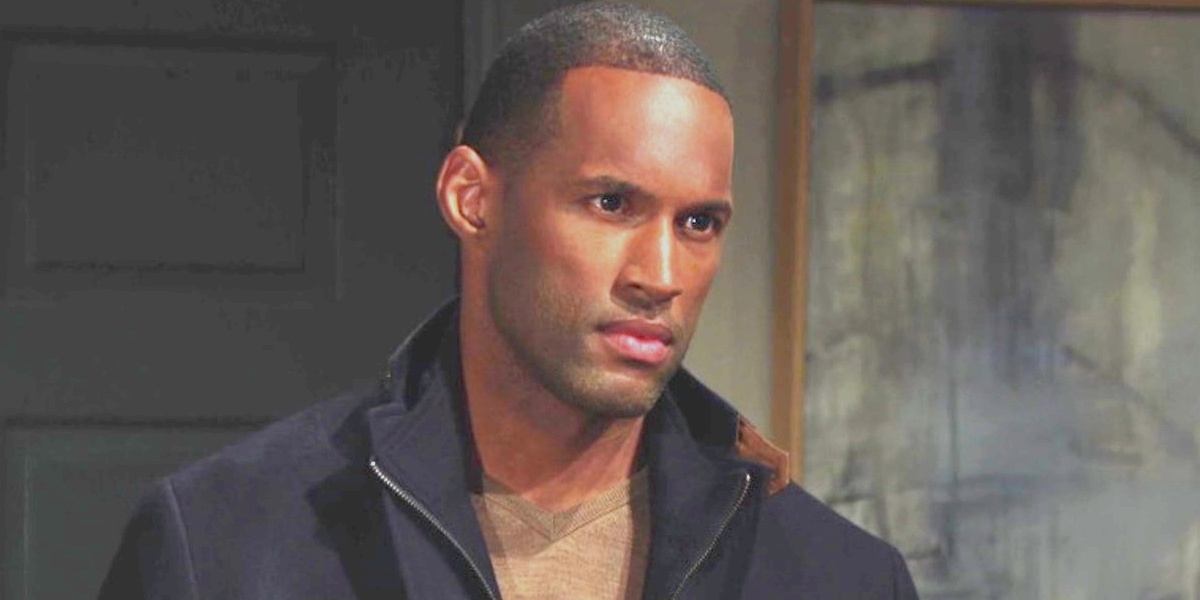Lettera a Tea Ranno per “Avevo un fuoco dentro”
Cara Tea, leggendoti ritrovo molto del mio vissuto della malattia e dell’ospedalizzazione, ma ritrovo anche quel fuoco sacro della scrittura, dove il confine tra autobiografia e narrazione è squarciato. Quel […]

Cara Tea,
leggendoti ritrovo molto del mio vissuto della malattia e dell’ospedalizzazione, ma ritrovo anche quel fuoco sacro della scrittura, dove il confine tra autobiografia e narrazione è squarciato. Quel fuoco potrebbe essere il male che divora, la crescita, la perdita dell’innocenza, il divenire donna; e torna la presenza del sangue, come dovere di crescere, di essere donne, prima, e come impossibilità di generare a causa dell’endometriosi, poi. La vita spezzata da un prima e da un dopo. Prima di scoprirsi ammalati, prima di aver guardato la morte in faccia, prima di essere trasportati in un inferno, e dopo la consapevolezza, la lotta contro il male che riempie il labirinto della fertilità, la lotta per stare al mondo, per poter generare. Tra questi due momenti abbiamo l’apprendistato con il professore: un docente, uno scrittore autoritario e severo. L’avversario che sgretola e disfa la passione, la pulsione vitale. L’avversario in quanto maestro, ogni maestro diviene un rivale, ogni maestro amerà stroncarci nel timore che possiamo superarlo. Infine, la lotta tra un maschile e un femminile ormai privi dell’equilibrio necessario per comprendersi. Una Sicilia atavica in cui gli anni Settanta non giungono mai. Un luogo abbacinante in cui il corpo però è negato in quanto peccaminoso. Una bellezza lacerata dall’incomprensione delle persone più care: le più pericolose.
È una storia di devozione e stregoneria, di rivolta, di riappropriazione di un’identità infranta. È una storia scritta con la lingua dello spirito: il sangue. È un percorso, il tuo, di morte e rinascita, dove ogni incontro si radica e diviene incanto. È scritta con una lingua limpida, pregna di poesia. A tratti il flusso di coscienza spezza la narrazione lasciandoci allucinare la realtà. Il fiabesco incanto della Morante sposa una lingua armoniosa, a tratti aulica, che richiama Una donna di Sibilla Aleramo.
È una scrittura profonda, che afferra e trascina con sé. Questa colpa di essere donna, e perciò fragile, emotiva, talvolta eccessivamente richiedente, l’ho sempre sentita anch’io, come se i miei bisogni fossero capricci. Sono le stesse cose che genitori e uomini ci hanno fatto pesare.
La scrittura del trauma è un compito. Vi è qualcosa di misterioso e infuocato in questo libro. La catena di montaggio che forgia scrittori in serie, intellettuali privi di emozioni, è la visione di una rivolta possibile solo nel silenzio del cuore: incredibile leggerti e ritrovare i miei vissuti.
«Ma lo sai che vuol dire scrivere?».
Mi guarda offesa. Lo chiedo giusto a lei che i libri se li mangia?
«Lo sai che vuol dire?» insisto.
Muta resta.
«No? E allora te lo dico io. Significa tornare lì, al punto esatto del dolore, al punto esatto dei denti che ti lacerano, in quel dolore che diventa eterno perché, per raccontarlo, deve eternarsi in ogni attimo su cui ti soffermi, in ogni parola che scegli, perché le parole sono spesso sbagliate, non rendono, non sono abbastanza evocative, e tu stai lì, nel dolore, per raccontare il dolore, per dirlo con una parola che non è mai quella giusta, si avvicina, ma non è mai quella giusta. Che vuol dire denti di cane? Che vuol dire fuoco che brucia?










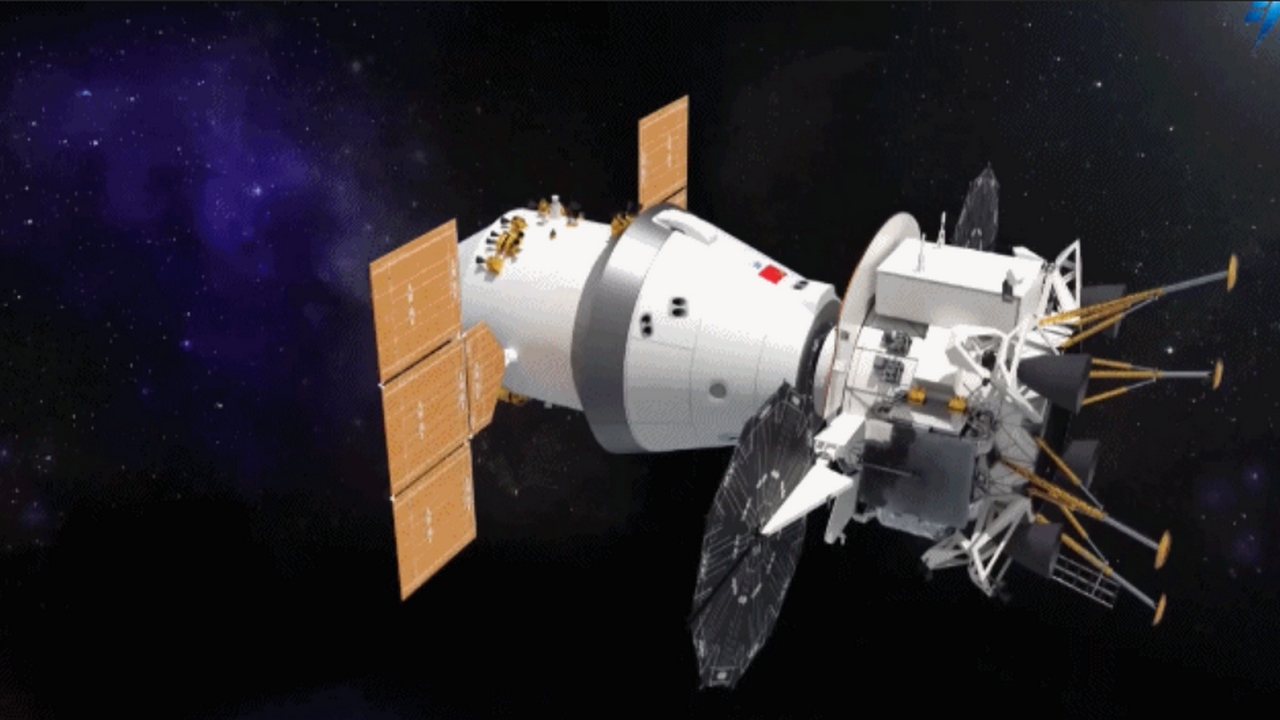
/https://www.html.it/app/uploads/2025/04/windows-11.jpg)
/https://www.html.it/app/uploads/2025/04/wp_drafter_547803.jpg)