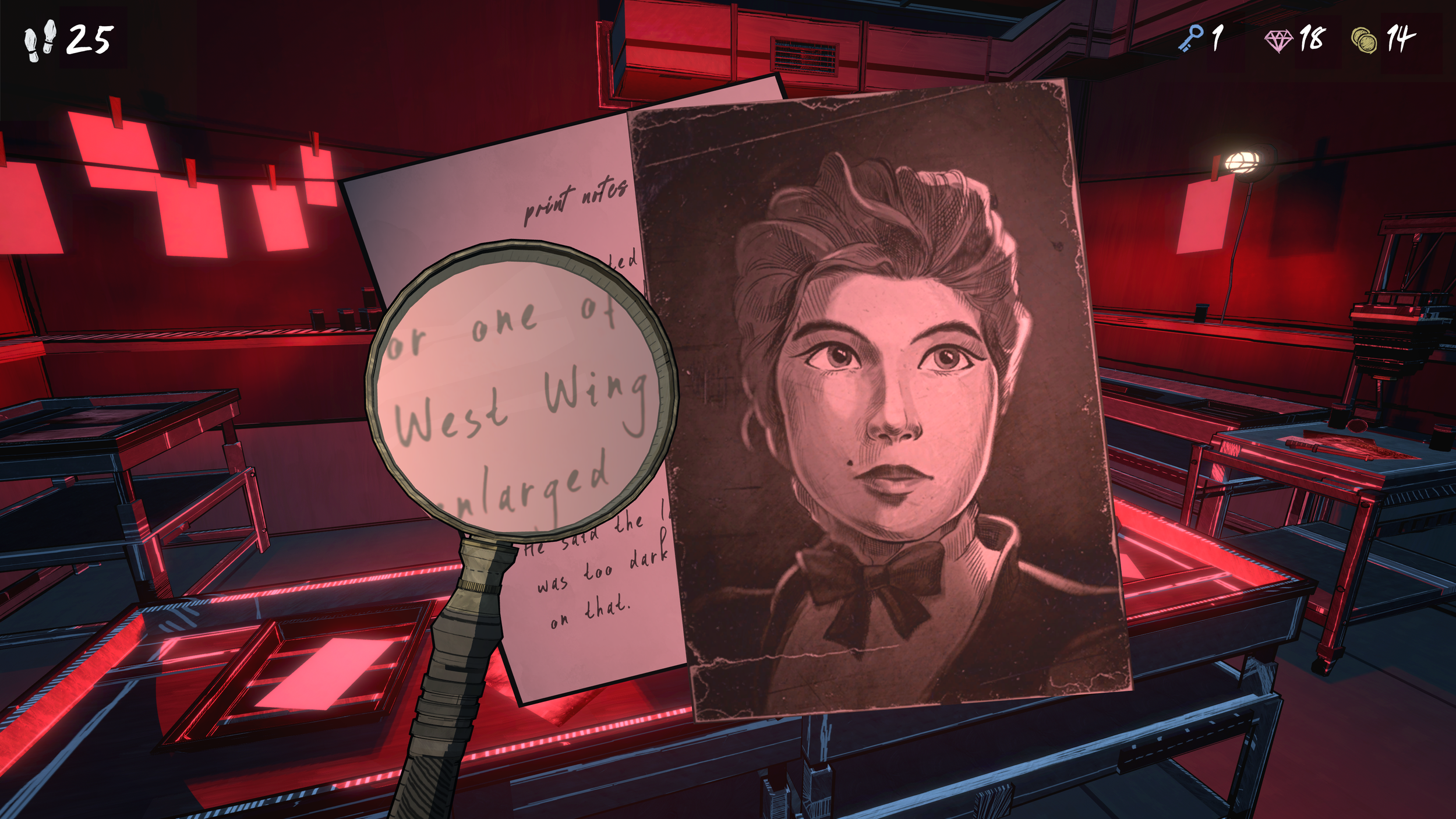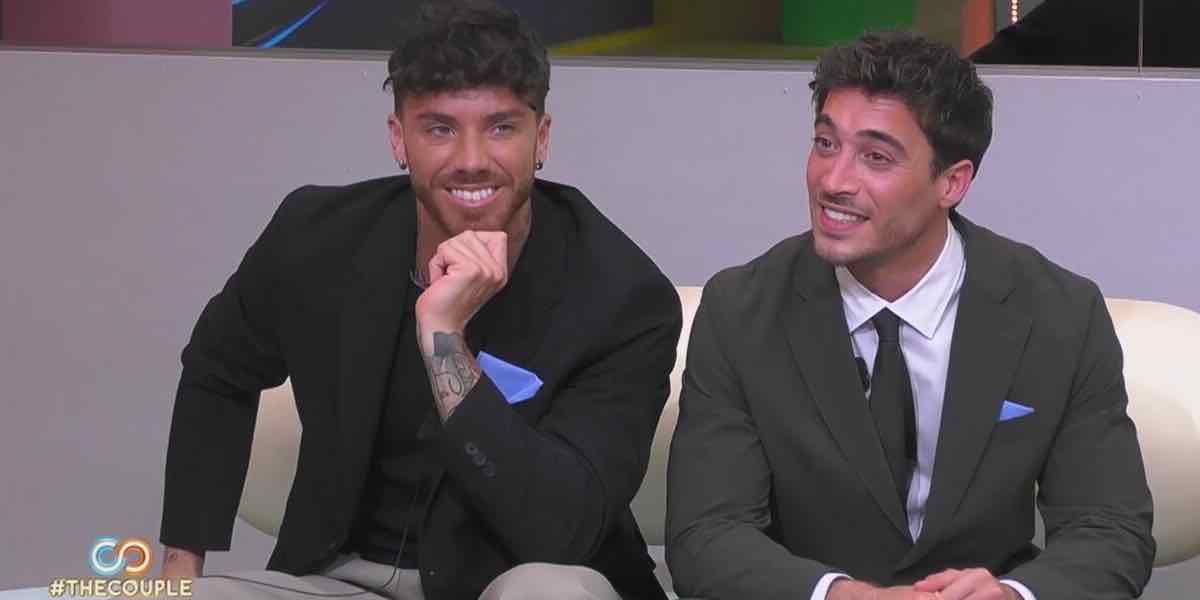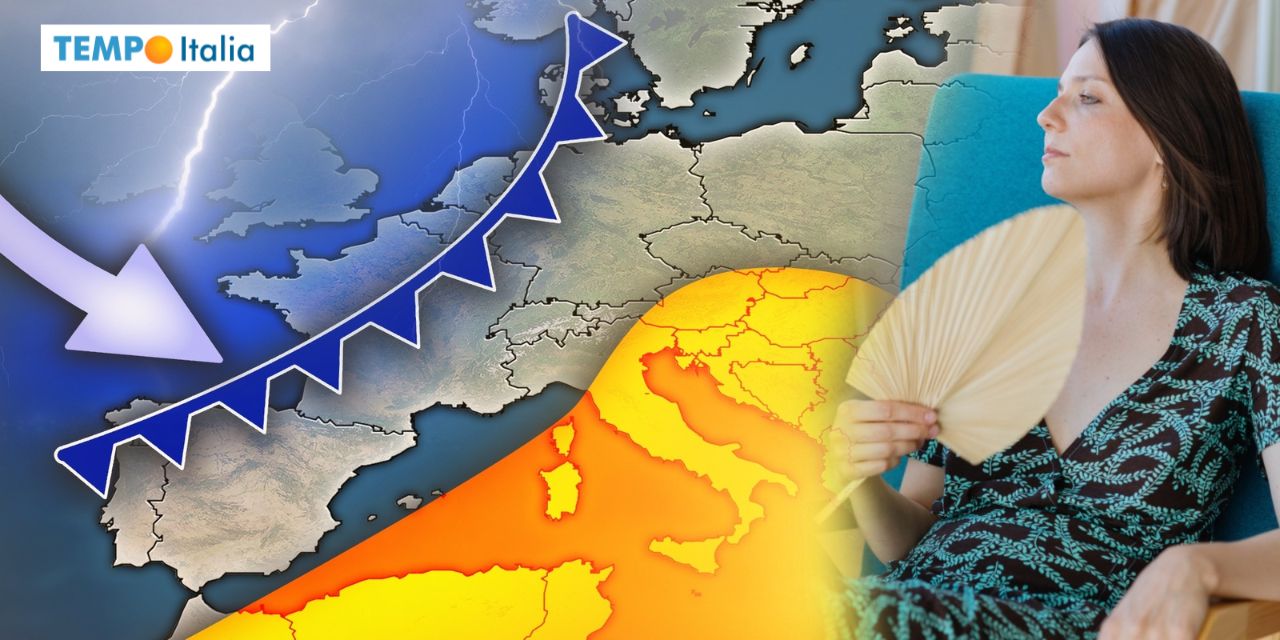Le storie premiate dal Goldman environmental prize 2025 insegnano che vale sempre la pena difendere l’ambiente
Conosciamo i vincitori e le vincitrici del Goldman environmental prize 2025, il più prestigioso riconoscimento internazionale per gli attivisti ambientali.

- Il Goldman environmental prize è un riconoscimento internazionale assegnato ogni anno a leader ambientalisti provenienti da sei regioni del mondo.
- I vincitori del 2025 sono Laurene Allen (Stati Uniti), Mari Luz Canaquiri Murayari (Perù), Semia Gharbi (Tunisia), Besjana Guri 2 Olsi Nika (Albania), Batmunkh Luvsandash (Mongolia), Carlos Mallo Molina (isole Canarie).
In un contesto geopolitico sempre più teso, con il riarmo elevato a priorità assoluta e il presidente della prima economia del mondo che calpesta qualsiasi tutela per l’ambiente e il clima, può venire la tentazione di ripiegarsi su sé stessi. Di concentrarsi sull’oggi invece di disperdere tempo ed energie per difendere il pianeta, con risultati incerti e lontani. I Goldman environmental prize, i cosiddetti Nobel per l’ambiente, ci ricordano che non è così. È vero: salvaguardare il territorio spesso significa partire dal basso e sfidare grandi poteri economici. È vero: ci sono momenti in cui può sembrare una battaglia contro i mulini a vento. Ma le sei storie premiate dall’edizione 2025 testimoniano che la dedizione, la competenza e la mobilitazione collettiva portano i loro frutti. Conosciamo dunque i vincitori e le vincitrici dei Goldman environmental prize 2025.
I vincitori e le vincitrici del Goldman environmental prize 2025
- Laurene Allen (Stati Uniti)
- Mari Luz Canaquiri Murayari (Perù)
- Semia Gharbi (Tunisia)
- Besjana Guri e Olsi Nika (Albania)
- Batmunkh Luvsandash (Mongolia)
- Carlos Mallo Molina (isole Canarie)
Laurene Allen (Stati Uniti)
Nel mese di maggio del 2024 lo stabilimento Saint-Gobain Performance Plastics nella cittadina di Merrimack, nel New Hampshire, ha chiuso i battenti. Faceva capo alla multinazionale francese Saint-Gobain e per vent’anni aveva fabbricato dispositivi di protezione, rivestimenti per antenne e altri articoli tessili. Prodotti che venivano immersi in una miscela liquida di Pfas, le famigerate sostanze per- e polifluoroalchiliche, e poi asciugati in un forno per assumere un rivestimento resistente e impermeabile.
Se la fabbrica non opera più è per merito di Laurene Allen, oggi sessantaduenne. Non è una scienziata di formazione, bensì un’assistente sociale che nel 2016 è uscita indignata dall’incontro in cui il New Hampshire department of environmental services cercava di minimizzare i rischi per la salute dovuti alla contaminazione da Pfas nell’acqua potabile, ben superiore alle soglie di sicurezza. La sua rabbia è diventata azione. Allen si è documentata, si è messa in contatto con esperti del tema, ha riunito un gruppo di volontari (chiamato Merrimack citizens for clean water) non si è arresa quando è stata presa per una Cassandra.

Alcuni membri del comitato si sono candidati a cariche elettive nazionali e locali, facendo così installare filtri per i Pfas. Tutto questo mentre Laurene Allen testimoniava nelle audizioni pubbliche, organizzava proteste e commissionava test clinici sull’impatto dei Pfas sulla salute. Tant’è che Saint-Gobain, pur avendo ottenuto il rinnovo delle licenze, ha chiuso l’impianto con la motivazione ufficiale di una “ristrutturazione della strategia produttiva”. Ma ora si apre un’altra battaglia: quella per la bonifica. Perché l’azienda non si è mai assunta la responsabilità della contaminazione da Pfas a Merrimack, quindi legalmente non è tenuta a farsene carico.
Mari Luz Canaquiri Murayari (Perù)
Nel 2000 uno sversamento di petrolio ha contaminato il fiume Marañón, sacro per il popolo indigeno Kukama. È lungo oltre 1.700 chilometri e scorre interamente in Perù, dalle Ande fino al fiume Ucayali, il ramo principale del rio delle Amazzoni. In un certo senso era un disastro annunciato, visto che trent’anni prima il governo peruviano aveva dato il via libera alle trivellazioni nel suo bacino, con effetti deleteri per l’ecosistema e chi lo abita. Tant’è che gli sversamenti, nel corso degli anni, sono stati decine. Ma dopo quell’episodio del 2000 Mari Luz Canaquiri Murayari si è resa conto di quanto poco fossero visibili le donne e ha dato vita alla Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana.

Alla guida dell’associazione, si è fatta notare soprattutto quando ha preteso chiarezza dalle autorità in seguito al nuovo, disastroso sversamento di petrolio avvenuto nel 2010 vicino al porto di Saramuro. E quando nel 2014, con gli strumenti della legge, è riuscita a fermare un progetto di dragaggio del fiume. Proprio dalla collaborazione con varie ong attive sul fronte legale ha preso il via una causa per il riconoscimento della personalità giuridica del fiume Marañón. Una strada che non era mai stata tentata prima in Perù.
L’iniziativa, di cui Mari Luz Canaquiri Murayari è stata il volto e la voce, ha avuto successo. Tanto più perché nel frattempo gli incidenti si moltiplicavano, così come le testimonianze e le marce di protesta della popolazione. A marzo 2024 la corte ha decretato che il fiume Marañón ha un valore, ha il diritto di restare a scorrimento libero e di essere tutelato dall’inquinamento. Il governo peruviano e la compagnia petrolifera nazionale, Petroperú, hanno violato questi diritti. Dunque, devono riparare i danni fatti e predisporre un piano di protezione del fiume e dei suoi affluenti.
Semia Gharbi (Tunisia)
C’è anche un po’ di Italia in questi Goldman environmental prize ma, purtroppo, con un’accezione tutt’altro che positiva. Perché dal nostro paese, nel 2020, sono partiti 282 container che contenevano 7.900 tonnellate di rifiuti che l’impresa tunisina Soreplast avrebbe dovuto selezionare e riciclare. Durante un’ispezione, però, le autorità tunisine hanno scoperto che quei rifiuti non erano riciclabili come dichiarato. Insomma, rientravano in un traffico illecito, presumibilmente facilitato da vaste sacche di corruzione su entrambe le sponde del Mediterraneo.
È qui che entra in gioco Semia Gharbi, scienziata, divulgatrice ambientale e da vent’anni insegnante e attivista. Gharbi è fondatrice e presidente dell’Associazione per l’educazione ambientale delle generazioni future, oltre che coordinatrice per il medio oriente e il nord Africa della rete Ipen (International pollutants elimination network) e co-fondatrice della Rete di ong Tunisie verde (Rtv).
Quando è esploso lo scandalo legato al traffico illegale di rifiuti, nell’autunno del 2020, Gharbi e i suoi colleghi di Rtv hanno lanciato una vasta campagna mediatica per spingere entrambi i governi coinvolti – italiano e tunisino – ad assumersi le proprie responsabilità. È anche merito di questa forte pressione pubblica se una commissione parlamentare ha avviato un’inchiesta che ha portato a decine di licenziamenti e arresti.
Dopo diversi mesi, i governi di Tunisia e Italia hanno firmato un accordo per il rimpatrio di 212 container: gli altri erano andati misteriosamente a fuoco. A novembre 2023, anche per evitare il ripetersi di episodi simili, le istituzioni europee hanno inasprito le regole sulle esportazioni di rifiuti nei paesi non appartenenti all’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
Besjana Guri e Olsi Nika (Albania)
In rappresentanza dell’Europa, a vincere il Goldman environmental prize 2025 sono Besjana Guri e Olsi Nika. Sono albanesi e hanno deciso di battersi per il fiume Vjosa, uno dei pochissimi fiumi europei rimasti a scorrimento libero: ciò significa che non ci sono dighe né altre strutture antropiche che interferiscono col suo percorso. La natura è rimasta intatta e si manifesta attraverso una ricchissima biodiversità, con 1.175 specie animali e vegetali censite, tra cui 119 protette dalla legge albanese e 39 minacciate.
Gli interessi economici, però, si fanno sentire. E l’idroelettrico è pressoché l’unica fonte di energia disponibile nel territorio albanese. Tant’è che il governo, negli anni Dieci, decide di costruire 45 dighe sul fiume Vjosa e sui suoi affluenti. Besjana Guri e Olsi Nika, attivi nella ong EcoAlbania, decidono di intervenire prima che sia troppo tardi. Nel 2014 lanciano una campagna per salvare “il cuore blu d’Europa”, in collaborazione con le ong EuroNatur e RiverWatch. L’anno successivo fondano l’iniziativa Amici del Vjosa con cui, armati di determinazione e creatività, coinvolgono ong, attivisti, artisti, scienziati e cittadini.

A marzo 2023 il governo albanese istituisce il Parco nazionale del fiume selvaggio – il primo del suo genere nell’intero Continente. Si estende su 125 chilometri quadrati, cioè il corso del fiume Vjosa e i suoi affluenti, proibendo le attività commerciali nel 75 per cento dell’area e permettendo i pascoli tradizionali nel restante 25 per cento. Nella parte albanese non potrà essere edificata nessuna diga. Ed è già stato aperto il dialogo con il governo della Grecia, paese in cui nasce il fiume, per estendere tali protezioni oltreconfine. Ma ora inizia un’altra battaglia, quella per impedire che sia deviato il corso del fiume Shushica.
Batmunkh Luvsandash (Mongolia)
La Mongolia ha un soprannome, Minegolia. Perché a partire dagli anni Novanta, con venire meno del sostegno dell’Unione sovietica, ha fatto leva sui ricchi giacimenti di oro, rame, zinco, uranio e carbone per dare slancio alla propria economia. Il problema è che la Mongolia è anche un territorio semi desertico, ancor più in questi anni in cui l’impatto dei cambiamenti climatici si fa sentire, e le miniere prosciugano – e inquinano – le sue scarsissime risorse idriche. Un problema che si fa sentire nella provincia del Dornogov’, occupata quasi interamente dal deserto del Gobi, habitat – tra gli altri – di cammelli selvatici, pecore Argali, asini selvatici in via di estinzione, circa trecento piante autoctone. Quasi il 10 per cento del suo territorio è stato destinato alle miniere, spesso con concessioni frammentate che interrompono gli habitat e complicano la vita dei pastori.
Nella provincia del Dornogov’, vive anche Batmunkh Luvsandash, vincitore del Goldman environmental prize all’età di 81 anni. Figlio di pastori nomadi, ha dalla sua parte una profonda conoscenza del territorio e le competenze tecniche dategli dal suo lavoro di ingegnere. Quando nel 2015 il governo mongolo ha rilasciato licenze per le esplorazioni minerarie attorno al monte sacro di Hutag, ha capito che istituire un’area protetta era l’unico modo per scongiurare il peggio.
Ha studiato, ha viaggiato e si è presentato nell’ufficio del governo locale con una mappa delle aree da tutelare, disegnata a mano. Scoprendo che era quasi identica a quella che aveva messo a punto, attraverso un sistema di informazione geografica, The Nature Conservancy per conto del governo mongolo. Ha dunque unito le forze con lo staff della ong e con le agenzie statali per trovare il giusto equilibrio tra il rispetto dell’ambiente e le esigenze degli allevatori e dei pastori.
Batmunkh Luvsandash ha presentato ufficialmente la sua proposta nella primavera del 2020 e due anni dopo ha incassato il via libera. La nuova area protetta vieta qualsiasi attività estrattiva su 267 chilometri quadrati e si aggiunge alle altre tre zone che erano già state tutelate negli anni precedenti, per un totale di circa 832 kmq. Accolta con favore dalla comunità locale che, oltre a portare avanti lo stile di vita che la caratterizza da secoli, gode di un’opportunità lavorativa in più per la sorveglianza del parco.
Carlos Mallo Molina (isole Canarie)
Tenerife, la più grande delle isole Canarie, è una meta turistica rinomata che conta circa sei milioni di visitatori all’anno. Ma le esigenze del turismo di massa mal si sposano con quelle della straordinaria biodiversità marina della zona. Nonostante l’istituzione dell’area marina protetta Teno-Rasca, negli ultimi decenni si è assistito alla scomparsa di più della metà delle praterie di posidonia vitali, al crollo delle popolazioni di pesci e a una crescita dell’inquinamento e della pesca. Dopo la costruzione nel 2010 del porto di Granadilla, a est, il governo spagnolo ha deciso di edificarne un altro sul lato occidentale dell’isola, a Fonsalía, nel bel mezzo dell’area marina protetta. Con una capacità prevista di 470 imbarcazioni da diporto e cinque grandi traghetti.

Carlos Mallo Molina ha abbracciato questa causa tanto da scegliere di cambiare vita. Era un ingegnere civile esperto proprio nella costruzione di porti ma, quando ha studiato i possibili danni dovuti al terminal di Fonsalía, ha lasciato il suo lavoro per fondare un’organizzazione no profit, Innoceana. Ha riunito un team di esperti con cui ha mappato le specie marine locali, i loro habitat e lo stato di salute dell’ecosistema. Ha messo a frutto le sue competenze da ingegnere per stilare rapporti sui problemi legati al futuro porto di Fonsalía e, anche e soprattutto, per proporre alternative altrettanto valide ma meno impattanti. Ha lavorato sul fronte della sensibilizzazione, anche per bambini, con l’aiuto della realtà virtuale. Ha raccolto oltre 420mila firme. La sua battaglia è andata a buon fine: non ci sarà alcun porto a Fonsalía. Al suo posto, sempre per iniziativa di Innoceana, sorgerà il primo centro di osservazione ed educazione marina delle isole Canarie.