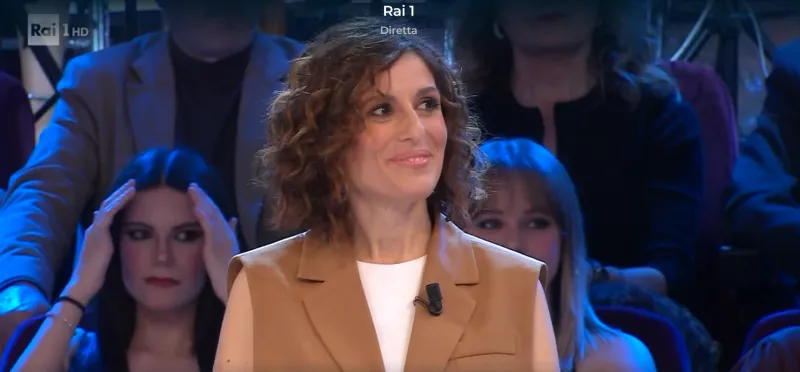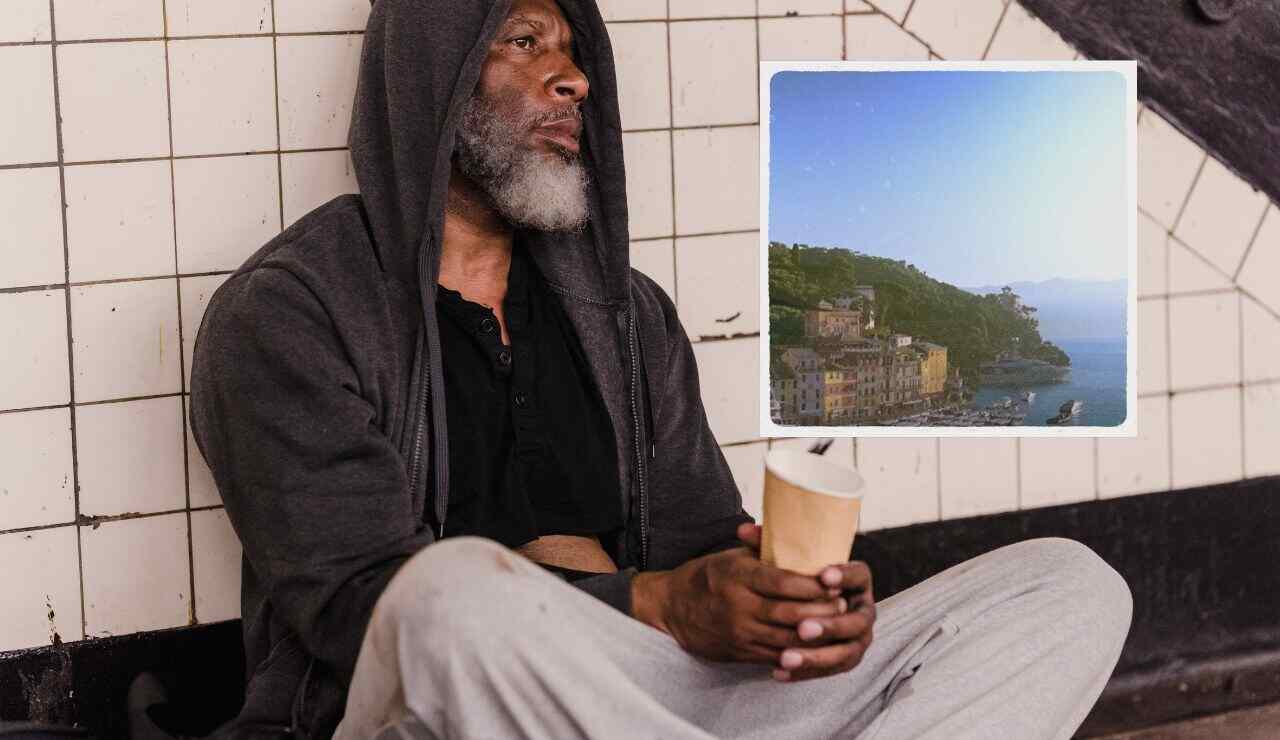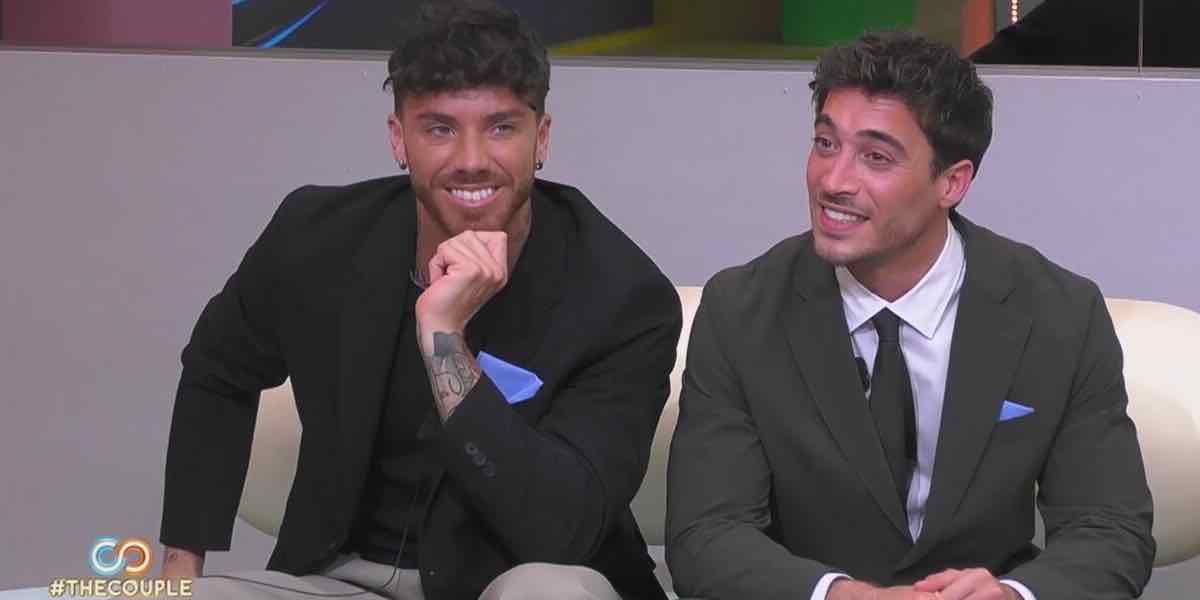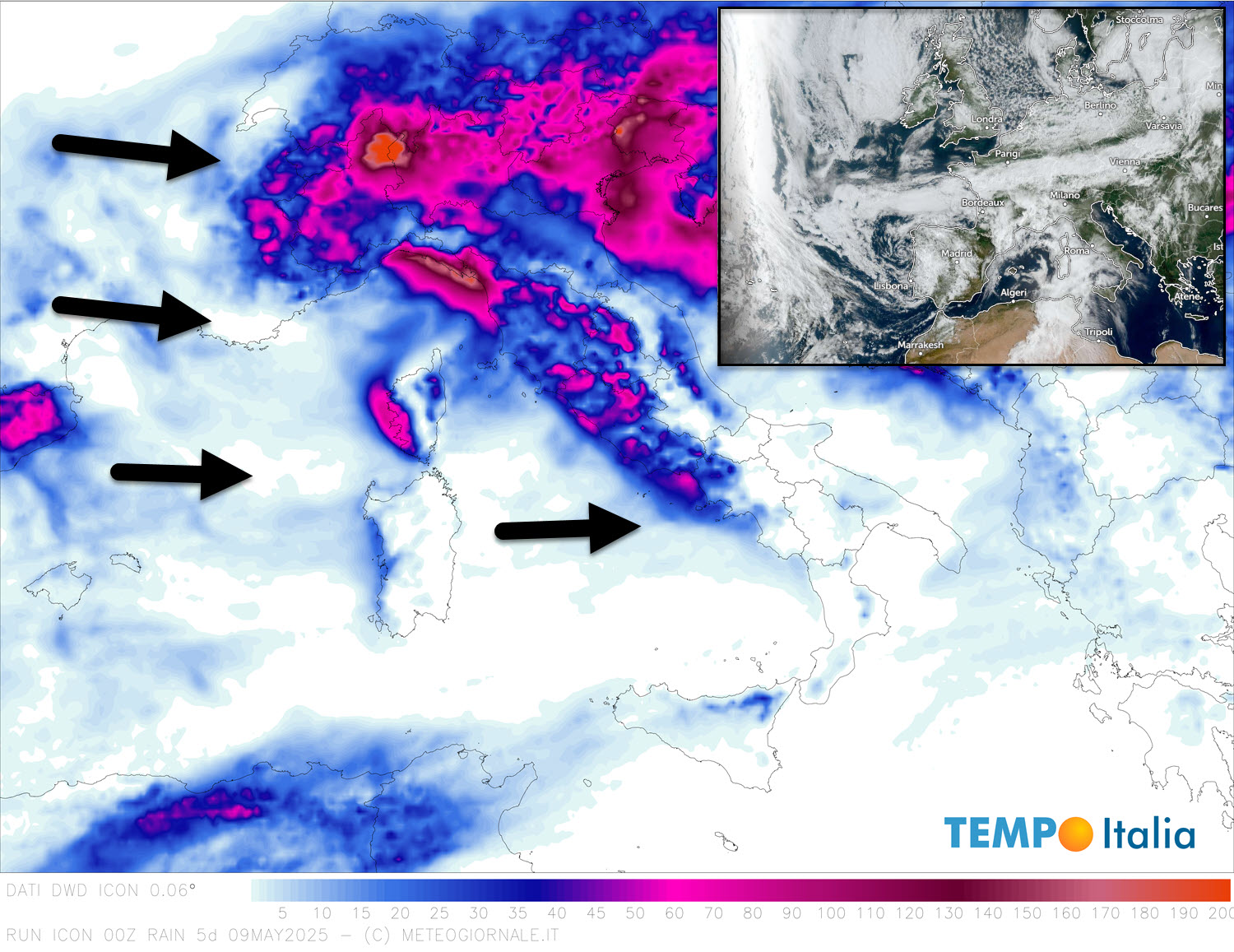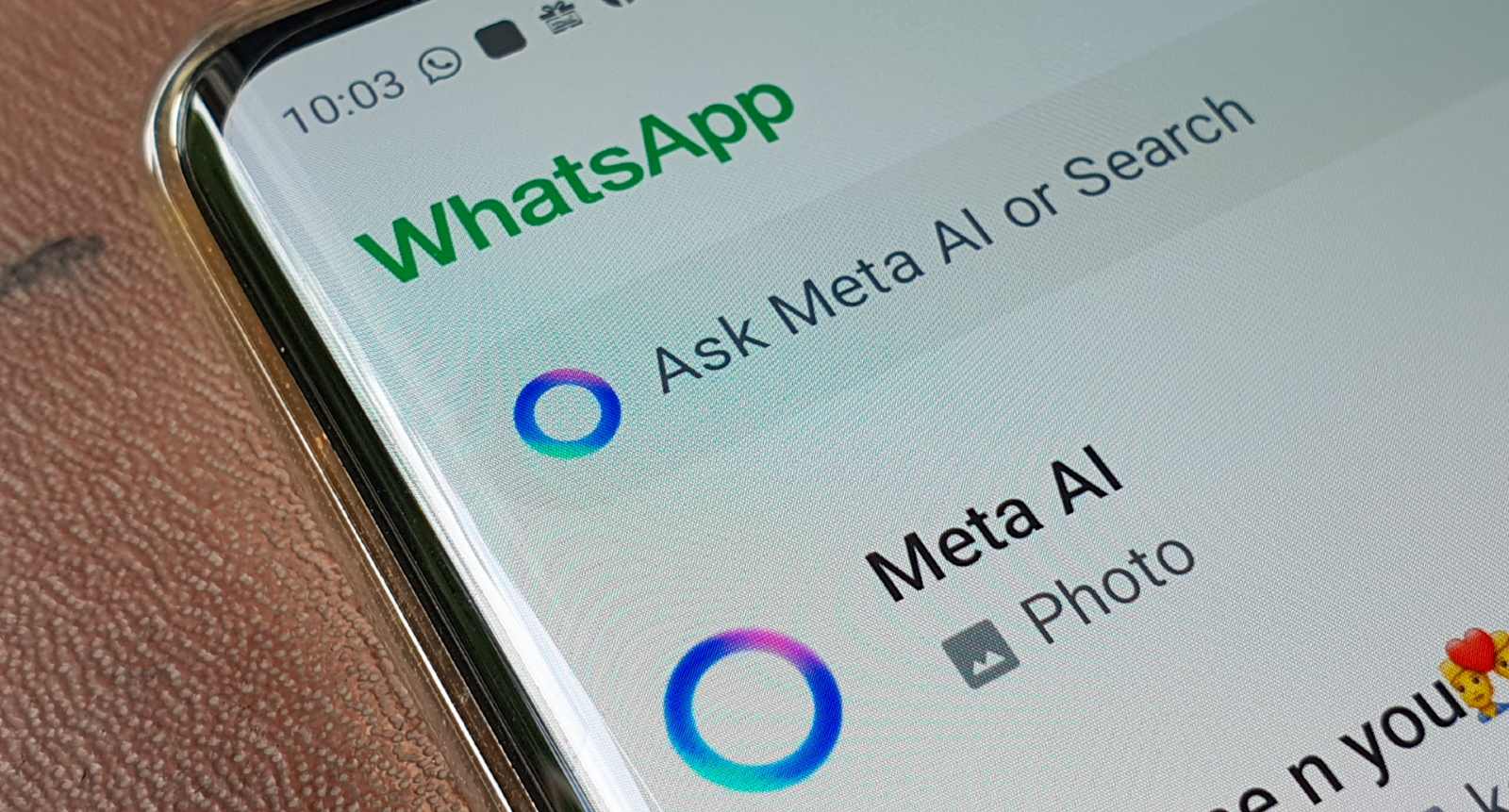La preziosa eredità di Papa Francesco e lo “stolto pregiudizio” contro di lui
Erano tanti gli interrogativi, le attese e le preoccupazioni sulla Chiesa agli inizi del conclave del marzo 2013, dopo le inaspettate dimissioni di Benedetto XVI e le tensioni di vario […]

Erano tanti gli interrogativi, le attese e le preoccupazioni sulla Chiesa agli inizi del conclave del marzo 2013, dopo le inaspettate dimissioni di Benedetto XVI e le tensioni di vario tipo che ruotavano intorno al Vaticano.
L’elezione di un Papa proveniente dall’America Latina e che si volle chiamare Francesco rappresentò, già di per sé, una ventata di novità che sorprese positivamente la generalità dei cattolici e non solo. Un segno di rinnovamento, ma non certo di rottura. Infatti, il contenuto dei suoi discorsi non si discostava affatto da quelli dei Papi precedenti.
Tuttavia, l’ultimo Papa ha lasciato qualche segno in più. A esempio, sul piano dell’accoglienza ai migranti ha confermato le posizioni dei Papi, quantomeno da Pio XII a Benedetto XVI, ma Francesco si è recato a Lampedusa come primo viaggio apostolico; d’altronde, il fenomeno e le relative vittime diventavano sempre più imponenti. Similmente, si può affermare per i tema della pace, dei poveri, del dialogo tra le religioni, del rapporto con le donne e così via. Inoltre, per le modalità della comunicazione – senz’altro più diretta e semplice – egli ha dato più incisività ai contenuti del messaggio e, evidentemente, maggiore eco. Un esempio di tale semplicità lo si può riscontrare quando, in un discorso sulla famiglia, con linguaggio semplice e non dottrinale, affermò che in una famiglia non dovevano mancare mai tre parole: “permesso, grazie, scusa”; discorso, questo, che ha avuto una certa diffusione in comunità e famiglie di fedeli.
Ogni Papa, almeno dal secondo dopoguerra, ha dovuto fare i conti con la modernità, cercando di fare parlare il Vangelo anche nel proprio tempo, ma non senza cercare di comprendere quest’ultimo; in tal modo, anche attirando forti polemiche. Come non ricordare, a riguardo, quelle su Giovanni Paolo II, anche interne alla Chiesa, in tema di immigrazione (l’appello ad accogliere in egual modo gli stranieri di tutte le religioni), di dialogo con le altre religioni (si pensi a quelle forti ricevute con l’incontro interreligioso di Assisi del 1986), l’opposizione alle diverse guerre anche statunitensi, ecc.
Papa Francesco ha ricevuto, probabilmente, ancora più opposizioni, anche se non ha subito lo scisma che visse Giovanni Paolo II con i Lefebriani. Nel caso di Bergoglio, gli ultraconservatori hanno voluto strumentalizzare l’esistenza in vita del precedente pontefice, ritenendo quest’ultimo o ancora il vero Papa o inventando contrapposizioni tra i due; questo, nonostante Benedetto non abbia mai dato seguito a questi atteggiamenti e abbia parlato, a riguardo, di “stolto pregiudizio nei confronti di Francesco”.
I “passi avanti” di Francesco non sono altro, in realtà, che ulteriori applicazioni del Concilio Vaticano II, del quale, per la sua forte carica innovativa, non fu possibile realizzare subito tutti gli obiettivi.
Tali cariche innovative, in particolare quelle di Bergoglio, sono state a volte confuse con cedimenti della dottrina cattolica alla mentalità moderna, ma, in realtà, esse corrispondono piuttosto a quelle che Papa Giovanni XXIII chiamò, in riferimento proprio a quel Concilio, “aggiornamenti”, per una migliore comprensione e applicazione dei principi evangelici al tempo presente con le sue questioni, esigenze, problemi specifici.
Francesco non ha fatto altro che continuare questa linea con, in più, i tratti suoi specifici con cui è riuscito a fare emergere la potente portata misericordiosa della Parola di Cristo che, per dirla con San Paolo, va oltre la legge, quindi non può essere comunque rinchiusa in essa.
Ad esempio, in tema di famiglia, lo stesso Gesù, da un lato, conferma l’indissolubilità del matrimonio; nello stesso tempo, con la samaritana incontrata al pozzo, che aveva avuto cinque mariti e quello con cui viveva era solo il suo “compagno”, Gesù si ferma a parlare e ci diventa amico (per semplificare il racconto), facendo prevalere la misericordia. Alla luce di questo si capisce meglio l’orientamento di Francesco, ivi compresa la sua apertura alle unioni omosessuali e alle coppie non sposate, senza tuttavia equiparare queste ultime ai coniugati.
Infatti, una delle sue espressioni è stata “tutti, tutti, tutti”, intendendo con questo che il messaggio evangelico non poteva arrestarsi dinnanzi a talune categorie di persone o a certe condizioni sociali, proprio per raccogliere tutti nella rete di Cristo.
Francesco, così, è voluto uscire dal quel recinto dei c.d. “valori non negoziabili”, di riuniana memoria – anche perché, in tal modo apparivano rimanere negoziabili, invece, valori come la pace, il perdono, la giustizia sociale – nella convinzione che l’unico valore davvero non negoziabile fosse, in realtà, la misericordia per tutti.
Allora, se è davvero così, ecco che la Chiesa non è più un fortino dentro il quale ci si debba difendere dall’esterno, con le proprie convinzioni, usi e abitudini, ma un tesoro di sapienza e amore che il mondo deve conoscere e senza condizioni, nonché il Vangelo un insegnamento e una pratica che possono guarire tanti. Da qui, quindi, la visione della Chiesa come “un ospedale da campo”, presente in mezzo ai problemi, le angosce, i drammi dell’uomo e che giunge nelle periferie del mondo, sociali, geografiche ed esistenziali. Ne scaturisce il modello, specie con la Evangelii gaudium, della “Chiesa in uscita” che spiazza non pochi in talune parrocchie e che dice che occorre uscire da un atteggiamento difensivo e vittimista, perché in realtà il cristiano ha talenti da dissotterrare e investire. In tale esortazione apostolica, il Papa, come anche nelle sue encicliche, ripercorre le problematiche profonde della società, sforzandosi di comprendere a fondo realtà e cause della povertà, sia materiale che spirituale, nel mondo odierno divenuto talmente economicista per cui oggi gli ultimi, secondo Francesco, non sono più solo gli sfruttati ma lo sono ancor più i c.d. “avanzi”, cioè coloro che non servono (più) nemmeno al sistema di produzione la cui mentalità ha generato la c.d. “cultura dello scarto”. Dinnanzi a questo, vi è l’invito ai cristiani di riscoprire la propria vocazione all’incontro con l’altro e all’annuncio del messaggio evangelico, ricordando che “per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica”.
Nell’enciclica sociale Laudato Sì Francesco invita a sollevare lo sguardo sul mondo intero, in una esistenza in cui l’uomo deve sviluppare il rapporto con Dio come quello con il prossimo e, contemporaneamente, con il Creato, in un’ottica di “ecologia integrale”, consapevole che “il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi”. Così, poi, nella Fratelli tutti, con la critica alla “società sempre più globalizzata che ci rende vicini ma non ci rende fratelli”, Francesco approfondisce il rapporto tra la pace, la fraternità e la giustizia sociale, ponendo ancor di più la Chiesa dinnanzi ai grandi temi per la salvezza dell’umanità partendo da sé stessi e non perdendo mai la bussola del messaggio di Cristo. Si confronta inevitabilmente con il tema del mondo globalizzato a trazione neoliberale, accusando il fatto che talune sue parole d’ordine all’apparenza umanitarie sono, in realtà, espressioni oggi ampiamente strumentalizzate dalla relativa ideologia, quale, ad esempio l’“aprirsi al mondo” che “è stata fatta propria dall’economia e dalla finanza” e che “si riferisce all’apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire senza vincoli né complicazioni in tutti i Paesi”, imponendo, oltre ad oppressione, un modello culturale unico che “unifica il mondo ma divide le persone”, che “ci rende vicini ma non ci rende fratelli”.
Qui, soffermandosi sulla parabola del Buon samaritano si dimostra il valore assoluto della solidarietà e la superiorità della misericordia sull’identità e ruolo sociale, seppur religioso di ciascuno: infatti, il levita e il sacerdote passano avanti dinnanzi all’uomo mezzo morto ma l’eretico si ferma e se ne prende cura. Questo racconto dovrebbe essere già di per sé sufficiente a rispondere a taluni detrattori di Francesco quando richiamano un malinteso concetto di tradizione e identità cristiana per contrapporvisi.
Infatti, dinnanzi a questo porre fortemente la Chiesa dinnanzi ai grandi problemi materiali, e non solo, della società ci sono stati ambienti cristiani, ma anche non cristiani ma che qualche tempo fa si sarebbero chiamato “cristianisti”, secondo i quali Francesco avrebbe esagerato nel parlare troppo dei poveri quanto, invece, avrebbe dovuto soprattutto “parlare di Dio”, e che lo stesso avrebbe scambiato la Chiesa per una ONG. Ora, con questo c.d. “parlare di Dio” occorrerebbe chiedersi cosa si intenda, precisamente, anche prendendo come esempio i precedenti papi in confronto a Bergoglio, o anche Gesù stesso, del quale, leggendo i Vangeli, non vengono riportati tanti suoi discorsi sul Padre quanto i racconti sulle persone con cui entrava in relazione nonché discorsi che richiedevano certi sentimenti e condotte. Lo stesso Gesù, quando parla del Padre, lo fa generalmente nell’ambito della descrizione della relazione con l’altro e soprattutto, appunto, con gli ultimi.
Comunque, Francesco ha ugualmente parlato spesso di Dio, di Maria e di altri santi; ha fatto spesso riferimento a insegnamenti evangelici, come anche si legge nei suoi scritti, quali pure quelli qui citati; cosa, questa, che in ogni caso smentisce, di fatto, quella critica.
Piuttosto, in tanti abbiamo potuto osservare e, chi ha voluto, anche sentire la tenerezza e l’essenza divina nelle parole e nelle azioni del Papa argentino: è così che operano i santi e, mi sento di dire, faceva lo stesso Gesù.
Infatti, la sua opera ha attratto tanti, anche fuori dei confini della Chiesa stessa. D’altronde, anche Gesù stesso subiva critiche simili, anche quando attirava a sé prostitute, pubblicani, samaritani, proprio coloro che erano considerati ai margini della società religiosa dell’epoca, e con i quali ci faceva amicizia: sì, proprio scandaloso; ma chi è senza peccato…
Infatti, Gesù convertiva i cuori più con la misericordia e l’amicizia che con i richiami dottrinali e i suoi insegnamenti ruotavano su questo. Tale esempio sembra avere ispirato Papa Francesco il quale, senza mettere in discussione i principi teologici, ha attratto con la sapienza dell’amore imparata dal Vangelo e distribuita a tutti gli uomini e le donne del mondo. E’ in questo modo che il divino si è manifestato tramite Francesco, perché i concetti e discorsi teologici già ci sono nella Chiesa, potendosi affermare che tale Papa non ha tanto teorizzato quanto fosse buono il pane ma egli lo ha spezzato e distribuito.
Nei primi anni di questo papato, i “profeti di sventura” evocavano pericoli per la Chiesa e una riduzione del legame dei fedeli con essa; invece, non solo Francesco ha riavvicinato tanti ad essa, ma ha attratto anche gente generalmente lontana e scettica o che, comunque, si era allontanata dalla Chiesa da tempo. Recentissima, tra l’altro, è la notizia di un forte aumento di battezzati adulti, quest’anno, nella laicista Francia.
Egli ha saputo suscitare entusiasmi e testimoniato a sempre più gente di come il Vangelo può parlare ad essi ed attrarre il bisogno di senso e di trascendenza di tanti. Ha reso ancor più la Chiesa come un punto di riferimento nella ricerca della pace e della giustizia, rendendo il Papa un “leader” mondiale in questo. Mai si è stancato di invocare e cercare la pace e mai ha risparmiato parole, anche insistenti, per essa, ivi compreso per il massacro di Gaza.
Oserei affermare che Francesco, da un lato, ha evitato di porre la Chiesa in aperto conflitto con il c.d. moderno, dinnanzi al quale essa poteva sembrare quasi “indietro” secondo lo spirito di quest’ultimo però, nel contempo – criticandone, sì, gli errori e avvertendone i pericoli, ma cogliendovi pure le opportunità – ha cercato di porre la Chiesa addirittura davanti al moderno stesso, cioè in una posizione avanzata a questo, però indicandogli una strada differente da percorrere, mostrando così l’annuncio cristiano come una realtà che ancor oggi può fare “nuove tutte le cose”.
Insomma, in tutto questo Papa Francesco si è reso un interprete autentico del Vangelo.
Ne consegue che in questi giorni l’attenzione sulla decisione del conclave è tanta ed e più che comprensibile. Tuttavia, se da un lato può non apparire facile avere da questo conclave un nuovo Francesco, dall’altro è anche vero che lui ha rappresentato un esempio per tanti e un percorso ormai avviato che non può non coinvolgere anche il prossimo pontefice.
Nel frattempo, l’insegnamento di Francesco continua a parlare a noi personalmente, ricordandoci che non occorre essere papa o vescovo per portare avanti il lavoro da lui intrapreso.