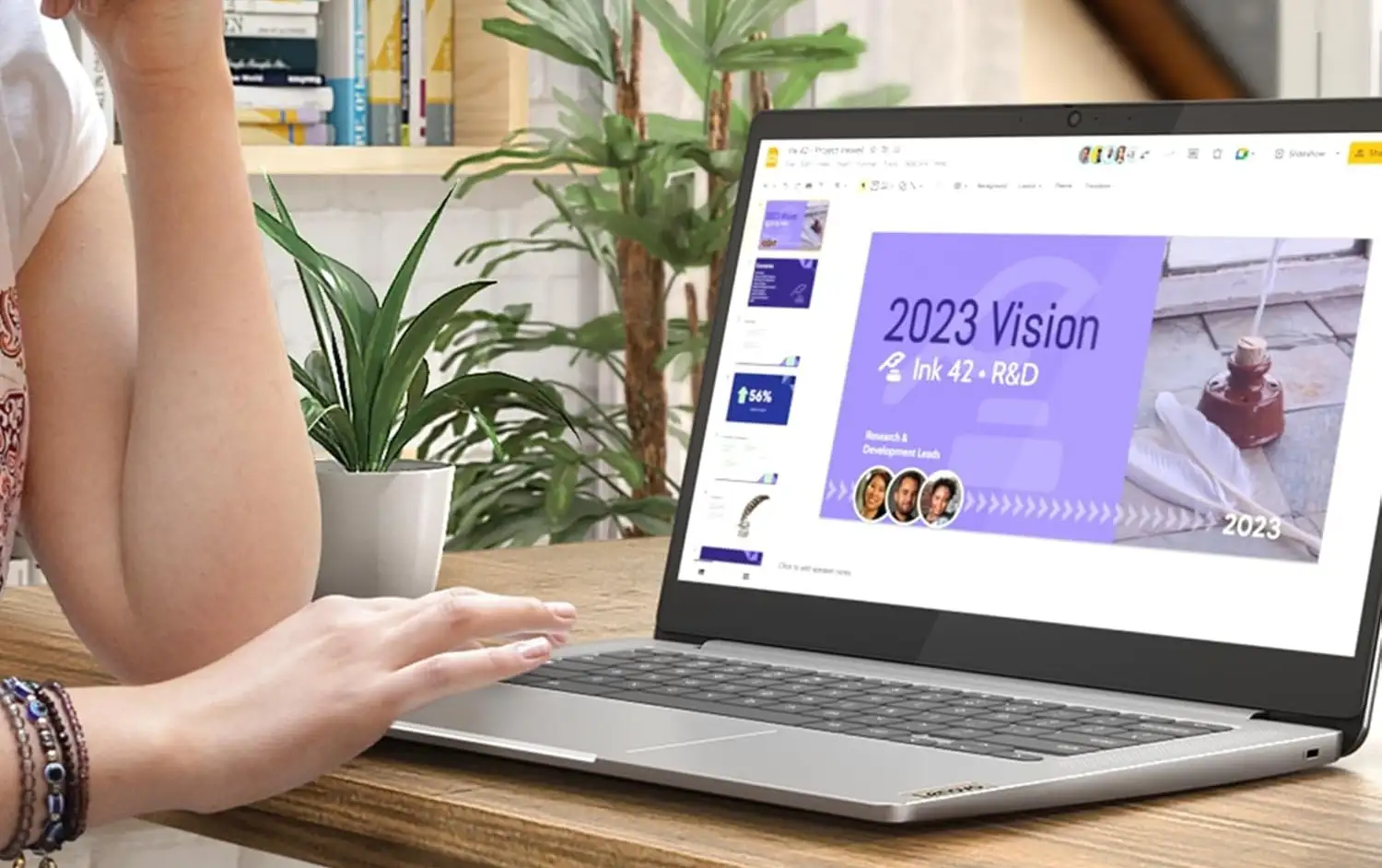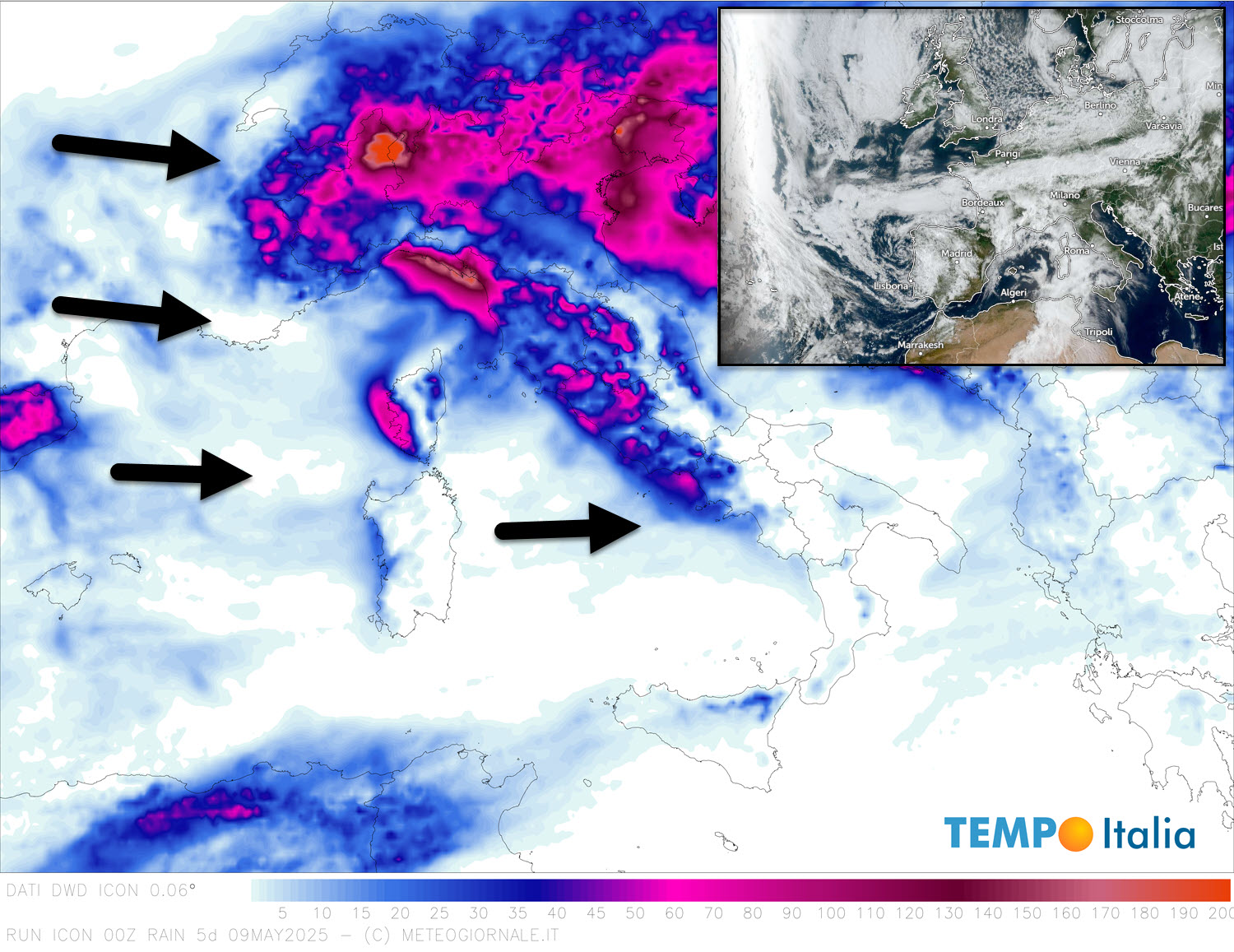Democrazia selettiva
Dall’AfD a Georgescu: quando il sistema decide chi ha diritto di parola e chi no. Non ho alcuna simpatia per l’AfD, sia chiaro. Lo ritengo un partito pericoloso, regressivo, intriso […]

Dall’AfD a Georgescu: quando il sistema decide chi ha diritto di parola e chi no.
Non ho alcuna simpatia per l’AfD, sia chiaro. Lo ritengo un partito pericoloso, regressivo, intriso di pulsioni xenofobe, autoritarie e revisioniste. Ma proprio per questo, la notizia che l’intero partito sia stato classificato come “pericolo per la democrazia” da parte dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione tedesca dovrebbe inquietare anche chi, come me, sta ben lontano da ogni deriva reazionaria. Perché quando uno Stato democratico si arroga il diritto di stabilire non solo ciò che è legittimo, ma anche chi lo è, si apre una voragine.
Non parliamo di atti criminali individuali. Parliamo di interi movimenti politici, rappresentati in Parlamento, sostenuti da milioni di cittadini, che vengono trattati come deviazioni da contenere, sorvegliare, delegittimare. Come se il problema non fosse il disagio sociale che li alimenta, ma la sua manifestazione. Come se fosse più comodo demonizzare che comprendere. O peggio: reprimere che rispondere.
La democrazia liberale, quando funziona, è proprio il luogo dove anche le opinioni più estreme possono esprimersi, a patto che restino nei confini della legalità. Ma se la legalità stessa diventa strumento per zittire, allora la posta in gioco è più alta. Se oggi si dichiara che un partito – per quanto ripugnante nei suoi messaggi – è “incompatibile con la democrazia”, domani chi sarà il prossimo? Un sindacato radicale? Un movimento ambientalista che “minaccia l’ordine economico”? Una lista pacifista che mette in discussione la NATO?
Il paradosso è servito: la democrazia difesa con strumenti non democratici diventa il suo contrario. Per paura di perdere, si autodistrugge.
In questo meccanismo perverso, non è l’AfD a far paura. È l’autocompiacimento di un sistema che, pur di non interrogarsi sulle sue falle, preferisce criminalizzare il sintomo. E chi non ci sta è fuori. Fuori dal dibattito, fuori dalla rappresentanza, fuori dall’immaginario del “cittadino accettabile”.
E qui il caso di Călin Georgescu è illuminante. In Romania, quest’uomo dalla formazione tecnica e dalla retorica identitaria, proposto come candidato alla presidenza, è stato escluso ufficialmente perché, cito testualmente, “non soddisfa i prerequisiti richiesti in tema di difesa dei valori costituzionali”. Tradotto: non piaceva ai vertici. Aveva osato parlare di sovranità, spiritualità, critica delle oligarchie. Non violento, non eversivo, solo non allineato.
E così, l’11 marzo 2025, la Corte costituzionale ha respinto il suo ricorso, sancendo che il popolo non ha nemmeno il diritto di scegliere se votarlo o no. Meglio decidere prima, dall’alto, chi può candidarsi. A seguire, scontri di piazza, condanne internazionali (persino da Elon Musk), e un discorso finale da parte del diretto interessato che ha il sapore di una profezia: “Ho smascherato il demone in tutta la sua orribilità. Ora, una volta che si vede che aspetto ha l’inferno, la scelta spetta a voi.”
No, non sto sostenendo Georgescu. E no, non sto legittimando l’AfD. Sto chiedendo se una democrazia che censura, silenzia, marginalizza è ancora degna di questo nome. Se la libertà è solo quella degli allineati, o anche quella di chi disobbedisce. Perché ciò che rende una democrazia autentica non è l’omogeneità del pensiero, ma la capacità di contenere, assorbire, dialogare con il dissenso.
E qui torniamo al punto: il vero pericolo per la democrazia non è l’estremismo. È l’establishment che rifiuta di ascoltare. È la sinistra che si rifugia nella morale, ma dimentica il sociale. È il centro che si crede neutrale, ma difende solo lo status quo. È la destra che finge di opporsi, ma si nutre dello stesso consenso rabbioso, senza offrire nessuna visione.
C’è una crisi di rappresentanza profonda in Europa. I popoli si allontanano, i tecnocrati si blindano, i media filtrano, i partiti si accartocciano. In questo vuoto, l’AfD diventa sfogo. Georgescu, simbolo. Non perché siano risposte giuste, ma perché sono le uniche visibili.
E così, mentre ci congratuliamo per aver messo al bando un partito pericoloso, lasciamo campo libero al vero veleno: l’arroganza dei giusti, la censura dei perbenisti, la smania di controllo di chi teme il popolo ma non lo ama.
La vera risposta all’estrema destra è giustizia sociale. Redistribuzione. Dignità. Cultura critica. Rappresentanza vera. Non sorveglianza, non interdizione. Se togli voce al disagio, resta solo il grido. E se la politica non lo accoglie, lo raccoglierà il populismo peggiore.
Una democrazia senza popolo è solo una burocrazia con le urne. Un rito svuotato. Una costituzione imbalsamata. E nessun allarme antifascista di comodo può salvarla da se stessa.
Serve coraggio, non conformismo. Domande, non etichette. Più parole, meno esclusioni. Perché se oggi silenzi l’AfD o Georgescu solo perché ti fanno paura, domani potresti scoprire che è il tuo turno.
E sarai solo.
Ma ciò che inquieta ancora di più è l’ipocrisia selettiva con cui si decide chi rappresenta un pericolo e chi no. Le pulsioni autoritarie non abitano solo a destra. Ci sono Stati, governi, apparati che esercitano un controllo silenzioso, elegante, apparentemente legittimo, ma profondamente censorio. Non serve il manganello per reprimere: bastano le circolari. Non servono i gulag: bastano le blacklist.
L’Europa che si erge a paladina della democrazia è la stessa che firma accordi con regimi che imprigionano giornalisti. È la stessa che si scandalizza per l’avanzata dei sovranismi ma si dimentica di come ha umiliato la Grecia, derubricato le proteste sociali a “folklore”, ignorato la fame e la rabbia in periferia. È la stessa che oggi tappa la bocca a Georgescu e domani magari metterà sotto osservazione un movimento studentesco che osa contestare la NATO.
Non si tratta di sottovalutare il rischio dell’estrema destra. Né di legittimare chi ne sposa i dogmi. Ma se l’unica risposta che la democrazia sa dare è chiudere le porte, allora c’è un problema. Il populismo non nasce dall’eccesso di libertà, ma dal suo vuoto. Dalla sensazione che il voto non conti, che la voce non valga, che l’alternativa non esista. E quando tutto sembra già deciso, anche il grido più scomposto appare una forma di partecipazione.
La storia è piena di episodi in cui ciò che era considerato “pericoloso”, un giorno si è rivelato necessario il giorno dopo. La Resistenza stessa, in molti contesti europei, fu bollata come “eversione”. I movimenti operai furono perseguitati come “anti-sistema”. Eppure, senza di essi, non avremmo né diritti né costituzioni da difendere. Oggi si grida al pericolo dell’AfD, domani si griderà contro chi contesta le guerre “giuste”, poi contro chi propone una riforma fiscale troppo radicale. È una catena che non finisce mai.
Anche il linguaggio tradisce la deriva. Chi decide cosa è “disinformazione”? Chi stabilisce quando una notizia è “complottista”? Chi controlla i controllori? Nell’era degli algoritmi, del fact-checking pilotato, delle campagne stampa fotocopia, la verità è spesso un algoritmo politico. E il dissenso diventa disturbo. Quello che serve non è più la voce scomoda, ma quella addomesticata.
L’informazione è parte di questo meccanismo. L’AfD, ad esempio, viene ridotta a una sigla di odio, senza raccontarne le radici sociali. Georgescu viene presentato come un santone delirante, senza analizzare le sue proposte. I media non spiegano: semplificano. Non approfondiscono: etichettano. Perché un cittadino informato può scegliere, ma un cittadino impaurito obbedisce.
E così la democrazia si trasforma in un recinto. Protetto, ordinato, perfetto. Ma sterile. Dove tutto è permesso finché non disturba, finché non mette in discussione, finché non propone davvero un’altra visione. Un recinto dove il potere si traveste da pluralismo e la censura da responsabilità.
Il caso di Georgescu, nel suo piccolo, ha rivelato questa nudità del potere. La Romania, Paese membro dell’UE, ha impedito a un candidato legittimo di correre alle elezioni. Non per reati, non per terrorismo, ma per idee. Idee discutibili, forse. Ma idee. E il silenzio delle istituzioni europee è stato assordante. Come se la legittimità democratica fosse una concessione, non un diritto.
Alla fine, ciò che rimane è un’Europa stanca, spaventata, impaurita dal suo stesso popolo. Che alza muri contro l’immigrazione, ma anche contro il dissenso. Che parla di libertà, ma chiude le porte. Che celebra la democrazia come icona, ma ne dimentica la pratica.
E allora, forse, vale la pena tornare a chiederci: cos’è davvero la democrazia? È il governo dei migliori? Dei più accettabili? O è il governo di tutti, anche di chi ci disturba, ci provoca, ci costringe a pensare? Perché se rinunciamo a questa domanda, se scegliamo la sicurezza dell’omologazione, allora la democrazia è già finita. Solo che ancora non lo abbiamo capito.
Non è un caso che in questo clima di esclusione e sospetto, il ruolo dei media diventi cruciale. Ma non per informare: per recintare. Chi esprime posizioni disallineate — anche solo per interrogarsi — viene immediatamente bollato come estremista, complottista, o peggio, pericoloso. I giornali titolano con parole come “minaccia”, “rischio”, “deviazione”, senza mai soffermarsi sul contenuto, sulle cause sociali e culturali che alimentano queste voci.
In questo, la stampa non fa più da cane da guardia del potere, ma da filtro. Decide chi è degno di parola e chi no. Un’informazione che si comporta come tribunale etico ha già tradito la sua funzione. La libertà di stampa, infatti, non è solo la libertà di chi scrive, ma anche — e soprattutto — quella di chi legge. E se al lettore non arriva che una sola narrazione, rassicurante e sterilizzata, quella non è democrazia: è pedagogia travestita da pluralismo.
In un simile contesto, anche la sinistra, quella che si vuole radicale e alternativa, ha le sue responsabilità. Quando l’unico metro di giudizio diventa la correttezza ideologica, si finisce per confondere la critica con la devianza. Ma la politica non è una cattedra. È un campo di battaglia sociale, dove si ascolta, si capisce, si cambia. Altrimenti resta solo accademia che si guarda allo specchio, mentre il Paese reale si rifugia nei peggiori porti sicuri.
Pasolini, che non era certo tenero né con il potere né con il popolo, ci aveva messo in guardia decenni fa: la vera repressione non è più nei manganelli, ma nel consenso pilotato. Nella costruzione del cittadino ideale, obbediente, indignato solo quando gli viene concesso. Oggi, quel cittadino ideale sembra fatto per assorbire ogni notizia senza metterla in discussione, purché venga da fonti certificate. Eppure, il pensiero critico è proprio ciò che distingue una società viva da una disciplinata.
Se non si recupera il senso della complessità, se non si restituisce al cittadino il diritto di dubitare, discutere, disobbedire — entro i limiti della Costituzione — la democrazia si riduce a un simulacro.
Il vero antifascismo, oggi, non è solo memoria del passato, ma vigilanza sul presente.
Ed è dovere di chi scrive, denuncia o semplicemente osserva, non smettere mai di fare domande.
Anche a costo di restare scomodo.