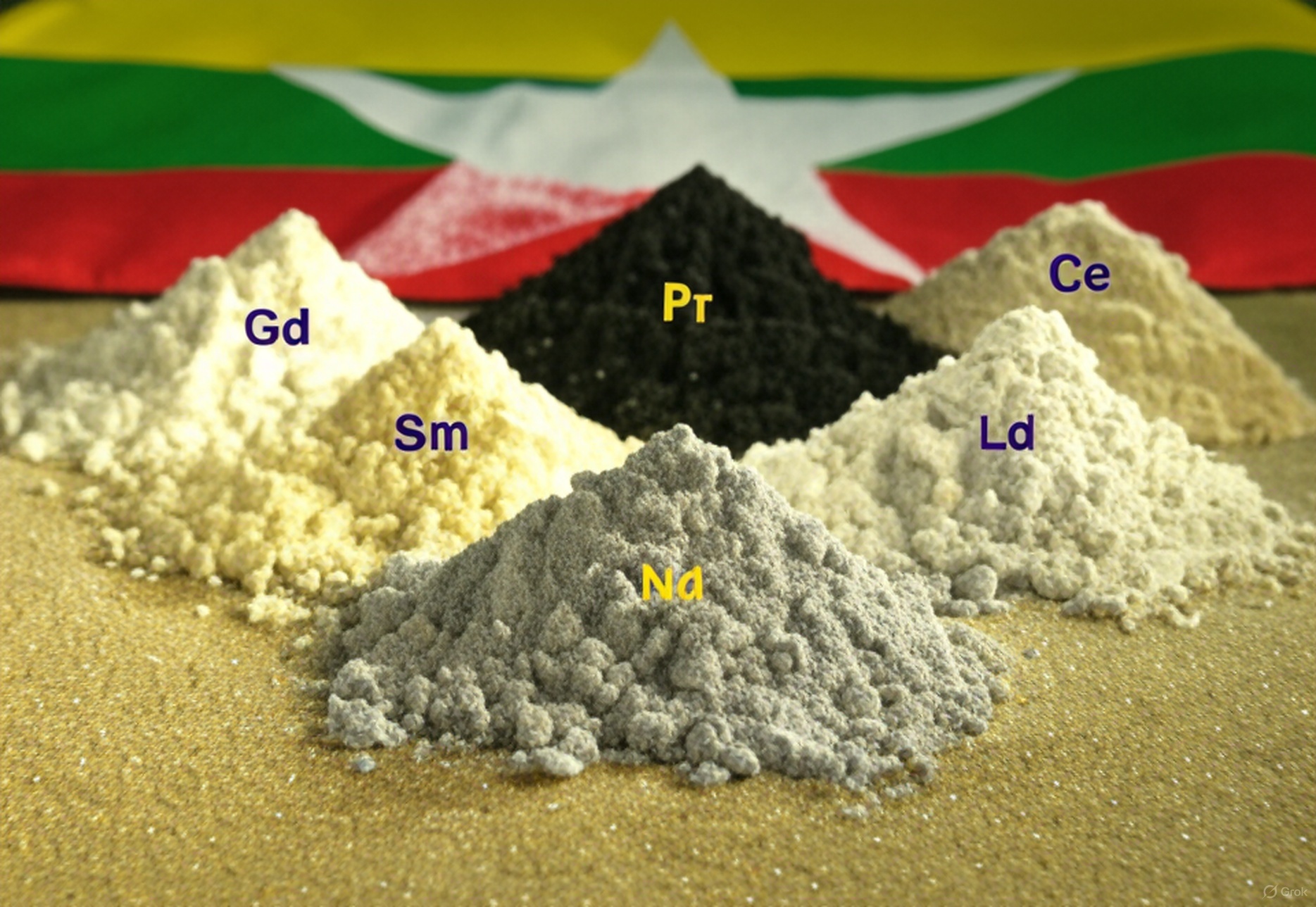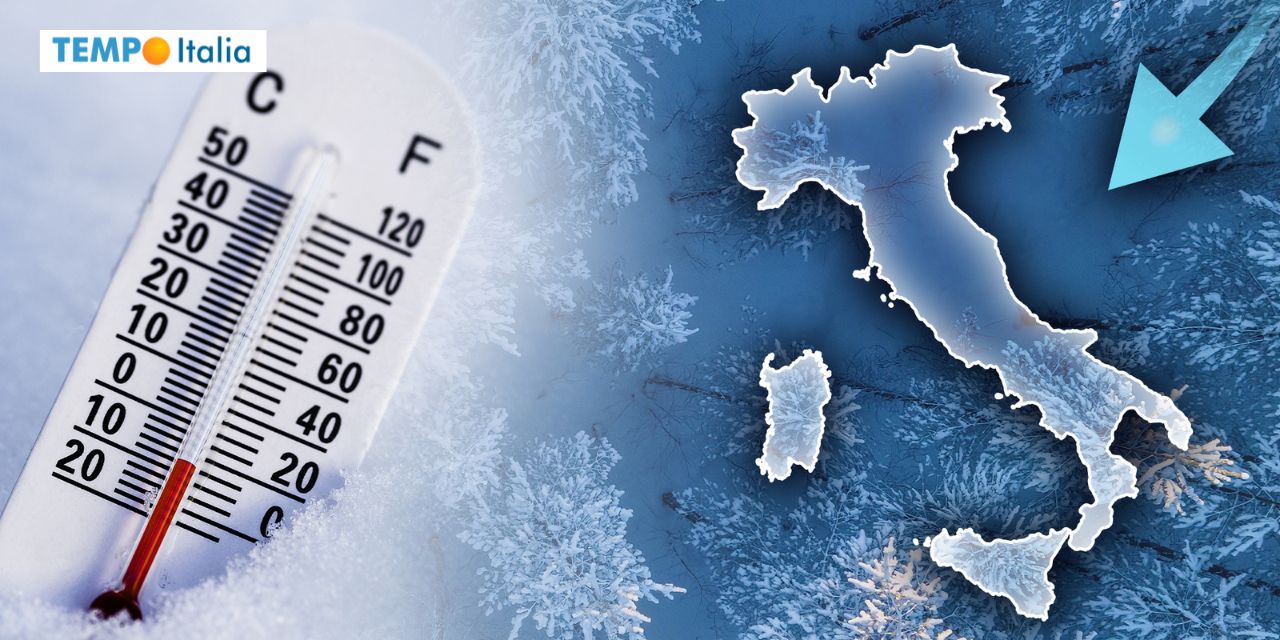Il paradosso della smart economy? Prodotti sempre più intelligenti per consumatori sempre più ignoranti
Logiche e strumenti di marketing pensati per migliorare i rapporti fra le imprese e i loro clienti possono diventare nocivi per la comunità se diffusi su larga scala senza responsabilità e senso critico, in modo malevolo, spregiudicato e opportunistico. A sostenerlo Paolo Guenzi, docente di Marketing e Vendite all’Università Bocconi e in SDA Bocconi School of Management che anticipa per i nostri lettori alcuni dei temi del suo libro "Il Marketing dell'ignoranza", edito da Egea

Quali sfide attendono la società di domani? Quali sono i rischi e quali le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico? Per la rubrica “Futuro da sfogliare” un estratto del libro Il marketing dell’ignoranza di Paolo Guenzi, edito da Egea.
***
Nelle società contemporanee molte persone hanno una vera e propria ossessione per la tecnologia, ne accettano acriticamente qualsiasi sviluppo, affascinate dalle aspettative di progresso che la accompagnano. Ci vorrebbe un po’ più di equilibrio. La mia opinione sulla tecnologia è semplice e non particolarmente originale: la tecnologia in sé non è buona o cattiva, dipende dall’uso che se ne fa. E questo uso dipende soprattutto dalla capacità di giudizio e dal profilo morale degli esseri umani che la utilizzano.
Viviamo in una società in cui la tecnologia ha raggiunto livelli tali da rischiare di sfuggire al nostro controllo: si pensi all’energia atomica, all’intelligenza artificiale, alle biotecnologie… Per questo l’ignoranza (intesa in senso lato, quindi anche come assenza o carenza di capacità di ragionamento e spirito critico) è un formidabile moltiplicatore dei rischi e un potentissimo riduttore delle opportunità delle tecnologie. Questa considerazione mi porta a formulare alcune riflessioni sul rapporto fra ignoranza e tecnologia.
Viaggio nella smart economy
Una delle macrotendenze principali nei rapporti fra aziende e consumatori è il proliferare di prodotti cosiddetti “intelligenti”: la parola magica, inevitabilmente anglosassone, è smart. Dallo smartphone allo smartwatch fino alla smart tv, la promessa dei produttori è quella di offrire ai propri clienti prodotti che incorporano qualche forma di intelligenza: dal materasso che impara ad adeguarsi alla forma del corpo di chi ci dorme sopra all’automobile che si guida da sola.
Nella maggior parte dei casi l’obiettivo dei prodotti smart consiste nel rendere più semplice la vita dei consumatori, nel ridurre i loro errori. Un forno che non brucia le torte, un miscelatore che non sbaglia il dosaggio degli ingredienti impediscono agli umani di incorrere nella fatica della sperimentazione e nell’imbarazzo sconfortante del fallimento.

Intendiamoci, non sono masochista o autolesionista: posso comprendere i benefici offerti da questi prodotti, e giungere persino ad apprezzarne l’ingegnoso funzionamento. Per molti consumatori (penso per esempio alle persone anziane o con varie forme di disabilità) queste soluzioni sono la manna dal cielo, e dobbiamo tutti essere grati a chi le ha sviluppate.
Ma fermiamoci per un attimo a ragionare sulle conseguenze di questa tendenza, allorché diventi pervasiva, sulla società nel suo insieme. Credo che a livello sistemico all’aumentare dell’intelligenza dei prodotti corrisponda necessariamente, o comunque con un alto grado di probabilità, una generale riduzione dell’intelligenza degli esseri umani che li acquistano, utilizzano e consumano. Lo sviluppo della conoscenza – e dell’intelligenza in senso più lato – deriva infatti in buona parte dall’apprendimento che scaturisce dagli errori. Si impara facendo e, soprattutto, sbagliando. Chi non affronta mai problemi, difficilmente impara a risolverli.
Leggi anche: Dietro le quinte di Meta. Vi svelo come funziona il marketing su Facebook e Instagram
È una società che nel suo complesso punta a prevenire qualsiasi problema o a eliminare gli errori sta paradossalmente minando una componente essenziale del proprio progresso collettivo. Sempre più gli umani delegano a macchine attività noiose, difficili o rischiose. Ripeto, in molti casi ciò è logico, utile e meritorio, ma in numerose circostanze non lo è.
E, se portato all’eccesso, se generalizzato, questo fenomeno rischia di avere conseguenze negative indesiderate e imprevedibili. Disincentiva lo sforzo individuale, la fatica, la curiosità, la gestione della frustrazione, la tensione al miglioramento. A questo proposito, lo sviluppo impetuoso dell’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare l’apoteosi di questo fenomeno e un punto di non ritorno nella storia dell’umanità.
Una vita più semplice non è sempre e necessariamente il preludio a un’esistenza più appagante. L’aspirazione di una vita senza errori e senza rischio ha spesso come corollario l’assenza della responsabilità. Se una macchina decide per me ciò che è meglio fare (ammesso che ciò succeda davvero), mi abituo a non assumermi la responsabilità di scegliere che cosa sia meglio fare e come, a partire da un’infinità di piccoli gesti quotidiani: è il satellitare che mi suggerisce quale strada sia preferibile percorrere, sono gli algoritmi che selezionano quale musica farmi ascoltare, e così via. È davvero una forma di progresso, tutto ciò?
Una società che culturalmente decide di affidare la responsabilità di scelta a qualcuno o qualcos’altro, che disincentiva o delegittima l’apprendimento dagli errori, che vuole sempre e comunque semplificare la vita di tutti tenderà a creare prodotti e servizi sempre più intelligenti, perché le persone alle quali sono destinati lo sono e lo saranno sempre meno.
Sensi senza senso
In un’ottica più allargata gli sviluppi tecnologici rischiano (e in parte già lo fanno, con prospettive di ulteriore aggravio della situazione) di generare una fondamentale ignoranza non solo del mondo e della realtà che ci circonda, ma anche di sé, nel senso che possono provocare un impoverimento sostanziale dell’autoconsapevolezza dell’individuo.
Innanzitutto questo avviene facilitando la costruzione di una pseudo-identità basata sulla narrazione a sé e agli altri via social media di una pseudo-vita che provoca un allontanamento dalla realtà che magari può essere terapeutico se temporaneo o applicato in certe situazioni, ma che diventa malato se permanente e diffuso su larga scala.
In secondo luogo la progressiva perdita della consapevolezza di sé scaturisce dalla virtualità sensoriale causata dall’impiego di strumenti tecnologici, nell’interazione con gli altri e con il mondo in generale, che impoverisce sensi quali il tatto e l’olfatto. E quando le tecnologie basate sulla realtà aumentata o virtuale prometteranno di risolvere questo problema, si genererà (come già accaduto per i contenuti testuali, musicali o visivi) la spiralizzazione dei sensi, per cui per esempio ci verranno riproposti profumi coerenti con i nostri gusti e comportamenti pregressi, promuovendo così la replicazione sistematica degli stessi modelli sensoriali e quindi degli stessi meccanismi di assuefazione ripetitiva sperimentati dall’impiego degli algoritmi sino a oggi utilizzati per gli altri sensi.

Il punto terminale di questo processo sarà costituito dalla virtualità emotiva, quando ologrammi alimentati da intelligenza artificiale potranno sostituirsi agli esseri umani per soddisfare i nostri bisogni emotivi e trasmetterci consolazione o euforia, completando la sostituzione della spesso faticosa vita concreta con un paradiso artificiale multisensoriale arricchito da emozioni posticce.
Quando la pseudo-vita avrà preso il sopravvento, fornendo possibilità impensabili nel passato, o comunque nuove forme di soddisfacimento di bisogni, si potranno comprare sogni e illusioni artificiali per fuggire dalla realtà (una nuova forma di droga, in fondo), si potrà dare nuovo sfogo a fantasie e perversioni (volendo si potrebbe persino uccidere o essere uccisi realmente in videogiochi appositi), si potranno prendere identità altrui e vivere vite altrui, forse si potrà comunicare con il pensiero e trasferire l’intera coscienza da un essere vivente a un altro oppure ad artefatti virtuali.
In questa prospettiva ambienti fittizi come il metaverso potrebbero alla lunga avere un grande successo, perché costituiscono la tempesta perfetta, una mirabile sintesi dell’intersezione, estremizzata, dei valori di immaterialità, futilità, unicità che connotano la società del marketing dell’ignoranza.
Soprattutto in considerazione dello sviluppo dell’intelligenza artificiale le potenzialità sono enormi, in senso sia positivo che negativo: ottimisti e pessimisti possono fornire interpretazioni opposte, perché tutto dipende da come le tecnologie sono e saranno utilizzate. E questo dipende dalla capacità di giudizio e dalla morale del genere umano.
I rischi del cattivo impiego delle tecnologie sono enormi, e l’ignoranza di massa (a partire dalla disinformazione e dalla mancanza di conoscenza, riflessione critica e consapevolezza su questi aspetti e sulle loro possibili conseguenze) promette di esserne uno straordinario moltiplicatore.
Per questo va combattuta in tutte le sue forme, con un colossale sforzo di promozione dell’informazione, della capacità di analizzare la realtà, del dialogo e del confronto, del pensiero critico, dell’esercizio del dubbio, del metodo scientifico, dell’umiltà di ascoltare e di mettersi in discussione.
La verità, interpretabile secondo Popper come “connivenza critica”, cioè temporaneo accordo fra il maggior numero possibile di esperti indipendenti in un dato ambito, può essere concepita come un bene pubblico per il genere umano.
In un mondo contemporaneo popolato da miliardi di micro-editori di contenuti sui social network di fatto incontrollabili in rete, chi crea esternalità negative generando, diffondendo o promuovendo disinformazione e falsità dovrebbe essere preventivamente dissuaso dal farlo (semplicemente applicando online le stesse proibizioni e sanzioni previste al di fuori del contesto digitale) e chiamato a contribuire a rimediare al danno procurato, come si fa per esempio tassando pubblicamente i carburanti che inquinano: allo stesso modo le piattaforme di social networking potrebbero essere tassate per finanziare i costosissimi sistemi di controllo che oggi non esistono o sono largamente insufficienti.