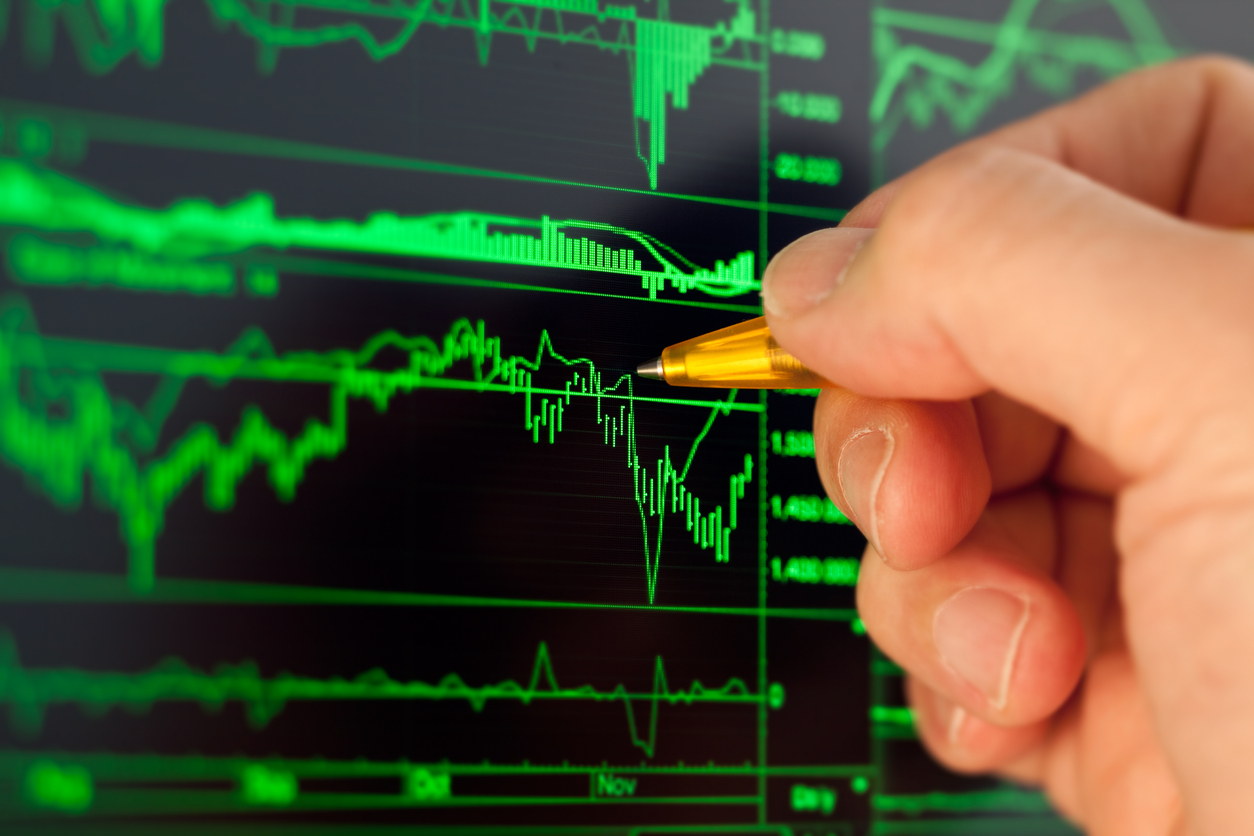I segni del presente e le difficoltà di pensare il nuovo
La condizione tragica dell’uomo L’uomo è l’unico essere vivente capace di scegliere consapevolmente la morte per qualcosa che giudica più importante della propria sopravvivenza: la libertà, la dignità, la fedeltà […]

La condizione tragica dell’uomo
L’uomo è l’unico essere vivente capace di scegliere consapevolmente la morte per qualcosa che giudica più importante della propria sopravvivenza: la libertà, la dignità, la fedeltà a un principio. Questa possibilità, paradossale e profondamente umana, nasce dalla nostra condizione mortale e, allo stesso tempo, la riflette. Proprio perché sappiamo di essere finiti, costretti a confrontarci con il limite della morte, siamo spinti a produrre senso, a cercare direzioni che diano valore e orientamento alla nostra esistenza.
Questa relazione è circolare: la consapevolezza della morte genera il bisogno di senso, e il senso che costruiamo può arrivare a rendere accettabile, perfino necessaria, la scelta della morte per qualcosa che consideriamo superiore.
Le società umane, infatti, non possiedono un fine immanente, inscritto nella loro natura: devono darselo. Hanno bisogno di costruire scopi, significati condivisi, visioni collettive del vivere insieme.
Umanizzarsi significa allora entrare in questo processo di costruzione culturale: dar forma alla propria vita e a quella della comunità attraverso narrazioni, valori, orientamenti che ci permettono non solo di convivere, ma di dare un senso al nostro essere mortali.
Non dobbiamo confondere la formalizzazione dei significati — come li troviamo espressi nelle leggi, nelle norme o nelle istituzioni — con il loro reale processo di nascita. I significati autentici prendono forma nell’esperienza vissuta: si generano attraverso i comportamenti collettivi, le pratiche quotidiane, le relazioni, le emozioni e i desideri delle persone concrete. Essi cambiano con il tempo e variano da una società all’altra, perché riflettono ciò che gli esseri umani rappresentano gli uni per gli altri in un determinato momento storico: quali valori condividono, quali obiettivi si pongono, cosa giudicano degno o indegno.
In questo senso, l’essere umano è al tempo stesso creatore e creatura della storia: da un lato costruisce significati, dall’altro è modellato dalle circostanze storiche e culturali in cui vive. I significati non sono mai assoluti, ma vanno sempre compresi nel contesto in cui emergono.
Oggi, in un’epoca di profonda transizione, è fondamentale imparare a leggere i segni del presente, interpretare ciò che accade non solo in superficie, ma nel suo valore simbolico e umano. Questo ci permette di cogliere le aspirazioni, i bisogni e le rappresentazioni che muovono le persone.
Serve pazienza, ascolto e attenzione per riconoscere quello che un tempo si chiamava “spirito del tempo” (Geist der Zeit). Solo così possiamo porre le domande giuste e cercare risposte che siano all’altezza della complessità del mondo in cui viviamo.
Fascismo e democrazia: la fragilità della libertà
Forse molti non ricordano — o non sanno — che negli anni ’60 lo psicologo Stanley Milgram condusse un esperimento destinato a diventare uno dei più inquietanti nella storia della psicologia sociale. L’obiettivo era semplice e spietato: capire fino a che punto persone comuni fossero disposte a obbedire a un’autorità, anche quando ciò comportava infliggere dolore a un altro essere umano.
Ai partecipanti, individui ordinari scelti tra la popolazione, venne detto che stavano partecipando a uno studio sull’apprendimento. A ogni errore commesso da un presunto “allievo” (in realtà un attore), essi dovevano somministrare una scossa elettrica, aumentando progressivamente l’intensità. Sebbene le scosse non fossero reali, i partecipanti non lo sapevano, e continuavano a colpire l’altro con scosse apparentemente dolorose, nonostante le grida, le suppliche e i silenzi, semplicemente perché una figura in camice, autoritaria e calma, diceva loro di continuare.
Il risultato fu scioccante: una grande maggioranza dei partecipanti arrivò fino alla fine, infliggendo quella che credevano essere una scarica potenzialmente letale. Non erano mostri, né fanatici: erano persone normali, capaci di compiere azioni gravissime pur di non mettere in discussione l’autorità. Questo ci dice che la sottomissione cieca non è una patologia rara, ma una possibilità reale e presente in ogni essere umano, se inserita in un certo contesto.
È qui che emerge, con forza, la fragilità della libertà. Non è un bene naturale, stabile e garantito: è una possibilità che va difesa e coltivata ogni giorno, all’interno delle strutture sociali che la rendono praticabile. Quando queste strutture — le istituzioni, le regole condivise, i codici simbolici — funzionano, ci orientano, rendono comprensibili le nostre azioni e ci permettono di fidarci degli altri. Ma quando queste forme si sgretolano, tutto diventa ambiguo: le parole feriscono, i gesti si deformano, la fiducia si dissolve, e il legame sociale si spezza.
Proprio a partire da questa consapevolezza — che l’obbedienza cieca è una possibilità umana ordinaria, non una devianza eccezionale — possiamo comprendere come certi fenomeni storici, troppo spesso liquidati come “mostruosità del passato”, in realtà rappresentino potenzialità sempre latenti.
Il fascismo, da questo punto di vista, non è un incidente anomalo o irripetibile, ma una risposta autoritaria a un bisogno profondo e ricorrente: quello di ordine, sicurezza, protezione. Ogni volta che un contesto di crisi spinge l’individuo a rinunciare alla propria autonomia in nome di un ordine percepito come necessario o salvifico, quella possibilità torna ad attivarsi.
Il male, in questa prospettiva, non si presenta con sembianze straordinarie: è insidioso proprio perché si radica nella normalità, si ammanta di razionalità, si nutre dei nostri bisogni non risolti. La banalità del male — per dirla con Hannah Arendt — non è un paradosso, ma un monito: il totalitarismo può nascere anche dalla routine, dall’abitudine ad obbedire, dalla rassegnazione, dalla paura del disordine.
Per questo la democrazia non è mai una conquista definitiva, ma un equilibrio fragile tra forze opposte: libertà e autorità, autonomia e protezione. Essa è un tentativo sempre incompleto di evitare che una di queste spinte diventi assoluta e travolga l’altra. E il rischio non si manifesta solo nella violenza aperta, ma anche nella normalizzazione dell’obbedienza, nel desiderio di certezze, nella tolleranza passiva verso forme di esclusione e sopraffazione.
Ogni società, del resto, ha sempre cercato di gestire la propria violenza interna proiettandola verso l’esterno: Atene contro Sparta, Roma contro i barbari, lo Stato-nazione contro l’invasore. Ma oggi, in un’epoca in cui i confini degli Stati, delle classi e delle ideologie si sfaldano, la guerra si riconfigura come conflitto diffuso, trasversale, spesso invisibile: una lotta di tutti contro tutti. In questo contesto, le democrazie liberali — nate per neutralizzare il conflitto attraverso il diritto — mostrano tutta la loro difficoltà ad arginare una violenza che non ha più un nemico esterno riconoscibile, ma che attraversa silenziosamente i rapporti quotidiani.
Invocare la pace, allora, può diventare un gesto retorico se non si ha il coraggio di affrontare le cause strutturali del conflitto. Spesso si immagina la pace come ritorno a un ordine perduto, come se esistesse una neutralità a cui basti semplicemente tornare. Ma la pace senza giustizia è un’illusione: una forma di autoassoluzione che evita di interrogarsi sulle disuguaglianze e le ferite che hanno generato il conflitto stesso.
Non esistono alternative preconfezionate. Ogni autentico cambiamento deve partire da una lettura onesta della realtà, capace di individuare le condizioni concrete da cui muovere. E se queste condizioni non esistono ancora, allora ogni azione rischia di trasformarsi in un gesto donchisciottesco, solitario e inutile — un’utopia che si infrange contro l’indifferenza dei fatti.
Globalizzazione e protezionismo: due volti dello stesso paradigma neoliberista
La globalizzazione, intesa come processo di estensione planetaria dei rapporti sociali fondati sullo scambio mercantile, ha prodotto effetti tanto inevitabili quanto distruttivi. Se da un lato essa ha promesso di abbattere barriere e connettere il mondo, dall’altro ha accentuato fratture profonde tra società e sistemi produttivi, con impatti devastanti sulle persone e sull’ambiente.
I processi di delocalizzazione industriale, ad esempio, hanno spostato la produzione verso paesi con legislazioni sul lavoro meno tutelanti e salari più bassi — come la Cina — contribuendo allo svuotamento dei sistemi sociali nei paesi d’origine e allo scarico dei costi ambientali e umani su scala globale. Questo squilibrio ha aggravato le disuguaglianze tra le nazioni e ha generato una vulnerabilità sistemica, in cui il benessere di alcuni si fonda sulla marginalizzazione di altri.
In tale contesto, il ritorno al protezionismo — come dimostrato dalle politiche dell’amministrazione Trump — non rappresenta una reale alternativa alla globalizzazione, ma piuttosto una risposta interna allo stesso impianto ideologico. Infatti, benché proponga la difesa delle economie nazionali, il protezionismo resta ancorato ai principi fondamentali del mercato: competitività, produttività, innovazione e centralità del profitto. In questo senso, globalizzazione e protezionismo sono due facce della stessa medaglia, entrambe radicate nel pensiero neoliberista.
Il protezionismo non supera la contraddizione originaria del capitalismo globale; la ridisegna, spostando il conflitto da una dimensione tra centri e periferie a una lotta interna tra un capitalismo tecnocratico e cosmopolita e uno nazional-populista e localistico. La frattura non viene risolta, ma semplicemente ricollocata lungo nuove linee ideologiche e geopolitiche. Nel frattempo, resta irrisolta la tensione strutturale tra lo sviluppo delle forze produttive e i vincoli imposti dai rapporti sociali esistenti.
Questa contraddizione produce una crisi che non è solo economica, ma anche politica, culturale e istituzionale. Le istituzioni democratiche costruite nel dopoguerra — governi rappresentativi, parlamenti, sistemi di welfare, movimenti sociali — appaiono oggi svuotate di senso e inefficaci nel fronteggiare le disfunzioni del modello globale. La semplice osservanza formale dei meccanismi democratici non è più sufficiente a garantirne la sostanza.
Al contrario, assistiamo a un’involuzione autoritaria: la democrazia viene svuotata dall’interno, le sue fragilità sfruttate da forze reazionarie che promuovono ideologie escludenti, ridimensionano i diritti fondamentali e legittimano l’uso della crudeltà nel discorso pubblico. Il razzismo, la violenza verbale e l’esclusione sociale tornano a occupare spazi centrali nella narrazione politica.
In questo scenario, il neoliberismo ha avuto un ruolo decisivo. Esaltando l’individualismo, il successo personale e la competizione permanente, ha minato le basi della solidarietà e del senso di comunità. Il dolore dell’altro è diventato un dettaglio irrilevante, l’empatia un ostacolo alla prestazione. Il discredito gettato sulla cosiddetta “correttezza politica” — al netto delle sue ambiguità — ha sancito il fallimento di ogni tentativo di mediazione e convivenza, aprendo la strada alla polarizzazione, alla brutalizzazione del linguaggio e alla normalizzazione dell’intolleranza.
In conclusione, globalizzazione e protezionismo non sono opposti ma complementari o, meglio, due facce della stessa medaglia: entrambi affondano le loro radici nel paradigma neoliberista, che, anziché risolvere le crisi che genera, le riproduce sotto forme nuove e sempre più distruttive.
Tra solitudine e potenza: ripensare la libertà oltre il neoliberismo
In continuità con questi sviluppi, emerge con forza una crisi che non si limita alla sfera economica o politica, ma investe i valori, i legami sociali e la tenuta stessa della convivenza democratica. Le trasformazioni del mondo contemporaneo, alimentate da logiche mercantili e da una visione tecnocratica del progresso, hanno progressivamente messo a nudo le fragilità strutturali delle democrazie liberali. L’incapacità delle istituzioni di governare processi sempre più interconnessi ha aperto la strada a nuove forme di autoritarismo, spesso legittimate da un senso diffuso di insicurezza e frustrazione.
Ma questo regresso democratico non è frutto esclusivo di dinamiche esterne. Esso si alimenta delle contraddizioni interne ai nostri sistemi politici e sociali: la crescente precarietà esistenziale, la perdita di fiducia nei corpi intermedi, l’erosione del senso di appartenenza collettiva. È proprio lo scarto tra le potenzialità aperte dallo sviluppo tecnico-produttivo e i limiti imposti dalle relazioni sociali esistenti che genera il conflitto strutturale in cui siamo immersi. Un conflitto che non viene mai risolto, ma continuamente riformulato, rimanendo privo di una direzione trasformativa capace di incidere sulle sue cause profonde.
In questa fase di transizione storica, i paradigmi che dominano il discorso pubblico appaiono incapaci di immaginare alternative reali. Come aveva intuito Marx già nell’Ottocento, le forze produttive sviluppate dalla civiltà borghese diventano troppo potenti per essere contenute nei rapporti sociali che le hanno generate, fino a ostacolarli e minacciarne la stessa riproduzione. L’eccesso di mezzi — tecnologie, produzione, comunicazione — si trasforma così in un paradosso: anziché favorire l’emancipazione, approfondisce le disuguaglianze e alimenta crisi sempre più ricorrenti.
La politica contemporanea si muove dunque entro una tensione tragica. Da un lato, l’individualismo neoliberale promette libertà assoluta e godimento illimitato; dall’altro, produce solitudine, alienazione e marginalità.
Un progetto di trasformazione autentico non può eludere questa contraddizione, ma deve imparare ad abitarla, a riconoscerla come terreno di conflitto e possibilità. Non bastano più rassicurazioni superficiali o misure emergenziali: occorre ridefinire alla radice il significato stesso della libertà, sganciandola dalla logica dell’accumulazione e del consumo, e fondandola invece su una condivisione sostanziale del tempo e delle risorse.
Questo processo non sarà privo di tensioni né privo di costi. Le lotte per il potere e per il controllo delle risorse, se non guidate da una visione capace di oltrepassare la semplice gestione dei conflitti, rischiano di condurre alla rovina comune. Solo un cambiamento radicale che riorganizzi i fondamenti delle relazioni sociali e del lavoro può aprire la strada a una comunità più umana, in cui l’individuo non sia più prigioniero della propria condizione, ma possa fiorire nel movimento stesso del divenire.
Riferimenti bibliografici
Cassano F. (2011) L’umiltà del male: Editori Laterza
Winnicott D.W. (2025) Il sentimento del reale: Raffaello Cortina Editore
Barcellona P. (1993) Lo Spazio della Politica: Editori Riuniti
Mazzetti G. (1992) Dalla crisi del comunismo all’agire comunitario: Editori Riuniti
Bauman Z. (2011) Vite che non possiamo permetterci: Editori Laterza
Fromm E. (1992) Anima e Società: Mondadori
Cantarella E. (2021) Sparta e Atene: Einaudi
Zizek S. (2023) Too Late To Awaken: Allen Lane
Bewes T. (2002) Reification: Verso London – New York
Streek W. (2016) How Will Capitalism End?: Verso London – New York
Bazzocchi C. (2020) Il misterioso Zoppicare dell’Uomo: Meltemi