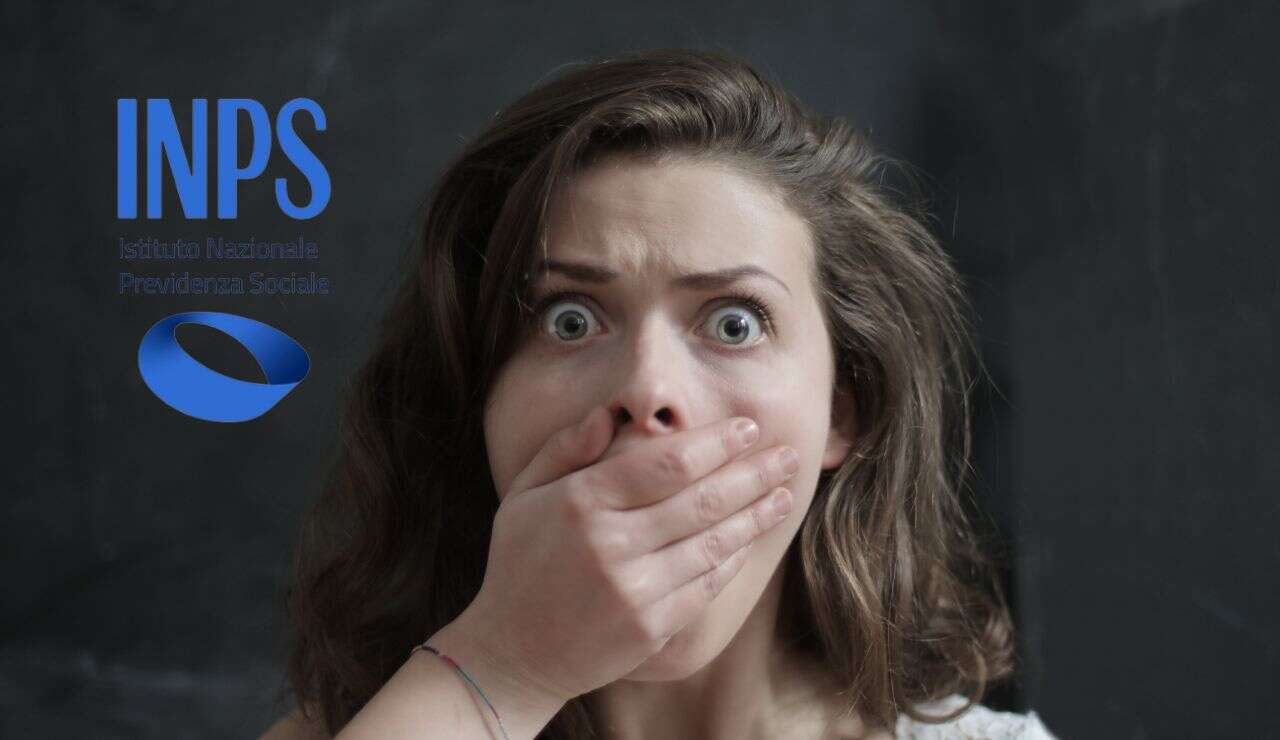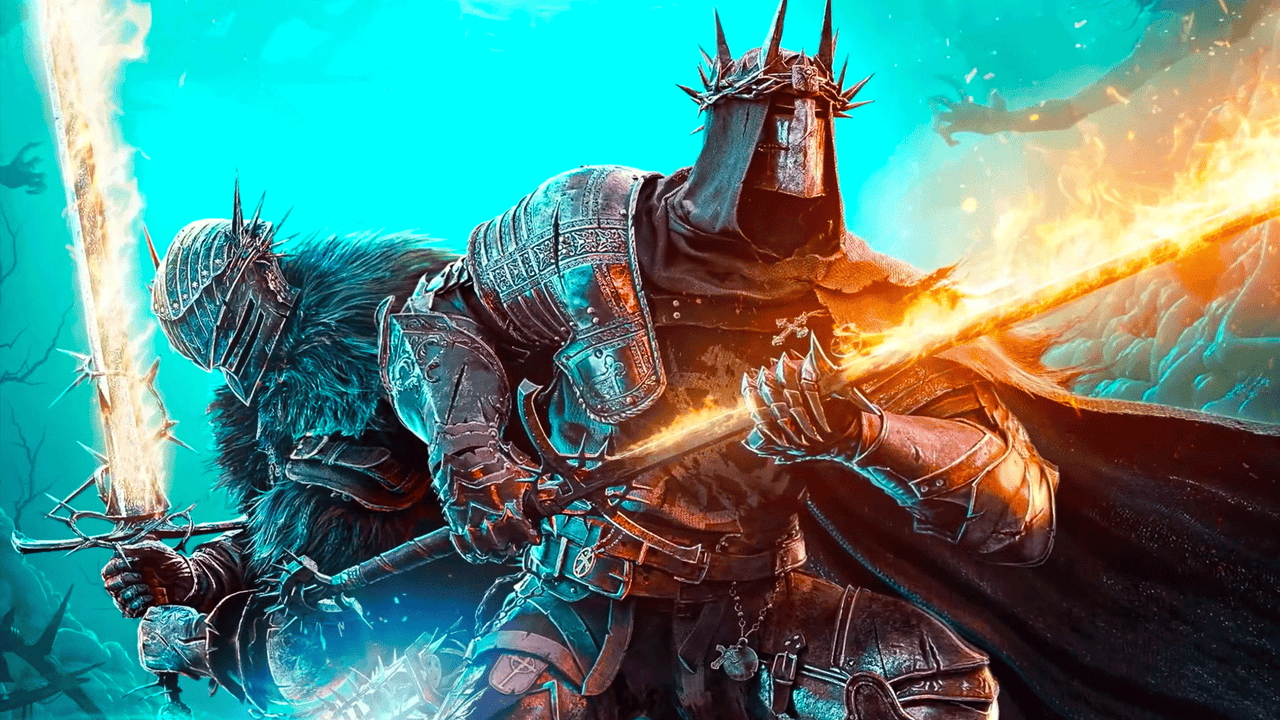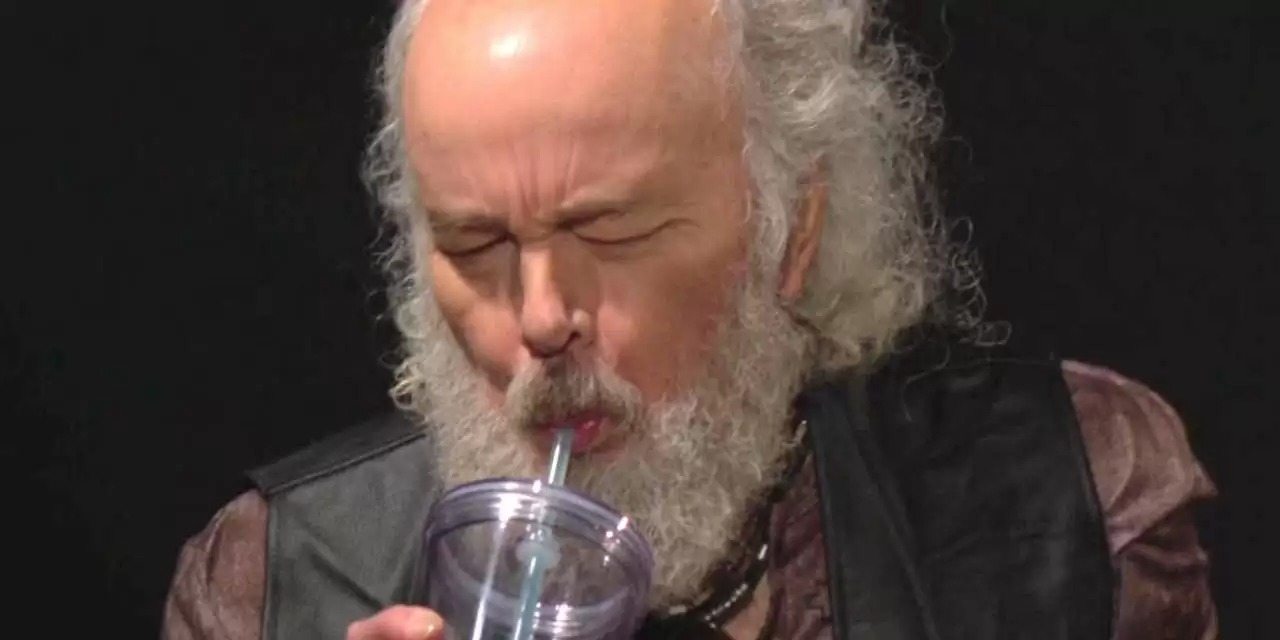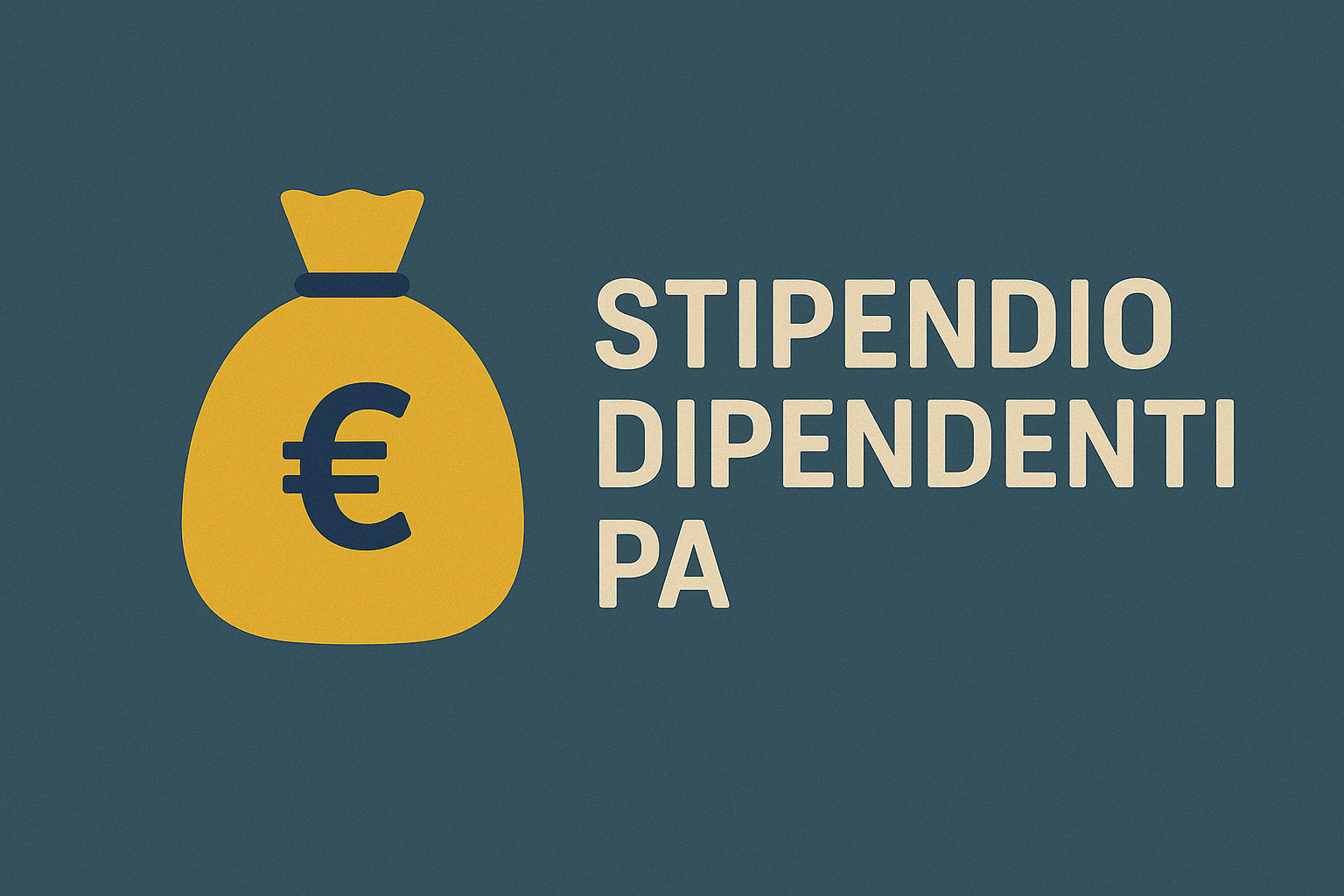Ho gli attacchi d’ansia perché il mondo è sempre più fascista, soffro di “fasciofobia”
Tra guerre, minacce tra Paesi fino a poco tempo fa alleati, conflitti commerciali, il rischio di escalation anche militari e l’ascesa dell’estrema destra in sempre più Paesi, è impossibile non provare ansia di fronte agli avvenimenti di un mondo sempre più fascista e alla deriva, in cui le cattive notizie sono all’ordine del giorno. È una condizione che gli inglesi hanno definito “political anxiety” e che noi potremmo anche chiamare “fasciofobia”. L'articolo Ho gli attacchi d’ansia perché il mondo è sempre più fascista, soffro di “fasciofobia” proviene da THE VISION.

Da anni purtroppo soffro di disturbo d’ansia generalizzato. Spesso è legato anche ad attacchi di panico e a stati di depressione minore. Sono quindi abituato, sia di fronte a una motivazione reale sia senza un apparente fattore scatenante, ad avere momenti di tensione e inquietudine. In questi mesi, però, mi sono trovato di fronte a una situazione inedita, ovvero ad avere forti momenti d’ansia a causa della situazione politica nazionale e internazionale intorno a me. È successo di recente, per esempio, quando alla Camera Giorgia Meloni ha rinnegato il Manifesto di Ventotene. Non che potessi aspettarmi altro dalla leader di un partito neofascista, ma in quanto presidente del Consiglio pensavo che potesse mantenere un freno istituzionale. Questo è stato il pensiero che ho avuto dopo la sua vittoria alle elezioni: “Ok, avremo il governo più di destra di sempre dal tempi di Mussolini, ma in qualche modo gli anticorpi della democrazia ci proteggeranno”. Venendo meno quelle protezioni, e quindi assistendo alla manifestazione dell’humus ideologico di Meloni, mi sono sentito vulnerabile e mi sono fatto assalire dall’ansia.

In Italia è una tematica poco dibattuta. Si parla già da un po’ di eco-ansia, la paura per il destino del pianeta tra riscaldamento globale, inquinamento e scenari futuri poco luminosi. Come per altri fenomeni, per avvicinarmi alle sensazioni che sto provando in questi giorni ho dovuto cercare su internet un termine legato alla cultura anglosassone. Ho così approfondito la condizione della political anxiety, diffusa negli Stati Uniti da circa un decennio, che noi potremmo anche chiamare “fasciofobia”. Ho trovato un interessante articolo di Jeremy P. Shapiro, professore associato di scienze psicologiche alla Case Western Reserve University. Shapiro racconta del suo primo caso di una paziente afflitta dalla “political anxiety”. Era il 2016, Donald Trump aveva appena vinto le elezioni e la donna, sconvolta, gli chiese di iniziare una terapia per ansia e depressione causate proprio dal risultato elettorale. Shapiro iniziò a seguirla e si accorse che non c’erano altre problematiche a livello di salute mentale, né nel presente né nel passato della donna, fuori dal “disagio politico”.

Shapiro ha così negli anni approfondito la problematica studiandola a fondo. È un disagio che si basa sulla convinzione che possano accadere eventi negativi nel proprio Paese o nell’intero pianeta in quanto nelle mani di “cattivi leader”. La ricetta di Shapiro per uscirne è quella di contestualizzare il periodo storico che stiamo vivendo. Se paragoniamo la situazione attuale a quella di vent’anni fa probabilmente la paura è legittima, considerando le incertezze a livello globale tra guerre, minacce tra Paesi fino a poco tempo fa alleati, conflitti commerciali e il rischio di escalation anche militari da un momento all’altro. Shapiro prova però ad ampliare i confronti, ricordando per esempio che i nostri padri o nonni hanno affrontato una guerra mondiale, che negli Stati Uniti degli anni Trenta c’è stato il periodo della Grande Depressione e che siamo comunque in una condizione più fortunata rispetto ad altre zone del pianeta, dove tra povertà, fame e mancanza anche dei beni primari le difficoltà sono ben superiori. Inoltre, restando anche solo al fattore prettamente politico, la democrazia è una rarità nella storia, se messa a confronto con millenni di tirannie, monarchie o altre forme di potere meno confortanti. Le rassicurazioni di Shapiro però non bastano, e nel mio caso la spiegazione può riassumersi nel fatto che i principali leader che governano il mondo stiano delegittimando e impoverendo la democrazia stessa, quindi uno dei pochi pilastri rimasti per non crollare definitivamente.

Una delle mie maggiori preoccupazioni è quella di non essere capito. Ognuno, nella vita reale e sui social, ha una propria bolla in cui tendenzialmente ci sono persone con pensieri simili, anche a livello politico. Fuori da quella bolla, mi ritrovo in un territorio ignoto dove la gente è felice di essere rappresentata dai leader che ci governano. Dunque i Salvini e le Meloni in Italia, ma per evitare il provincialismo conviene uscire dai nostri confini. Queste persone – a quanto pare la maggioranza, se prendiamo in considerazione i risultati elettorali – accettano che il mondo sia in mano a delinquenti. Non è una frase iperbolica, considerando che Putin e Netanyahu sono stati condannati dalla Corte Penale Internazionale come criminali di guerra, con tanto di mandato d’arresto, e che Trump è il primo presidente pregiudicato della storia degli Stati Uniti. A questi possiamo aggiungere Orbàn, Milei, Musk e altri personaggi che sono apprezzati da un’ampia platea. Non mi sento compreso proprio perché, anche durante un semplice dialogo sui social, provo a spiegare le loro malefatte, i morti che hanno causato, le città che hanno distrutto, le leggi che hanno infranto, e mi sembra di parlare contro un muro. Non è un discorso mirato a riconoscere chissà quale mia superiorità morale o alta conoscenza politica – in entrambi i casi non credo di possederle. Non è neanche legato al torto o alla ragione. Certi eventi però dovrebbero trascendere la soggettività proprio in quanto oggettivi: un dittatore invade una nazione, un altro mette in atto una pulizia etnica e via dicendo. E l’ansia sale quando non si riesce ad afferrare questo ragionamento semplice, una divisione nemmeno tra “buoni e cattivi”, ma tra “altri e cattivi”. Gli altri possono anche essere dei politici impreparati, delle forze d’opposizione fiacche e scadenti, e nessuno lo nega. Non so ugualmente come si faccia a non comprendere la pericolosità di certi individui. È come se fossimo in un film e il mondo fosse nelle mani dei villain di turno, alleati per spartirsi la torta. È però la vita reale, e io provo una profonda paura di fronte alle conseguenze delle politiche di questi personaggi evidentemente acclamati da molti. Questo porta anche a chiedermi se non sia io a essere dalla parte del torto. Inizio a dubitare di tutto, d’altronde potrei essere il pazzo contromano in autostrada che accusa tutti gli altri di andare nella direzione sbagliata. Rimugino, penso, arrivo persino a incolparmi e torniamo al principio: l’ansia cresce.


Provo allora a riallacciarmi di nuovo a qualche fonte scientifica, un po’ alla ricerca di una consolazione, un po’ a capire se siamo in tanti a provare questa sensazione. A quanto pare sì. L’American Psychological Association ha realizzato un report in occasione delle ultime elezioni statunitensi. Il 74% degli intervistati si è dichiarato preoccupato per le violenze post elettorali (memori di Capitol Hill), mentre il 56% ha detto di essere in ansia per un’eventuale fine della democrazia negli Stati Uniti. In generale, per il 77% la situazione politica è una fonte di stress nelle loro vite. Secondo Brett Ford, professore associato di psicologia presso l’Università di Toronto, studioso del legame tra le emozioni e l’impegno politico, “ci sono forti argomenti a sostegno del fatto che per molte persona la politica generi una forma di stress cronico”. Ford aggiunge che le dinamiche della politica possono scatenare una vasta gamma di emozioni negative, tra cui preoccupazione, tristezza, disperazione, indignazione, disgusto, rabbia e frustrazione. Inoltre gli eventi politici comportano conflitti tra gruppi che possono avere ramificazioni nella vita sociale e danneggiare i rapporti dei singoli individui. La political anxiety del singolo si diffonde e diventa un sentimento di massa, una preoccupazione che indebolisce i cittadini e li allontana dalla stessa vita sociale.

Io non so cosa succederà tra sei mesi o tra un anno, se Trump annetterà la Groenlandia con la forza, se Putin continuerà a bombardare l’Ucraina e Netanyahu a ridurre Gaza in polvere. Non so nemmeno se un giorno Meloni si sveglierà decidendo di ricreare il MinCulPop o se Salvini presenterà un decreto legge per mandare in esilio le persone transgender. So soltanto che se l’ansia è per sua natura un meccanismo di difesa, quando la provo è per proteggermi da qualcosa, che sia un pensiero intrusivo, un evento reale o una preoccupazione di qualunque tipo. E oggi è la politica a farmi paura, anche per l’immobilismo di chi dovrebbe rappresentare la controparte dei “villain” e per la non totale realizzazione di gran parte dei cittadini di ciò che sta avvenendo. Non potendo prevedere il futuro, posso però sentire l’ansia del presente, anche perché il pericolo non è un’ipotesi legata al futuro ma una concretezza del presente. Mi sento anche po’ un idiota a dire al mio analista che avere Vannacci come europarlamentare mi porta a un passo da una crisi esistenziale; eppure viviamo in una società interconnessa e le emozioni sono inevitabilmente collegate anche agli eventi politici. Forse dovrei – dovremmo – accettarlo e considerarlo come qualsiasi altro problema psicologico, a costo di dire ai nostri analisti che abbiamo gli attacchi d’ansia perché il mondo è sempre più fascista.
L'articolo Ho gli attacchi d’ansia perché il mondo è sempre più fascista, soffro di “fasciofobia” proviene da THE VISION.