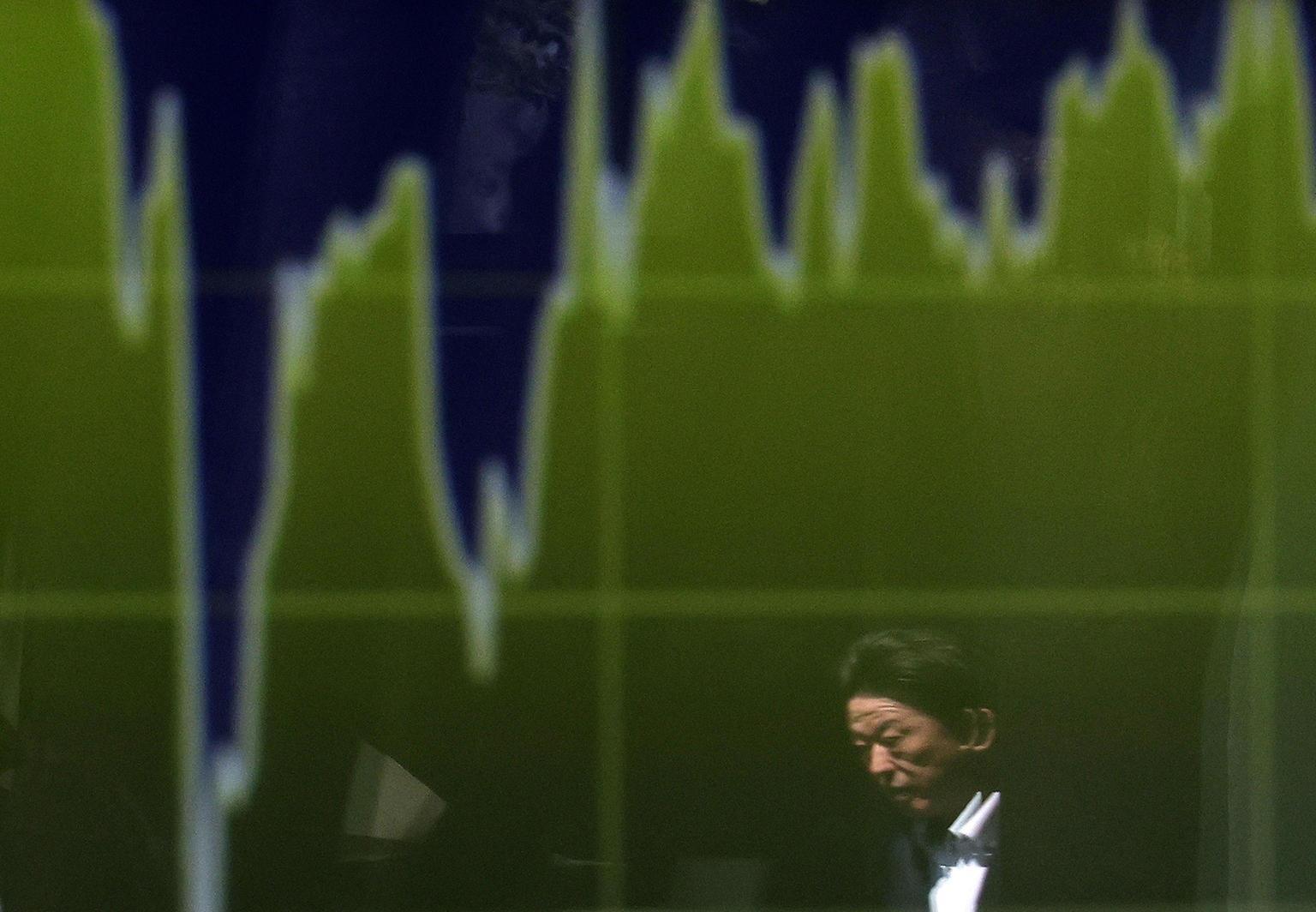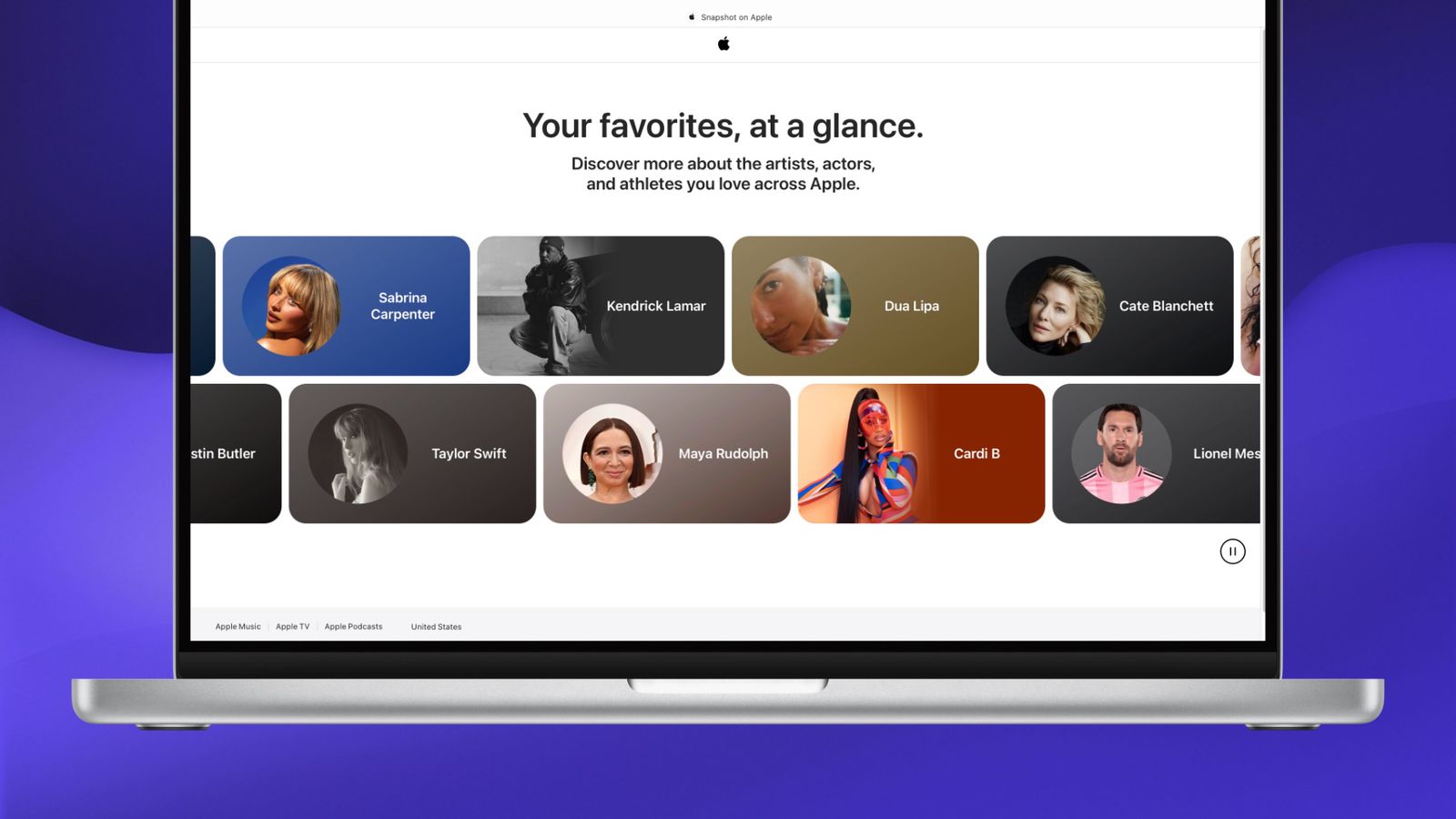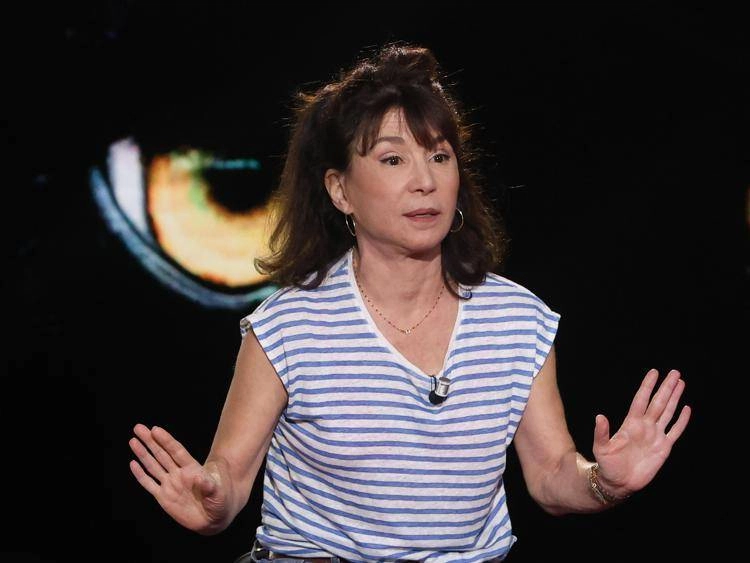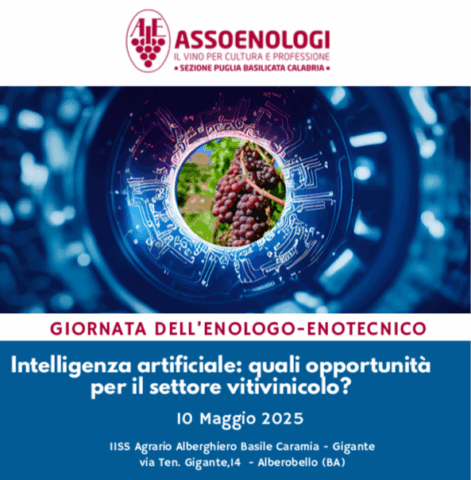Entriamo a Hebron, la città-prigione, mentre i caccia volano verso Gaza. A Masafer Yatta incontriamo Basel Adra
Da Gerusalemme, percorriamo la strada per raggiungere Hebron. Durante il mandato britannico (fra il 1920 e il 1948), questa era la strada residenziale più ambita dalle famiglie ricche, le uniche a potersi permettere di comprare casa qui. È proprio ciò che racconta Suad Amiry in Golda ha dormito qui: nel 1948 gli inglesi, partendo da […] L'articolo Entriamo a Hebron, la città-prigione, mentre i caccia volano verso Gaza. A Masafer Yatta incontriamo Basel Adra proviene da Il Fatto Quotidiano.

Da Gerusalemme, percorriamo la strada per raggiungere Hebron. Durante il mandato britannico (fra il 1920 e il 1948), questa era la strada residenziale più ambita dalle famiglie ricche, le uniche a potersi permettere di comprare casa qui. È proprio ciò che racconta Suad Amiry in Golda ha dormito qui: nel 1948 gli inglesi, partendo da Israele, “lasciarono due popoli in lotta: l’uno con tutto, l’altro con niente”. Inestimabile è per le famiglie palestinesi la perdita dei muri delle proprie case, muri che contengono ancora anime, memorie, affetti. Oggi ai vecchi proprietari di quei palazzi e di quei giardini è proibito avvicinarsi.
Anche se ci troviamo a pochissimi minuti dal centro di Hebron, siamo dovuti salire in alto facendo il giro della collina, a causa delle tante vie di accesso dirette negate alle persone. Il suono che sentiamo incessantemente è quello dei caccia che stanno volando verso Gaza, un rombo di tuono a cui non credo che riuscirò ad abituarmi.
Proprio mentre noi ci accingiamo a scendere, all’Aia cominciano le udienze della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi umanitari di Israele nella striscia di Gaza, dove da oltre cinquanta giorni vige un blocco totale degli aiuti in ingresso. Una maratona di cinque giorni che sarà aperta dalla testimonianza dell’Autorità Nazionale Palestinese. Nel frattempo, nell’enclave assediata non cessano le stragi: 51 morti negli attacchi israeliani di ieri, uno sferrato contro un gruppo di civili nella parte orientale della città di Gaza, uno su un bar vicino al campo di Al-Boureij.
Percorriamo la via per Hebron guardando le scie dei caccia diretti là, a portare distruzione.
Hebron è il più grande governatorato della Palestina, più di 1 milione di palestinesi vivono qui. È importante per il settore dell’agricoltura, soprattutto per l’uva. Ecco perché, praticamente dappertutto, si vedono tappeti verdi: là si distendono i vigneti, con circa 20 tipologie diverse di uva (anche se il momento migliore – spiega la nostra guida – è fra la fine di luglio e agosto).
Immaginate, però, vigneti sparsi in tutta la valle del Giordano, dove oggi ci sono insediamenti. Ecco: un tempo la coltivazione di uva di Hebron si espandeva così, mentre adesso una grande quantità di terre è stata sottratta, riducendo drasticamente la produzione. Non solo: gli israeliani che occupano la valle del Giordano raccolgono uva a loro volta, invadendo i mercati delle città palestinesi con prodotti molto più economici. Perché? Perché il costo di produzione per i palestinesi – gravati da mille ostacoli nell’ottenere gli strumenti necessari per la coltivazione e nel trasporto – è triplo. A Jenin, culla della tradizione agricola dell’anguria, i pozzi d’acqua sono stati chiusi per abbattere la produzione e sostituirla con i prodotti delle colonie. Una pratica ben mostrata in No other land.
Finalmente, entriamo a Hebron. Questa città è diversa da tutti gli altri centri urbani palestinesi, dove i coloni si sono stabiliti intorno ai confini, come in un assedio: qui i coloni vivono dentro la città, gli insediamenti sorgono addirittura nella città vecchia. Hebron – va detto – è un luogo chiave anche per la storia del popolo ebraico. Qui sorge la cosiddetta quercia di Abramo, un albero millenario dove, secondo la tradizione biblica, il patriarca piantò la sua tenda. Così le grotte che compongono il Santuario di Abramo, il secondo luogo sacro per gli ebrei, che lo considerano sepolcro di Abramo, Isacco e Giacobbe. Anche per questo la comunità dei coloni haredim [ultraortodossi] israeliani vuole ripristinare l’antica presenza ebraica.
Hebron è al contempo uno dei luoghi più emblematici del fallimento del processo di pace. Il controllo dell’esercito israeliano sulla popolazione palestinese è portato all’estremo. Nella città vecchia, tornelli metallici, muri e check point militari regolano gli spostamenti. Nella cosiddetta area H2, che include il centro storico ed è una delle zone più ad alta tensione della Cisgiordania, 35.000 palestinesi coabitano con circa 650 coloni israeliani.
Arriviamo a quella che l’esercito chiama Chicago Street, proprio nella H2. In realtà è l’inizio di un insediamento colonico, il più importante del centro di Hebron: qua i palestinesi non possono entrare se non per 50 metri, come la nostra guida, che è stata autorizzata dopo una breve trattativa. Le macchine parcheggiate hanno tutte targhe di coloni o dell’esercito, l’intero quartiere è sotto il controllo militare israeliano.
I primi insediamenti sono sorti nel 1983, in alto, posizionando dei caravan in una zona disabitata dai palestinesi. Poi hanno cominciato a espandersi. Camminando, fra due pali vediamo uno striscione con una stella di Davide e una scritta in ebraico, che vuol dire letteralmente “stiamo occupando Gaza”. La differenza fra le case degli israeliani e dei palestinesi è che quelle dei palestinesi hanno le grate e le cisterne d’acqua, le grate – ci spiega la guida – servono a ripararsi dai lanci delle birre e dell’immondizia dei coloni.
Percorriamo le vie di quella che era la parte più viva di Hebron, fino a quando, nel 1994, il massacro nella moschea a opera del terrorista Baruch Goldstein costò la vita a 29 palestinesi (altri 26 furono uccisi dall’esercito nel corso della giornata, mentre 5 israeliani furono uccisi dalla folla). Fu la premessa per la divisione della città in due settori: Hebron 2 (quell’H2 che rappresenta circa il 20% della città), sotto controllo dell’esercito israeliano, e Hebron 1, affidata al controllo dell’Autorità palestinese in accordo con il cosiddetto “protocollo di Hebron”.
Vediamo il secondo insediamento, il secondo più grande di Hebron, a ridosso del centro: sotto un portico c’è un edificio, un tempo era una scuola palestinese, adesso è diventata una scuola ebraica con più di 300 studenti.
Arriviamo infine nel centro storico di Hebron, dietro una scalinata in pietra comincia l’area occupata dai coloni, proprio nel cuore nevralgico ora interdetto ai palestinesi. Il filo spinato rappresenta un prima e un dopo inconciliabili, il lutto generato dalla privazione dell’area più importante della città e l’inizio di una nuova apartheid.
Hebron è ormai una città-prigione, in cui sono continue le violenze, le umiliazioni e le restrizioni ai danni dei palestinesi, praticamente confinati nelle loro case. Gli attacchi dei coloni, a sud e a nord di Hebron come a Ramallah, avvengono ogni giorno: dal lancio di pietre agli spari. Questo accade – ci dice Muhammad, il presidente dell’associazione “Youth against settlement” – perché il silenzio della comunità internazionale e il mancato riconoscimento dello Stato palestinese consentono ai coloni di non rispondere alla legge, protetti dal governo e dall’esercito israeliani.
Muhammad ci fa strada attraverso Hebron. Ci racconta tutto della sua organizzazione: un gruppo internazionale palestinese non partitico e fermamente non violento, impegnato soprattutto a rafforzare la presenza delle famiglie palestinesi che vivono a Hebron, supportandole in tutto ciò di cui hanno bisogno, da un aiuto per pitturare la casa, alle forniture d’acqua, agli interventi idraulici. Già, perché non possono far arrivare lavoratori da fuori, devono fare tutto da soli. Poi c’è l’aiuto legale, per esempio per chi viene arrestato. Ci sono un media team e un grande archivio, che raccoglie centinaia di video che mostrano gli attacchi dei coloni. E c’è il lavoro di advocacy, in viaggio per tutta Europa e per il mondo a parlare della Palestina, e qui, sul posto, mostrando a chi viene che cosa significa per i palestinesi vivere sotto l’occupazione.
Quando entriamo nel centro storico, Muhammad guarda verso una telecamera posta in alto. È il riconoscimento facciale: solo gli abitanti dell’area possono entrare. Hebron è diventata anche laboratorio di tecnologie di sorveglianza avanzate, come questa. E noi? Siamo entrati perché siamo stranieri, ma non era affatto detto, giorni fa il console francese è stato fermato. Tutto dipende dall’umore del soldato che in quel momento si trova al check point.
Usciti da Hebron, vogliamo raggiungere le zone più agricole della Cisgiordania, dove si trova la maggior parte degli insediamenti. Eppure, restiamo bloccati al check point, davanti alla serrata di uno dei mille cancelli che chiudono la Cisgiordania in piccole celle, grate di ferro posti davanti a tutti i villaggi, aperte o no a seconda dell’arbitrio dei soldati israeliani. Ci tocca compiere un giro più largo per arrivare a Masafer Yatta, rientrando in Hebron e uscendo da un’altra parte.
Al mio fianco, sull’auto, è seduta Luisa Morgantini, presidente di AssopacePalestina. “Vedi?” mi dice: “Qui anche i semafori contribuiscono all’apartheid: sulla strada principale da Gerusalemme a Hebron, percorsa dagli israeliani, il verde dura 5 o anche 7 minuti, invece per chi proviene dalle strade interne, ossia i palestinesi, poco più di un minuto. Vivere e sopravvivere sono una forma di lotta non violenta”.
A Masafer Yatta incontriamo Basel Adra, uno dei registi nonché il protagonista di No other Land. Ci raggiungono diversi attivisti da tutto il mondo presenti a turni di tre mesi nei villaggi. Proprio oggi – ci raccontano– il giudice deciderà se demolire o meno la Guest House che ci ospita, dove solo poche ore fa è avvenuta una delle tante distribuzioni di pacchi per coloro che hanno subito la demolizione delle proprie case.
Ci troviamo nell’area C, definita in base agli accordi di Oslo. Teoricamente, in questa zona ai palestinesi basterebbe chiedere l’autorizzazione per qualunque costruzione, la realtà è che è impossibile ottenere tali autorizzazioni. Il Piano regolatore è stato ottenuto soltanto nel 2012 e strade e palazzi sono entrati in possesso dei palestinesi dopo un lunghissimo e faticoso percorso di trattativa con il governo israeliano. Tuttavia, quel Masterplan ha teoricamente congelato tutti gli ordini di demolizione relativi alla zona.
L’edificio in cui ci troviamo è stato regolarmente costruito fra il 2020 e il 2022, anno in cui l’edificazione è stata però bloccata ed è arrivato un ordine di demolizione. Lo stesso sta accadendo in metà dei luoghi interessati dal Piano regolatore. Gli ordini di demolizione stanno toccando tantissimi villaggi in tutta la West bank, accompagnati dai violenti attacchi da parte dei coloni. Il progetto, non più taciuto, è demolire sostanzialmente tutto e far spostare le persone verso le città ghetto, annettendo l’area sfollata a Israele.
Si tratta di una zona strategica, vicina al deserto, utilizzata per l’addestramento dei soldati israeliani. È questa la scusa con cui si giustificano tutte le violenze e le demolizioni. Certo, le angherie, a cui le persone del luogo rispondono con una resistenza non violenta, cercando di difendere le loro case, durano da quarant’anni. Ma dal 7 ottobre 2023 la situazione è notevolmente peggiorata. Se non verranno prese misure immediate, la comunità palestinese di Masafer Yatta, come altre nella zona, sarà sfollata con la forza.
Opporsi a questo destino è un gesto quotidiano: quello del pastore che porta le pecore al pascolo, del genitore che accompagna i bambini a scuola. Sono modi per mostrare la propria presenza, rivendicare il diritto a vivere sulla propria terra. L’atto più forte di resistenza è la sopravvivenza stessa, la pazienza, soprattutto nelle lunghe fasi in cui l’attenzione internazionale si spegne.
Una lotta che è quanto più lontano si possa immaginare da ogni forma di terrorismo, che perdura sopportando ogni giorno soprusi e uccisioni arbitrarie. Una lotta sostenuta, per fortuna, da gruppi di attivisti come fa Leone che partecipa e anima ‘operazione Colomba’. Che ci racconta l’epopea dei bambini di Tuwa, che per arrivare a scuola a Tuwani (costruita legalmente nell’area del Masterplan) passavano un tempo da una strada fra la colonia di Ma’on e l’avamposto di Havat Ma’on, dove vivono i coloni che perpetrano le più crude aggressioni. I bambini sono stati attaccati innumerevoli volte, con spranghe e catene, insieme agli accompagnatori internazionali. Attivisti che ogni giorno fungevano da scorta a quei ragazzi, facendo compiere loro un giro più largo, quasi un’ora di cammino contro i 15 minuti diretti che ci vorrebbero.
Questo fino a quando, ormai 15 anni fa, una volontaria americana fu ferocemente picchiata e gravemente ferita. Il risalto mediatico fu grande, la Corte israeliana dichiarò illegale l’avamposto di Havat Ma’on, tuttavia, invece di smantellarlo, ordinò che fornisse esso stesso una scorta militare per gli allievi diretti ad At-Tuwani. Così, l’associazione cambiò missione: da quel momento si trattava di monitorare quanto la scorta militare facesse realmente il suo lavoro. A seconda del commando di turno, a volte i militari volte si presentavano, altre volte no. Soprattutto, i bimbi si trovavano scortati dagli stessi soldati che a Tuwa arrestavano i loro genitori.
Dal 7 ottobre, semplicemente, i bambini di Tuwa hanno smesso di venire alla scuola di At-Tuwani. Ora devono raggiungerne un’altra, in un lontano villaggio, un edificio sotto ordine di demolizione, subendo quindi una condizione temporanea e precaria.
L’attività dei volontari è durissima, anche se sono stati affiancati da Mediterranea in questo ultimo anno. La presenza continuativa è difficile, facile essere arrestati e rimpatriati come persone non gradite, con divieto di accesso per i seguenti dieci anni. Tutto questo significa essere sul territorio in cinque, in otto nei momenti migliori. Eppure, continuano e fanno la differenza. Anche loro attori di una resistenza non violenta che dovrebbe avere tutto il sostegno della comunità internazionale.
A fine giornata mentre viaggiamo verso Betlemme penso ad un uomo che, per le strade di Hebron si era fermato a chiacchierare con noi. “In Palestina ci sono criminali e brava gente” – mi ha detto – “gente violenta e gente non violenta, drogati e persone di chiesa, studenti e lavoratori che non chiedono niente, come in Italia, come in tutto il resto del mondo. Non ci sentiamo unici. Non siamo i prescelti. Non siamo migliori di nessuno, ma non siamo neanche dei reietti, vogliamo semplicemente vivere”.
L'articolo Entriamo a Hebron, la città-prigione, mentre i caccia volano verso Gaza. A Masafer Yatta incontriamo Basel Adra proviene da Il Fatto Quotidiano.