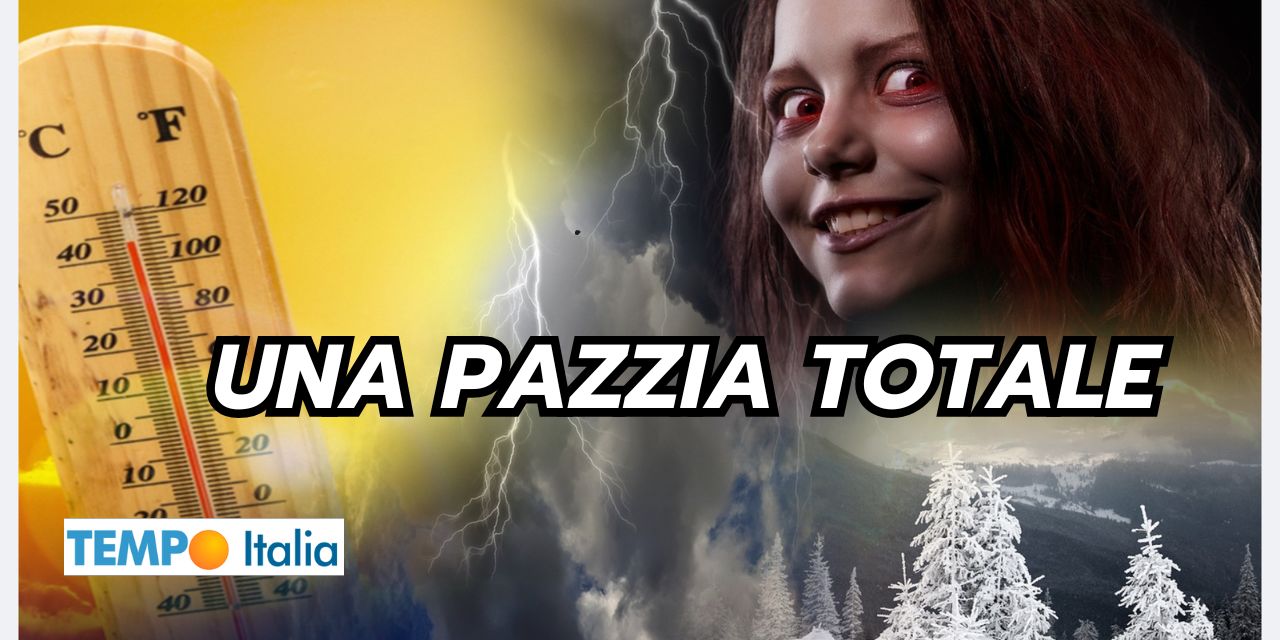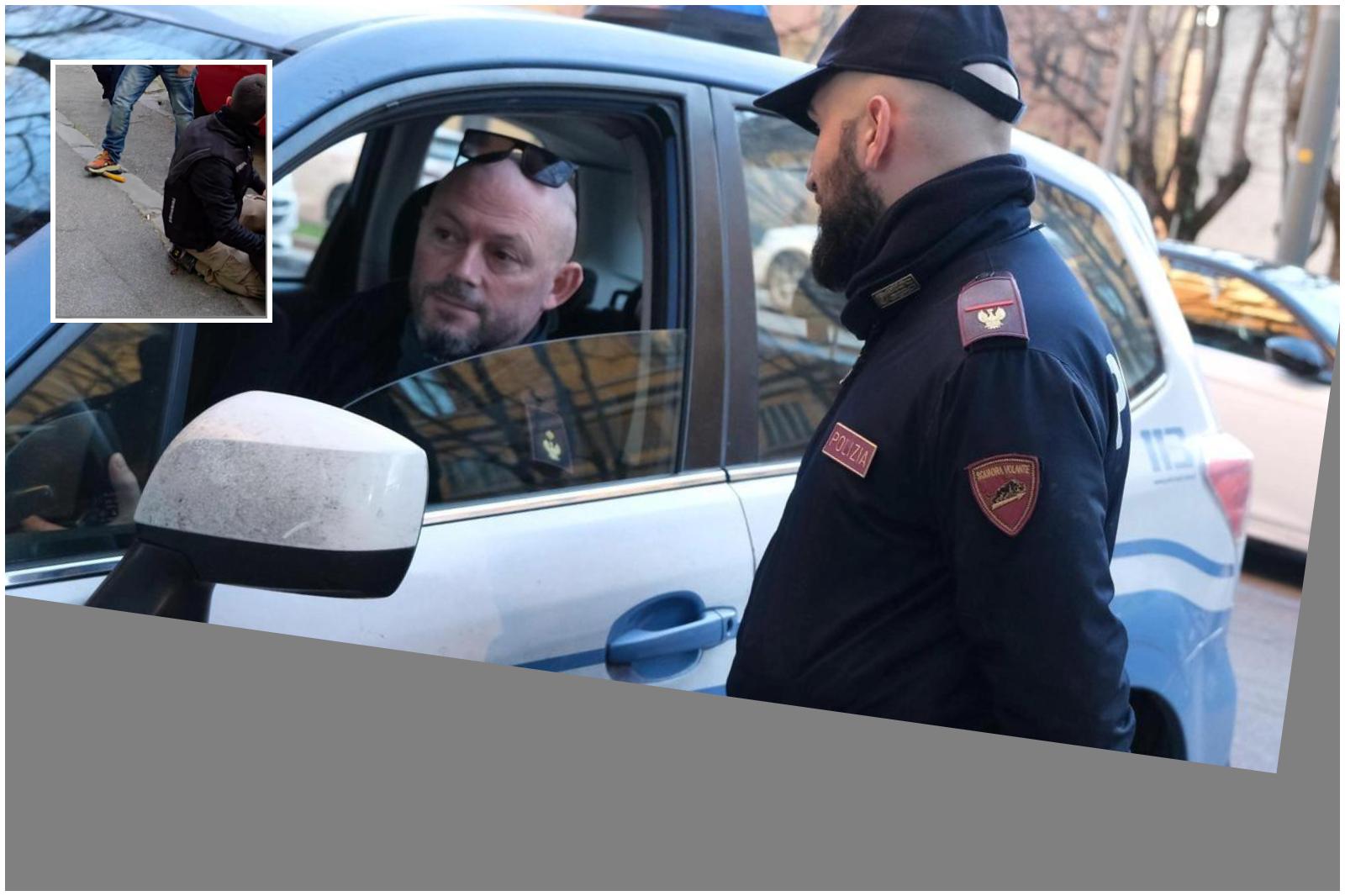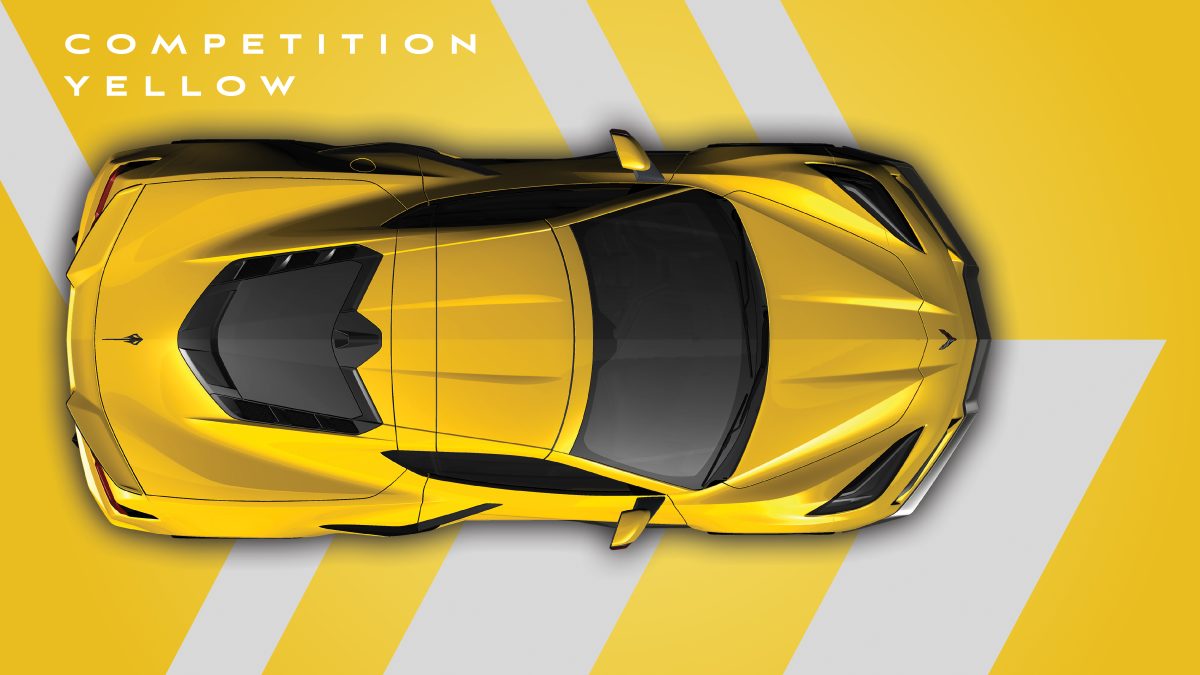Ddl Intelligenza artificiale: gli avvocati spiegano le nuove regole in arrivo
Il disegno di legge (Ddl), approvato dal Senato lo scorso 20 marzo, definisce un nuovo quadro giuridico nazionale per l’era dell’IA (intelligenza artificiale), cercando un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti. Il testo si propone di affiancare, senza sovrapporsi, l’AI Act europeo, delineando principi, governance e misure specifiche per il contesto italiano, al fine […] L'articolo Ddl Intelligenza artificiale: gli avvocati spiegano le nuove regole in arrivo proviene da Economy Magazine.

Il disegno di legge (Ddl), approvato dal Senato lo scorso 20 marzo, definisce un nuovo quadro giuridico nazionale per l’era dell’IA (intelligenza artificiale), cercando un equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti. Il testo si propone di affiancare, senza sovrapporsi, l’AI Act europeo, delineando principi, governance e misure specifiche per il contesto italiano, al fine di sfruttare appieno le opportunità offerte da questa tecnologia.
“Il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, approvato dal Senato e ora in esame alla Camera, rappresenta un passo importante verso una regolamentazione equilibrata dell’AI, intervenendo in ambiti chiave della vita quotidiana – spiega Jacopo Piemonte, Senior Associate dello studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani. – Ad esempio, l’AI potrà essere utilizzata nel settore pubblico, ma solo se viene garantito ai cittadini il diritto di comprendere le decisioni algoritmiche che li riguardano. In ambito sanitario, l’AI potrà essere di assistenza nell’identificare le diagnosi dei pazienti, ma sempre sotto il controllo dei medici, che rimarranno i responsabili finali dei responsi clinici. Nei luoghi di lavoro, l’AI potrà essere impiegata per migliorare la produttività, ma nel rispetto della dignità e della privacy dei lavoratori. Questo disegno di legge si configura dunque come un importante presidio per la tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra società. Il testo sarà ora sottoposto alla Camera per eventuali modifiche, che non dovrebbero però intaccare il suo impianto generale. Dopo la conclusione dell’iter legislativo, sarà comunque essenziale garantire un’adeguata allocazione di fondi alle autorità incaricate della supervisione di questa normativa. Solo in questo modo sarà possibile ottenere un’efficace applicazione della legge, assicurando che gli importanti principi ivi contenuti vengano tutelati effettivamente.
Un provvedimento innovativo che ha sollevato un ampio dibattito tra gli esperti legali. Mentre alcuni vedono nel nuovo disegno di legge un importante passo verso una regolamentazione equilibrata, altri sollevano perplessità sulla sua effettiva portata innovativa.
L’IA nel sistema giudiziario e nuove fattispecie di reato
L’impatto dell’IA all’interno del sistema giudiziario è uno dei temi più delicati. Gli esperti concordano sulla necessità di stabilire confini chiari, come spiegano Mascia Cassella e Luca Masotti, soci dello studio Masotti Cassella:
“Riteniamo che i relatori abbiano correttamente inteso definire i limiti entro cui l’intelligenza artificiale può essere utilizzata nell’attività giudiziale. È opportuno stabilire che attività sensibili quali l’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove, e l’adozione dei provvedimenti restino esclusivamente di competenza del magistrato, senza alcun ricorso all’IA. Da accogliere con favore è, invece, l’impiego dell’IA per le attività di organizzazione dei servizi e degli uffici, che, accompagnata da adeguata formazione del personale, ci si aspetta possa contribuire all’efficienza del sistema giustizia nel suo complesso senza però comprometterne l’integrità.”
Il disegno di legge affronta con decisione anche gli aspetti giuridici più complessi del diritto penale, ribadendo il principio cardine del primato dell’essere umano nelle decisioni giudiziarie. L’IA potrà supportare attività organizzative, ma non sostituirsi mai al giudizio umano.
Andrea Puccio, founding partner dello studio Puccio Penalisti Associati, sottolinea:
“Il Legislatore ha scelto di operare secondo due direttrici principali: da un lato, l’art. 22 prevede l’attribuzione di una delega al Governo per introdurre nuove fattispecie di reato e modificare la disciplina sulla responsabilità penale, anche per gli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Dall’altro, l’art. 26 interviene direttamente sul Codice penale, prevedendo specifiche circostanze aggravanti per reati commessi tramite IA e introducendo una nuova fattispecie di reato per la diffusione illecita di contenuti generati o alterati dall’IA.”
Lavoro e innovazione: l’Osservatorio del ministero
Il mondo del lavoro è un altro degli ambiti dove l’impatto dell’IA è tra i più evidenti. L’istituzione di un Osservatorio presso il ministero del Lavoro rappresenta un passo importante per monitorare e gestire l’integrazione delle tecnologie intelligenti nei contesti professionali.
Giorgio Manca, Partner e Co-Head of Employment di DWF Italy, evidenzia:
“L’art. 10 evidenzia che l’utilizzo dell’IA deve essere ‘sicuro, affidabile e trasparente’ e richiama gli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, includendovi anche l’eventuale utilizzo dell’IA. Molto significativo, a mio avviso, è il richiamo alla necessità di garantire in ogni caso la dignità umana e la riservatezza dei dati personali, nonché l’integrità psico-fisica dei lavoratori. Mi sembra significativa anche l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un ‘Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro’, a cui è affidato il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, di monitoraggio dell’impatto dell’IA sul mercato del lavoro e di promozione della formazione (sia dei lavoratori che dei datori di lavoro) in materia di IA”.
Diritto d’autore: nuove tutele
Gli articoli 23 e 24 vanno a modificare l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore chiarendo che “sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, (…) anche se realizzate tramite l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché siano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore”. Inoltre, per garantire trasparenza, i contenuti generati o modificati dall’IA dovranno essere contrassegnati da un watermark visibile, salvo quando il contenuto sia “parte di un’opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio”. Il DDL prevede poi un nuovo 70-septies alla Legge sul Diritto d’Autore che estende ai modelli e sistemi di IA, inclusa quella generativa, le eccezioni al diritto d’autore per l’estrazione di testi e dati per scopi di ricerca scientifica e per scopi commerciali, già previste dagli articoli 70-ter e 70-quater LDA
Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca La Rocca Sena, partner dello studio legale Sena & Partners, commentano:
“Se da un lato, il nuovo DDL cerca di regolamentare un settore in continua evoluzione affinché i contenuti creativi siano rispettati e protetti ‘per poter garantire un’informazione pluralistica e una vera libertà di scelta democratica, in cui il giornalismo e l’informazione possano mantenere un volto umano e una responsabilità concreta’ (Fascicolo Iter DDL s.1146, pg. 1460), dall’altro, non sono mancate critiche sia da parte della Commissione Europea (parere C(2024)7814 del 5 novembre 2024) che di Confindustria (Memoria, settembre 2024). La prima ha evidenziato una sovrapposizione normativa con l’AI ACT europeo, ed in particolare con l’art. 50 dello stesso; mentre la seconda, pur condividendo l’impostazione generale del DDL, ha sottolineato l’importanza che non vi siano interpretazioni eccessivamente restrittive da parte delle autorità di vigilanza in futuro. In particolare, l’imposizione di filtri molto rigidi nel cd. training datasets oppure obblighi sul watermarking più severi di quelli europei potrebbero ostacolare l’innovazione e la competitività dell’IA in Italia, rendendo più difficile per le aziende italiane sviluppare modelli/sistemi avanzati o competere con quelle straniere”.
“Dal punto di vista del diritto di autore, è interessante la notizia che Meta abbia reso disponibile alcuni dei propri sistemi di IA generativa agli utenti italiani delle proprie piattaforme, specie di messaggistica – aggiunge Stephanie Rotelli, co-founder dello studio Cosmo Legal Group – sia per Meta stessa, che in qualità di fornitore di sistemi di IA nel mercato europeo è soggetto alle disposizioni dell’AI Act, specie in tema di policy di tutela del diritto di autore e di trasparenza dei set di dati; sia per gli utenti, i quali, se deployer, dovranno attenersi alle disposizioni dell’AI Act, specie in termini di trasparenza, anche dei deepfake che realizzano; più in generale, gli utenti dovranno sapere che, anche ai sensi del DDL appena approvato al Senato, un contenuto generato da un sistema di IA generativa senza alcun apporto creativo umano non sarà protetto dal diritto di autore e che diffondere illecitamente deepfake costituirà reato”.
Limiti e risorse del nuovo DDL
“Non mancano le voci critiche sulla struttura e l’impostazione del disegno di legge, come fa notare Ugo Ettore Di Stefano, senior partner dello studio legale Lexellent, che segnala come “due punti evidenziano la limitata portata innovativa del provvedimento. Innanzitutto, emerge come il provvedimento sia sostanzialmente volto a definire norme di principio a carattere generale, principi già da tempo condivisi, quali la concezione antropocentrica dell’uso dell’AI o le eccezioni per ragioni di sicurezza nazionale (che sempre più saranno centrali in un’Europa che discute di nuovi armamenti e l’AI ne sarà parte essenziale). Anche le norme di settore appaiono poco innovative e per lo più di carattere generale. Per la Pubblica Amministrazione, per esempio, ci si limita sostanzialmente a indicare i principi di promozione dell’utilizzo dell’AI nella P.A. e della semplificazione nella Giustizia. Altri esempi di non necessità di tale norma si possono trovare nei non significativi interventi in ambito di diritto d’autore, con limitate indicazioni in merito all’obbligo di marcatura (art. 23) dei contenuti informativi audiovisivi e radiofonici generati o modificati con l’AI o l’aggiunta del termine ‘umano’ al concetto di opere di ingegno della L. 633/41, specificandosi poi che si intendono opere di ingegno anche quelle prodotte con strumenti di AI purché costituenti il risultato del lavoro intellettuale dell’autore (art. 24). In secondo luogo, le scarse risorse finanziarie investite. Solo gli artt. 19 e 21 prevedono 300 milioni annui per due anni per i servizi sperimentali ai cittadini e alle imprese dal Ministero degli Esteri e 1 miliardo per i restanti investimenti in cybersicurezza e calcolo quantistico. Per il resto, con l’art. 26 a chiusura, la consueta clausola di invarianza finanziaria che impone alle amministrazioni interessate a dare esecutività al provvedimento di farlo esclusivamente con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Ma l’AI ha altri costi: oggi tutte le principali imprese private impegnate nello sviluppo dell’intelligenza artificiale investono, ciascuna singolarmente, svariati miliardi ogni anno. Un provvedimento, insomma, che non cambierà la legislazione vigente in maniera radicale. E forse è corretto così, perché l’AI è un fenomeno in rapidissima evoluzione e di dimensione globale, non contenibile in un singolo atto normativo nazionale”.
Sulla stessa linea anche Massimiliano Pappalardo, partner dello studio legale Ughi e Nunziante, che evidenzia come “il DDL introduce un ulteriore layer normativo – che rimanda peraltro a successivi decreti attuativi – in un quadro regolamentare in materia di dati e di servizi digitali già stratificato e complesso. Per quanto sia comprensibile l’attenzione per una tecnologia rivoluzionaria e dalle potenzialità sconfinate, una maggiore semplificazione sarebbe stata forse auspicabile. Il testo approvato in Senato supera comunque alcuni dei rilievi svolti dalla Commissione europea rispetto al disegno di legge originario, ad esempio attraverso l’allineamento alle definizioni dell’AI Act. Gli interventi non sembrano, tuttavia, recepire del tutto le indicazioni della Commissione. In particolare, viene confermata la designazione di Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale. Al riguardo, la Commissione europea aveva ricordato che le autorità designate dai singoli Stati devono possedere lo stesso livello di indipendenza previsto dalla Direttiva (UE) 2016/680 per le autorità preposte alla protezione dei dati. Nonostante tale rilievo, il testo licenziato dal Senato conferma per questo ruolo due agenzie governative, anziché due autorità indipendenti”.
L'articolo Ddl Intelligenza artificiale: gli avvocati spiegano le nuove regole in arrivo proviene da Economy Magazine.












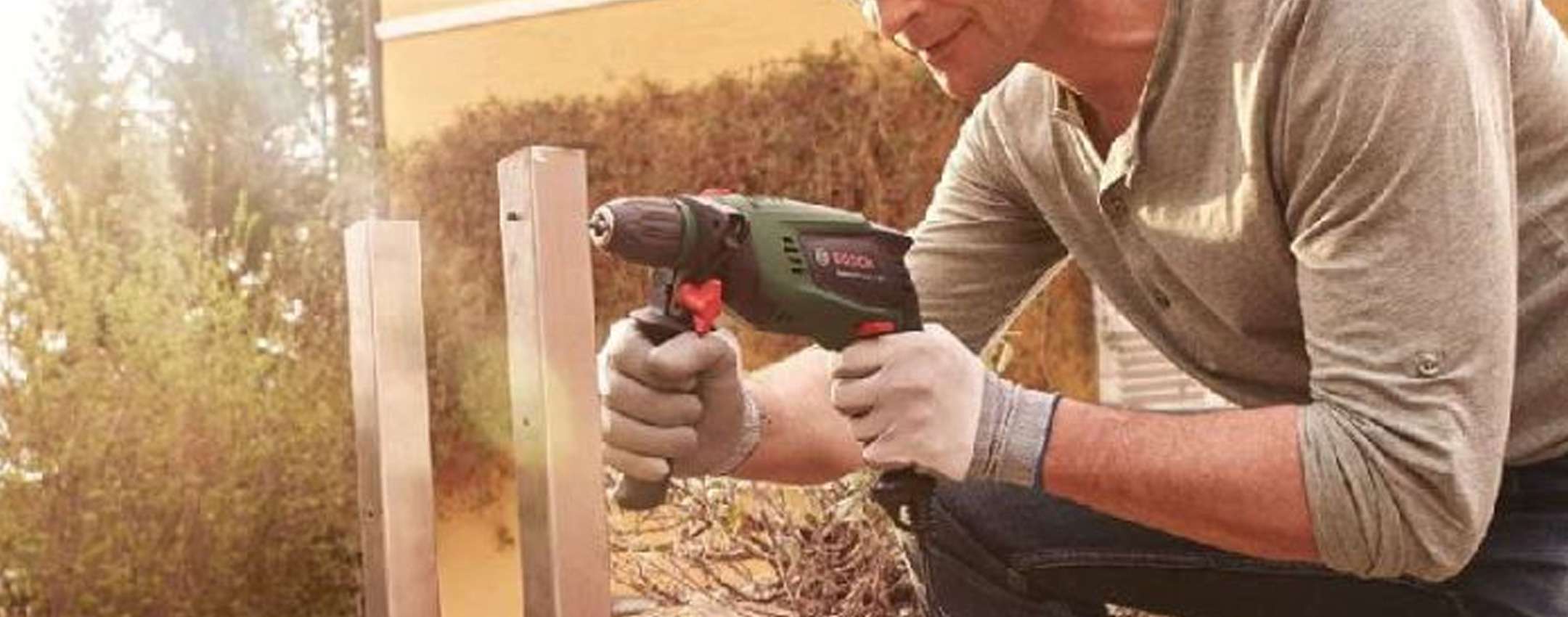

.jpg)