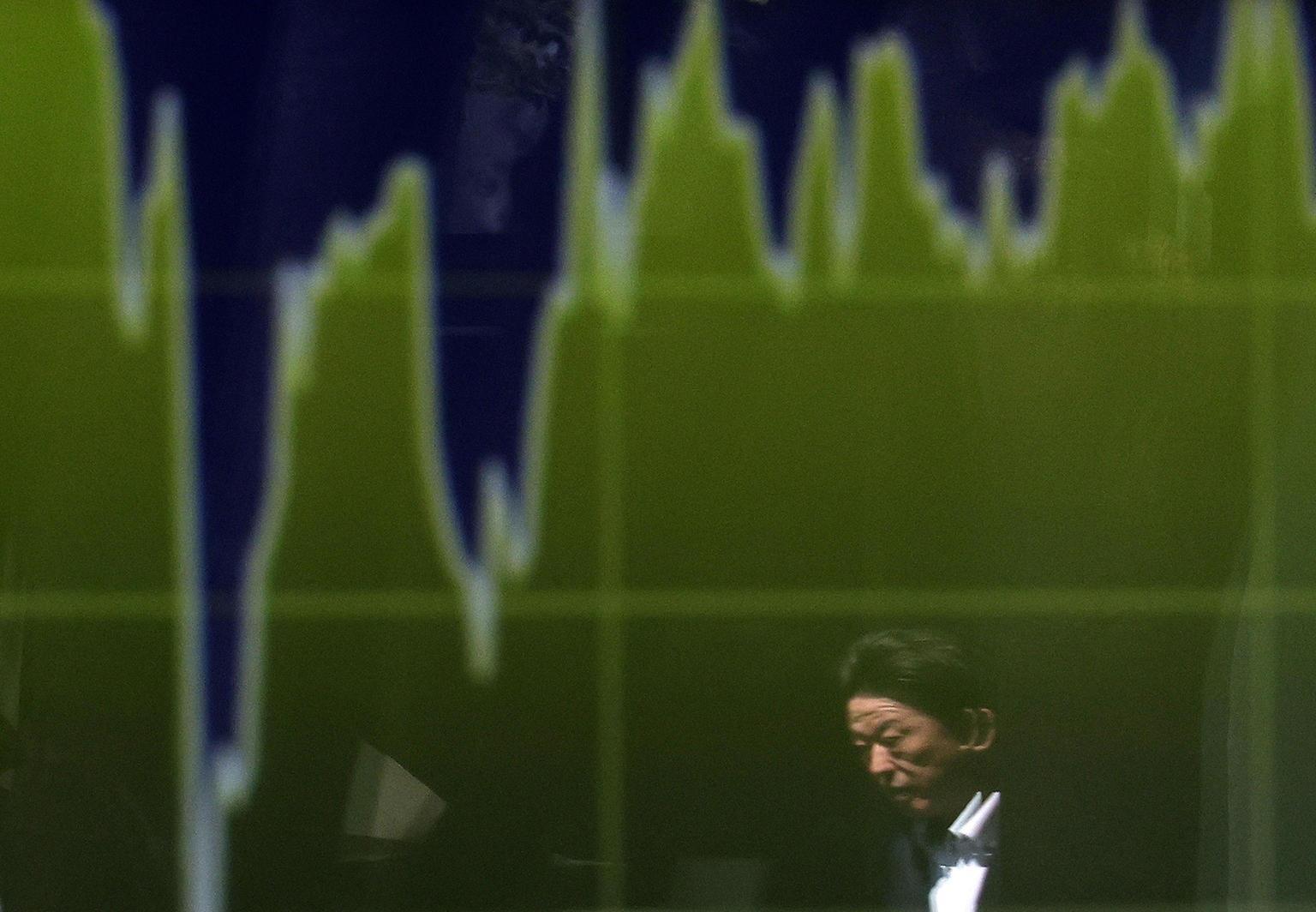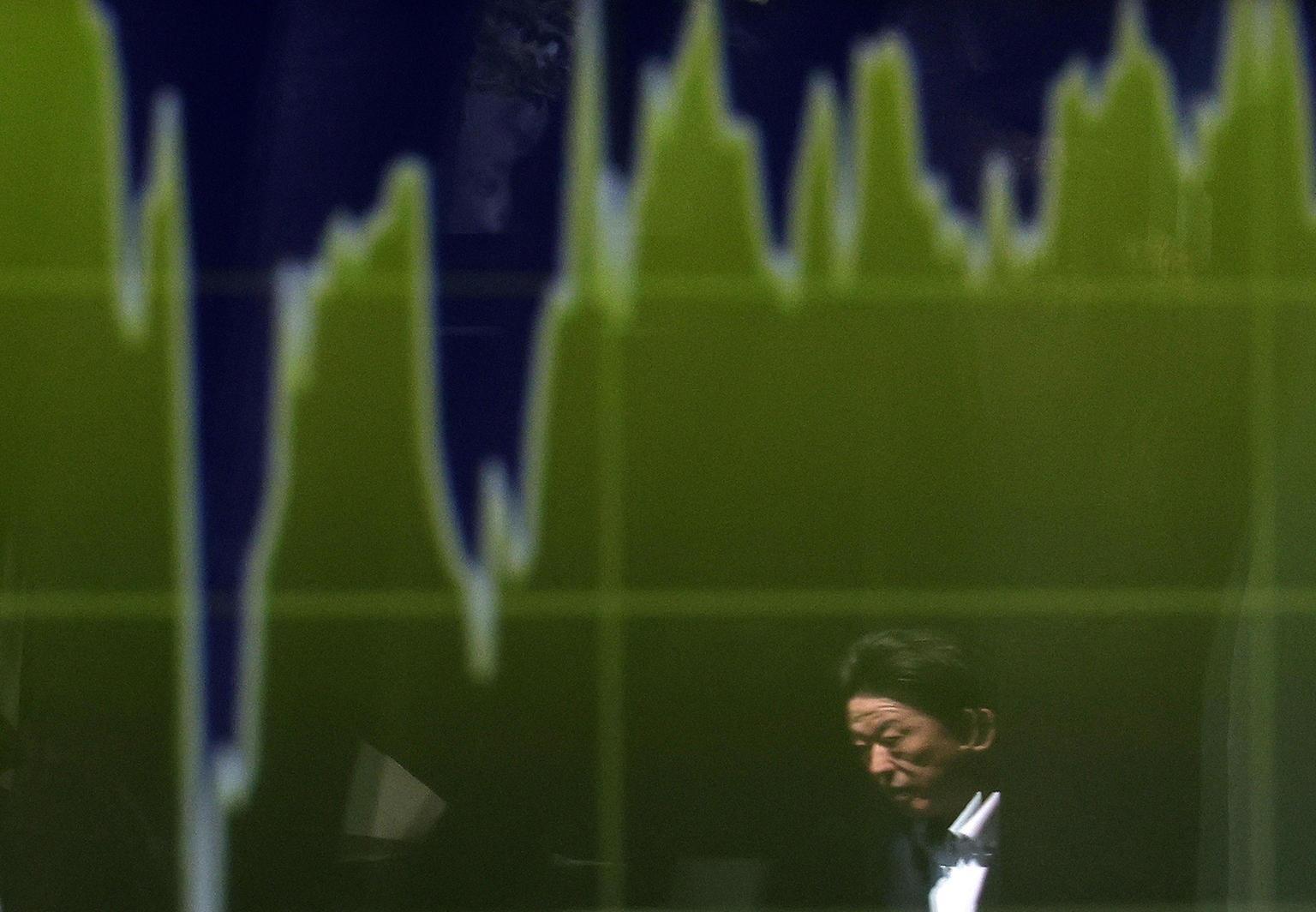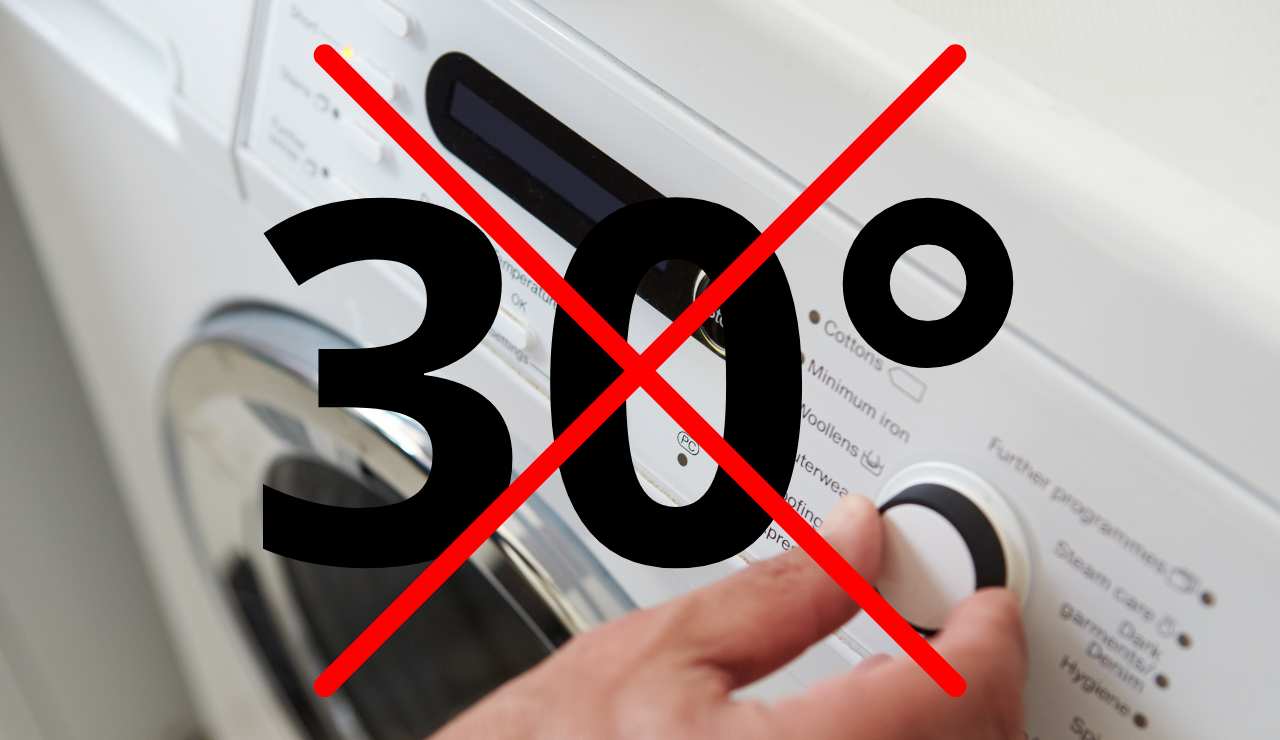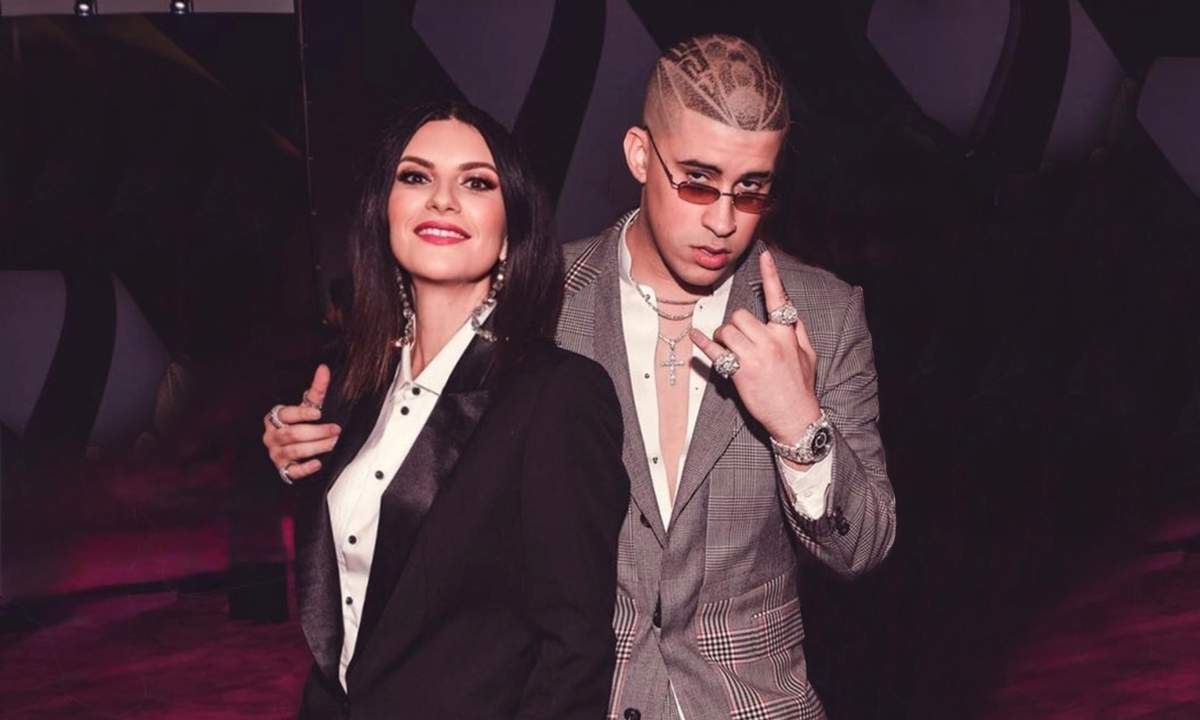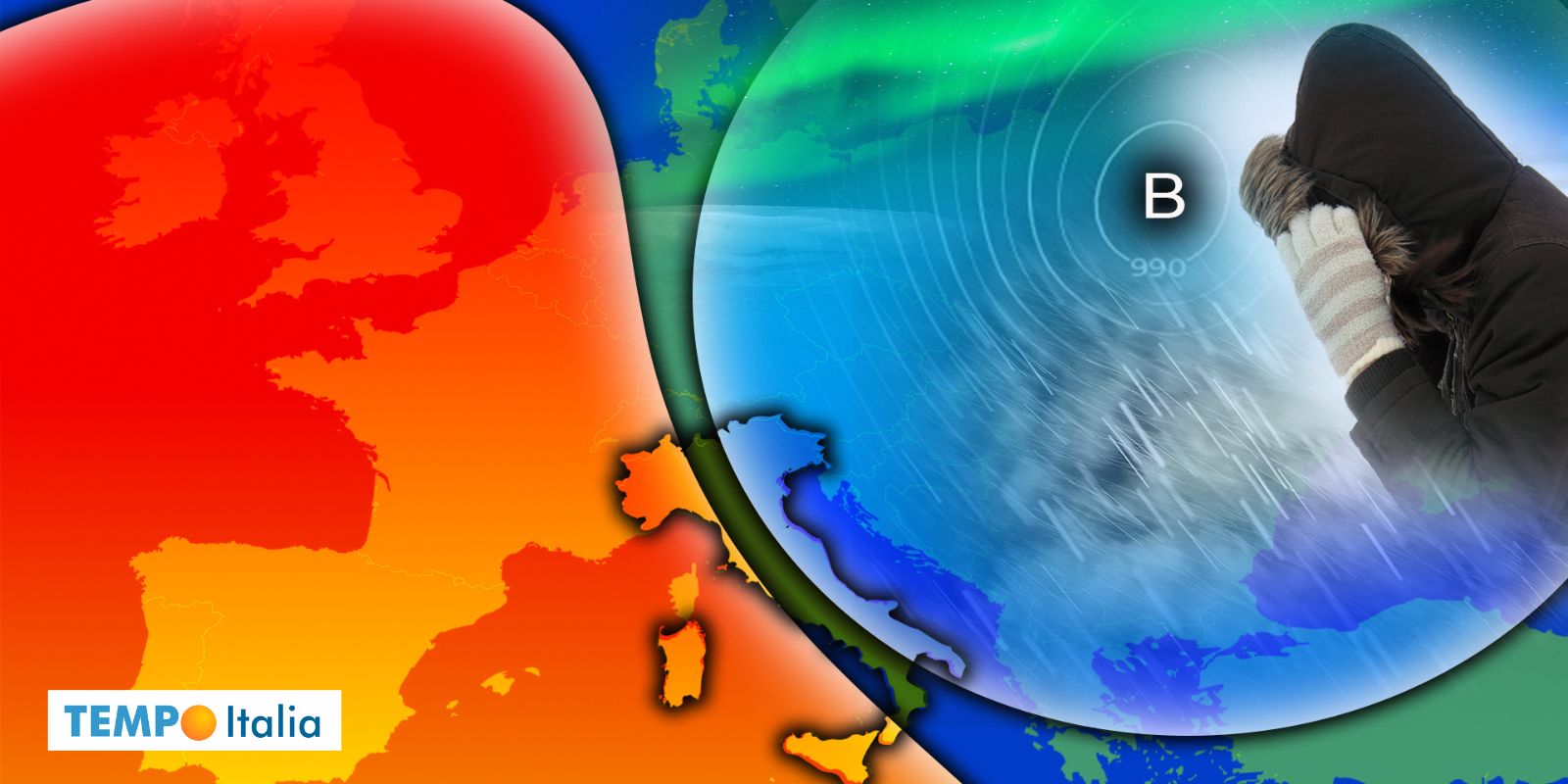Come è stata costruita la Basilica di San Pietro in Vaticano
L'origine della basilica di San Pietro risale alla sua costruzione nel IV secolo da parte dell'imperatore Costantino, nel luogo in cui si trovava il sepolcro dell'apostolo Pietro. Questa prima chiesa seguiva un progetto rivoluzionario, poiché introduceva nei templi cristiani un tipo di edificio, la basilica, che nel mondo romano era utilizzato per l'attività politica e si trovava nel foro. San Pietro nacque così come uno spazio di grandi dimensioni, diviso in tre navate porticate, alla cui estremità fu collocato un altare.Di fronte agli spazi bassi e raccolti dell'architettura a volta dell'Impero romano, la basilica costantiniana spiccava per la sua elevazione. Il tetto era in legno e le sue grandi colonne, riutilizzate da altri edifici romani e quindi di forme molto varie, raggiungevano i nove metri di altezza. Due di esse, in marmo nero africano, sono ancora conservate oggi, situate ai lati della porta centrale della basilica rinascimentale. La sua sontuosa decorazione interna presentava policromie e mosaici tipici dell'architettura paleocristiana.Con il passare dei secoli, la basilica romana subì un inevitabile deterioramento che si aggravò nel XIV secolo quando i papi trasferirono la loro sede nella città francese di Avignone. Fazio Degli Uberti, poeta fiorentino dell'epoca, scrisse di Roma che «sembrava una donna anziana, e tristi erano le sue vesti [...] il suo abito vecchio e logoro». San Pietro simboleggiava come nessun altro edificio il declino della capitale della cristianità. I suoi affreschi erano coperti di polvere e alcune pareti minacciavano di crollare.Costruzione della nuova basilicaD'altra parte, nel corso dei secoli erano state apportate numerose modifiche e aggiunte alla basilica, che ne avevano alterato la concezione originale. Secondo la testimonianza di un pellegrino inglese che vi si recò intorno al 1344, «se si perde il proprio compagno in questa chiesa, è possibile che lo si debba cercare per tutto il giorno, tanta è la sua grandezza e tanta la folla che corre da un luogo all'altro, prodigando nelle cappelle baci e preghiere».Un secolo dopo, San Pietro era ancora un'enorme basilica medievale, carica di simbolismo, ma in rovina. Era circondata da un amalgama di edifici con facciate e strutture diverse. E lo spazio che precedeva il complesso era letteralmente un terreno incolto.Nel XV secolo, con l'avvento del Rinascimento, furono condotti diversi studi sullo stato in cui versava il principale tempio della cristianità. Lo fece l'architetto fiorentino e funzionario papale Leone Battista Alberti, in diverse analisi raccolte nel suo trattato De re Aedificatoria (1450). In questo documento, Alberti riferiva della proliferazione di cappelle, delle modifiche apportate alle decorazioni delle porte, delle riparazioni dei tetti e dei difetti della struttura:«Nella basilica di San Pietro ho potuto osservare un elemento risolto in modo grossolano: un muro estremamente alto e lungo che è stato costruito su una serie continua di aperture, senza alcun arco che gli conferisca forza né alcun contrafforte che lo sostenga. Il muro è stato perforato da troppi fori lungo tutta la sua estensione ed è stato costruito in un luogo dove dovrà affrontare tutta la violenza dell'Aquilone [il vento del nord]. Di conseguenza, la forza continua del vento ha già spostato il muro in verticale di oltre sei piedi. Non ho alcun dubbio che, alla fine, una piccola pressione o il più leggero movimento farà crollare il muro».Tutto ciò rendeva urgente un restauro approfondito della basilica. Il papato, che nel 1420 era tornato a Roma sotto la guida di Martino V, sosteneva una rinascita della Chiesa cattolica che passava attraverso il recupero del passato glorioso delle chiese e dei monumenti di Roma, tra cui la basilica di San Pietro. Invece di un restauro, si optò per la costruzione di una nuova basilica secondo le linee dell'arte rinascimentale. Fu papa Niccolò V che nel 1447 decise che per simboleggiare il ritorno della Chiesa in Vaticano era necessaria una costruzione che rappresentasse una nuova fase per la Chiesa cattolica. Era necessario annunciare che la Chiesa tornava in città con il suo potere terreno e spirituale. Era necessario rifondare Roma.Ballo degli architettiIl progetto di Donato Bramante per la basilica di San Pietro, approvato da papa Giulio II nel 1506, prevedeva un disegno a forma di croce greca, con tutti i bracci della stessa lunghezza, in contrasto con la croce latina della basilica costantiniana. Il modello della croce greca nacque nelle chiese ortodosse dell'Impero Romano d'Oriente, a loro volta eredi di santuari di origine persiana. Adottare questa tipologia significava rompere con la tradizione latina e il modello della basilica romana.Bramante voleva che San Pietro a Roma simboleggiasse il rinnovamento della cristianità, quindi doveva differenziarsi da qualsiasi altra chiesa cattolica, ma altri lo videro come un tradimento degli antenati. Nei decenni successivi si mantenne l'indecisione tra i

L'origine della basilica di San Pietro risale alla sua costruzione nel IV secolo da parte dell'imperatore Costantino, nel luogo in cui si trovava il sepolcro dell'apostolo Pietro. Questa prima chiesa seguiva un progetto rivoluzionario, poiché introduceva nei templi cristiani un tipo di edificio, la basilica, che nel mondo romano era utilizzato per l'attività politica e si trovava nel foro. San Pietro nacque così come uno spazio di grandi dimensioni, diviso in tre navate porticate, alla cui estremità fu collocato un altare.
Di fronte agli spazi bassi e raccolti dell'architettura a volta dell'Impero romano, la basilica costantiniana spiccava per la sua elevazione. Il tetto era in legno e le sue grandi colonne, riutilizzate da altri edifici romani e quindi di forme molto varie, raggiungevano i nove metri di altezza. Due di esse, in marmo nero africano, sono ancora conservate oggi, situate ai lati della porta centrale della basilica rinascimentale. La sua sontuosa decorazione interna presentava policromie e mosaici tipici dell'architettura paleocristiana.
Con il passare dei secoli, la basilica romana subì un inevitabile deterioramento che si aggravò nel XIV secolo quando i papi trasferirono la loro sede nella città francese di Avignone. Fazio Degli Uberti, poeta fiorentino dell'epoca, scrisse di Roma che «sembrava una donna anziana, e tristi erano le sue vesti [...] il suo abito vecchio e logoro». San Pietro simboleggiava come nessun altro edificio il declino della capitale della cristianità. I suoi affreschi erano coperti di polvere e alcune pareti minacciavano di crollare.
Costruzione della nuova basilica
D'altra parte, nel corso dei secoli erano state apportate numerose modifiche e aggiunte alla basilica, che ne avevano alterato la concezione originale. Secondo la testimonianza di un pellegrino inglese che vi si recò intorno al 1344, «se si perde il proprio compagno in questa chiesa, è possibile che lo si debba cercare per tutto il giorno, tanta è la sua grandezza e tanta la folla che corre da un luogo all'altro, prodigando nelle cappelle baci e preghiere».
Un secolo dopo, San Pietro era ancora un'enorme basilica medievale, carica di simbolismo, ma in rovina. Era circondata da un amalgama di edifici con facciate e strutture diverse. E lo spazio che precedeva il complesso era letteralmente un terreno incolto.
Nel XV secolo, con l'avvento del Rinascimento, furono condotti diversi studi sullo stato in cui versava il principale tempio della cristianità. Lo fece l'architetto fiorentino e funzionario papale Leone Battista Alberti, in diverse analisi raccolte nel suo trattato De re Aedificatoria (1450). In questo documento, Alberti riferiva della proliferazione di cappelle, delle modifiche apportate alle decorazioni delle porte, delle riparazioni dei tetti e dei difetti della struttura:
«Nella basilica di San Pietro ho potuto osservare un elemento risolto in modo grossolano: un muro estremamente alto e lungo che è stato costruito su una serie continua di aperture, senza alcun arco che gli conferisca forza né alcun contrafforte che lo sostenga. Il muro è stato perforato da troppi fori lungo tutta la sua estensione ed è stato costruito in un luogo dove dovrà affrontare tutta la violenza dell'Aquilone [il vento del nord]. Di conseguenza, la forza continua del vento ha già spostato il muro in verticale di oltre sei piedi. Non ho alcun dubbio che, alla fine, una piccola pressione o il più leggero movimento farà crollare il muro».
Tutto ciò rendeva urgente un restauro approfondito della basilica. Il papato, che nel 1420 era tornato a Roma sotto la guida di Martino V, sosteneva una rinascita della Chiesa cattolica che passava attraverso il recupero del passato glorioso delle chiese e dei monumenti di Roma, tra cui la basilica di San Pietro. Invece di un restauro, si optò per la costruzione di una nuova basilica secondo le linee dell'arte rinascimentale. Fu papa Niccolò V che nel 1447 decise che per simboleggiare il ritorno della Chiesa in Vaticano era necessaria una costruzione che rappresentasse una nuova fase per la Chiesa cattolica. Era necessario annunciare che la Chiesa tornava in città con il suo potere terreno e spirituale. Era necessario rifondare Roma.
Ballo degli architetti
Il progetto di Donato Bramante per la basilica di San Pietro, approvato da papa Giulio II nel 1506, prevedeva un disegno a forma di croce greca, con tutti i bracci della stessa lunghezza, in contrasto con la croce latina della basilica costantiniana. Il modello della croce greca nacque nelle chiese ortodosse dell'Impero Romano d'Oriente, a loro volta eredi di santuari di origine persiana. Adottare questa tipologia significava rompere con la tradizione latina e il modello della basilica romana.
Bramante voleva che San Pietro a Roma simboleggiasse il rinnovamento della cristianità, quindi doveva differenziarsi da qualsiasi altra chiesa cattolica, ma altri lo videro come un tradimento degli antenati. Nei decenni successivi si mantenne l'indecisione tra i due modelli. Rafael Sanzio sosteneva la pianta a croce latina, mentre Antonio da Sangallo, Baldassare Peruzzi e Michelangelo tornarono alla forma a croce greca di Bramante. Infine, Carlo Maderno instaurò il modello latino definitivo, pur conservando il disegno del transetto proposto da Bramante come spazio centrale.
Alla fine Michelangelo fu nominato architetto pontificio nel 1546, all'età di 72 anni. Nella corrispondenza con Vasari, il suo primo biografo, Michelangelo scrisse: «Credo che Dio mi abbia affidato quest'opera». Subito elaborò un nuovo progetto per San Pietro che, in risposta ai difetti di quello di Sangallo, proponeva di eliminare i campanili e ogni eccesso ornamentale per ingrandire la cupola centrale e ottenere così una migliore illuminazione all'interno. Inoltre, le navate erano più piccole, il che avrebbe dovuto ridurre i costi di costruzione. Michelangelo seguì da vicino l'avanzamento dei lavori. «Se si potesse morire di vergogna e sofferenza, non sarei più vivo», disse dopo la demolizione del soffitto di una cappella mal progettata.
Un progetto senza precedenti
Quando fu nominato architetto pontificio nel 1546, Michelangelo riprese il modello a pianta centrale proposto da Bramante, ma aumentò la luminosità grazie a una cupola più grande che doveva poggiare su un tamburo ancora più alto. L'influenza di Brunelleschi è evidente nel disegno di questa nuova cupola. L'architetto scrisse a Firenze nel 1547 chiedendo dettagli tecnici sulla cupola di Santa Maria dei Fiori, il cui disegno a doppio guscio era a sua volta ispirato al Pantheon di Roma.
Si voleva così creare un effetto che esaltasse la luce naturale, mostrando al visitatore una pelle interna di grande leggerezza sostenuta dalla struttura esterna più pesante. La pelle interna, costruita dall'interno, è totalmente semisferica, mentre quella esterna ha una forma ovoidale più resistente. Michelangelo non vide mai la cupola finita e non ne iniziò nemmeno la costruzione. Il suo progetto fu ereditato da Giacomo della Porta, che si occupò di adattare il progetto e di dirigere i lavori, che terminarono nel 1590.
La forma definitiva della basilica di San Pietro fu fissata dall'architetto Carlo Maderno nel 1607. Il suo obiettivo era quello di dare coerenza a una chiesa che, dopo oltre un secolo di lavori, non era ancora stata completata e in cui si combinavano sezioni nuove con altre risalenti a più di un millennio fa. Maderno, nipote di Domenico da Fontana, ampliò le tre navate di accesso alla basilica per conferirle una struttura definitiva a croce latina. Questo prolungamento crea un interessante effetto spaziale, poiché entrando nel tempio il visitatore non può fare a meno di dirigere lo sguardo verso la cupola mentre avanza in linea retta. Heinrich Wölfflin, storico del XIX secolo, definiva questo effetto «spazio diretto verso l'infinito».
Va inoltre tenuto presente che San Pietro è una chiesa monumentale unica nel suo genere, concepita per il pellegrinaggio e gli eventi di massa e non per le cerimonie di culto convenzionali. Il progetto di Maderno includeva l'attuale facciata della basilica, che fu completata nel 1615. Il suo disegno differiva notevolmente dalle proposte precedenti e fin dall'inizio fu oggetto di critiche per lo stile troppo ricercato e per il fatto che l'attico nascondeva alla vista parte della cupola maggiore.
Secondo lo specialista James Lees-Milne, «anche il più imparziale dei critici ammette che [la facciata] fu un errore e alcuni sono dell'opinione che sia né più né meno un disastro». Maderno progettò anche due bracci laterali terminanti in campanili, che non furono mai costruiti.
Un prodigio del barocco
La decorazione interna di San Pietro fu intrapresa nella seconda metà del XVII secolo e riflette lo stile barocco dell'epoca. Il suo principale artefice fu il geniale scultore Gian Lorenzo Bernini, che godette del patrocinio di papa Urbano VIII. Il primo grande contributo di Bernini fu il baldacchino che sovrasta l'altare maggiore, eretto tra il 1626 e il 1633. La sua altezza di 28,5 metri, le quattro colonne salomoniche e le decorazioni creano un effetto di tensione che riempie di forza lo spazio centrale della basilica.
Il progetto del baldacchino ispirò la ristrutturazione e la decorazione sia dei pilastri centrali che delle colonne della navata principale, segnando lo stile che si sarebbe poi diffuso in tutto l'edificio. Ogni angolo dello spazio interno contiene decorazioni riferite a santi e pontefici, spesso incorniciate da motivi vegetali.
Sulle pilastri della navata centrale si trovano medaglioni con i ritratti dei primi papi, sostenuti da angeli. Bernini si occupò anche personalmente di scolpire la statua di San Longino come parte del transetto centrale, dedicata al centurione romano che trafisse il costato di Cristo con la lancia.
Una piazza aperta al mondo
Nel 1655, papa Alessandro VII incaricò Bernini di progettaredue colonnati che racchiudessero la piazza di San Pietro, delimitando lo spazio che precedeva la basilica. Bernini progettò due grandi bracci di sobrie colonne doriche, che formano un'ellisse con l'obelisco al centro. Dalla fine di questi colonnati nascono due bracci rettilinei che formano un trapezio con la facciata della basilica, creando un secondo spazio di accoglienza. Questo disegno provoca un effetto ottico che sembra avvicinare la facciata di San Pietro alla piazza ellittica, correggendo in parte l'orizzontalità del disegno di Maderno.
Bernini progettò un terzo colonnato che incorniciava l'accesso alla basilica dal ponte di Sant'Angelo, il che comportava la demolizione di parte delle abitazioni del quartiere di fronte al Vaticano, il Borgo. Ma né il suo progetto né altri simili proposti in seguito furono mai realizzati.
Alla fine fu Mussolini che, nel 1937, aprì una strada monumentale conosciuta come Via della Conciliazione, completata nel 1950. Da allora San Pietro ha continuato a trasformarsi, attraverso le sue rappresentazioni nei grandi media, nel cinema e in televisione. San Pietro rimane un simbolo vivente, sempre al passo con i tempi.