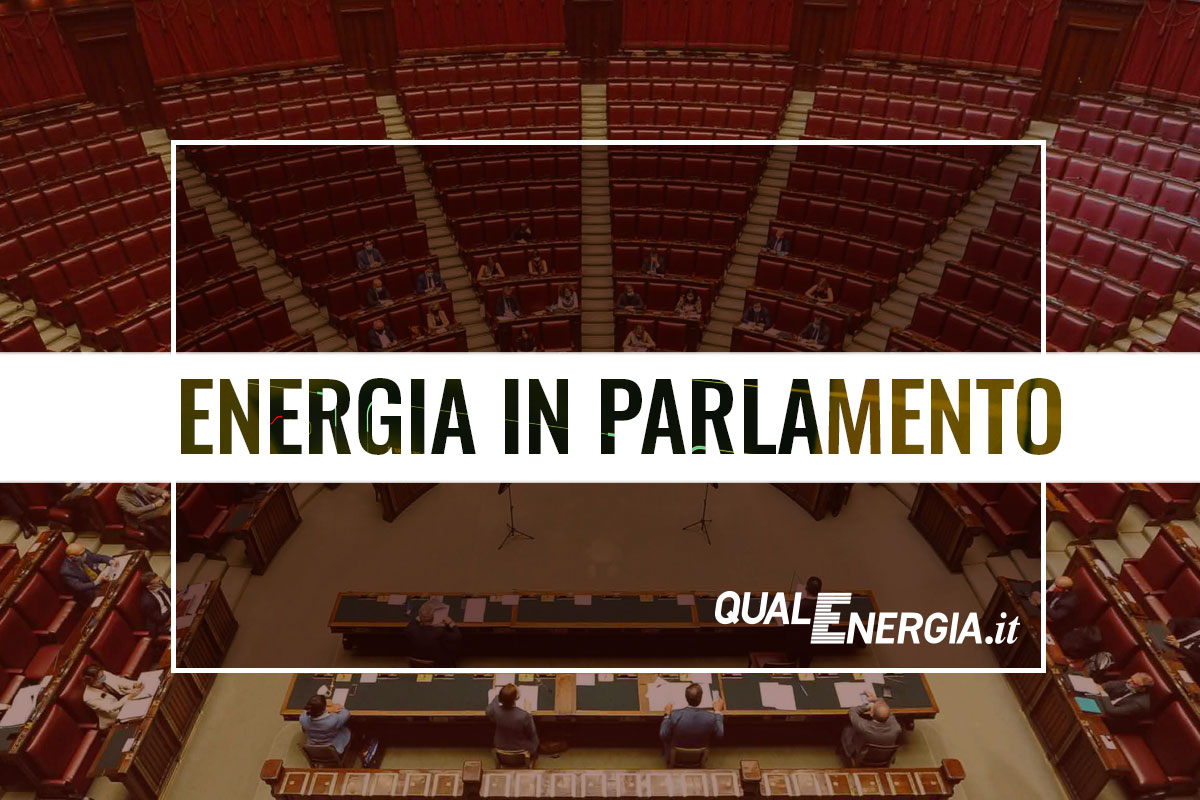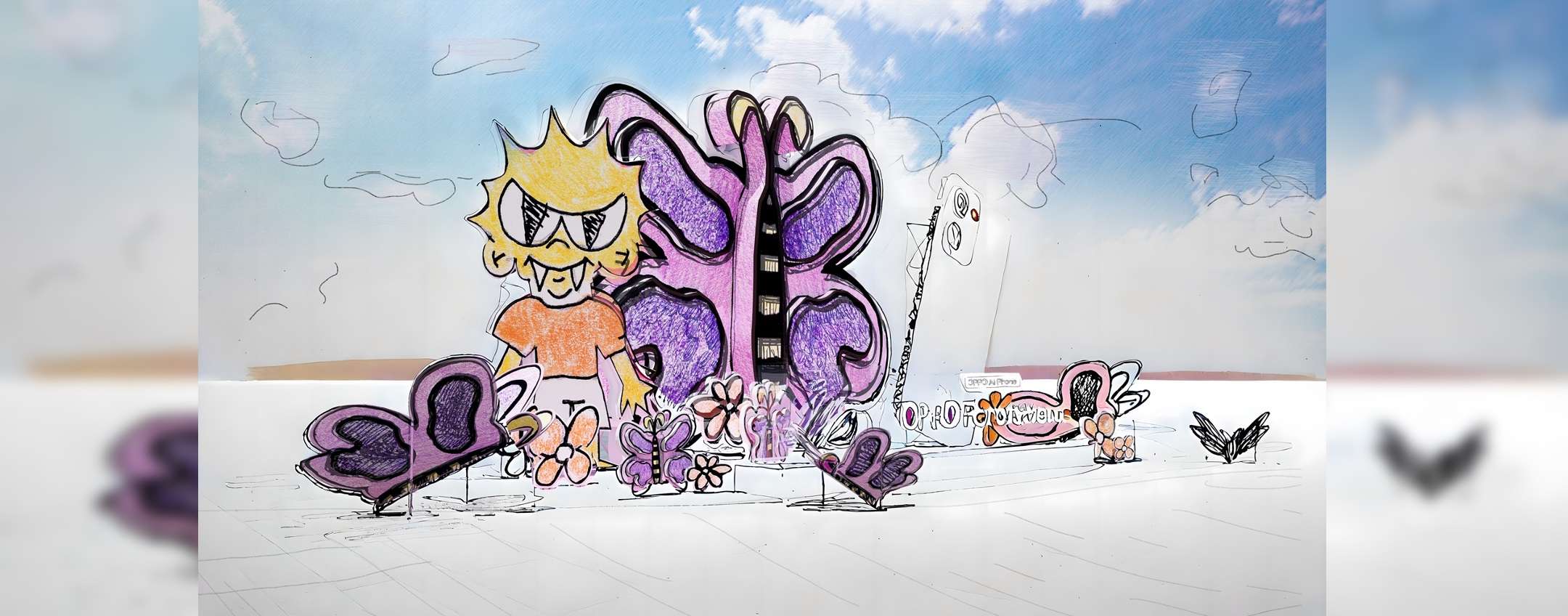50 anni fa in Cambogia iniziava uno dei genocidi più atroci della storia
Nell’aprile del 1975 i Khmer Rossi presero il controllo di Phnom Penh, instaurando uno dei regimi più violenti del Novecento.

“Phnom Penh è diventata una città fantasma, svuotata dei suoi abitanti con la forza: circa due milioni di persone. I Khmer Rossi hanno marciato nelle strade e hanno ordinato a quanti più cittadini possibile di abbandonare le città. Il risultato è stato un esodo di massa, una migrazione forzata di centinaia di migliaia di persone che sono state obbligate a lasciare le proprie case, a prendere con sé quel poco che potevano e a dirigersi verso le campagne per lavorare nei campi collettivi”. Iniziava così un articolo pubblicato dalla rivista statunitense Time il 19 maggio 1975, dal titolo “La lunga marcia da Phnom Penh”. Un articolo che raccontava, quasi in presa diretta, l’esodo verso le campagne a cui fu costretta la popolazione della capitale cambogiana, in quello che fu l’inizio di un incubo che durò quattro anni. E che si trasformò in uno dei genocidi più atroci della storia.
Chi erano e cosa volevano i Khmer Rossi in Cambogia
Tutto ebbe inizio il 17 aprile 1975. Quando, dopo cinque anni di guerra civile, i Khmer Rossi guidati dal generale Pol Pot entrarono nella capitale Phnom Penh. Inizialmente furono accolti con un timido entusiasmo dalla popolazione, illusa che quel cambio di scenario potesse mettere fine alle ostilità tra i Khmer Rossi e le forze governative della Cambogia, sostenute dagli Stati Uniti e dal Vietnam del Sud.
Ci volle poco però per ricredersi. Poche ore dopo essere entrati in città, i Khmer Rossi imposero l’evacuazione forzata dell’intera popolazione, costretta a trasferirsi nelle campagne per lavorare i campi di riso. “Testimoni oculari hanno descritto scene di estrema brutalità – raccontava il Time –. I soldati dei Khmer Rossi che hanno preso il controllo di Phnom Penh hanno ordinato alle persone di lasciare la città, spingendole a bastonate o col calcio dei fucili, e sparando a chi esitava”.
L’obiettivo dei Khmer Rossi, il movimento di guerriglieri comunisti nato negli anni Sessanta come una divisione dell’esercito popolare del Vietnam del Nord, era quello di trasformare la Cambogia in una sorta di repubblica socialista agraria utopica basata su principi maoisti portati all’estremo. Un esperimento sociale senza precedenti, che per essere attuato richiedeva lo svuotamento delle città per ripopolare le campagne, fulcro della nuova società cambogiana. Lì sorsero campi di lavoro dove persero la vita centinaia di migliaia di persone.

Il nuovo regime voleva cancellare ogni traccia del mondo capitalista precedente, considerato corrotto e borghese. Si arrivò al punto di bruciare le biblioteche e proibire l’uso degli occhiali, perché, secondo il nuovo ordine politico, elevavano la persona allo status di intellettuale, una casta che doveva essere eliminata. In nome della nuova ideologia, fu ordinato di distruggere tutti i veicoli a motore per riportare in auge i carri tirati dai muli, simbolo di un ritorno alla vita agricola.
Anche la medicina occidentale venne rifiutata: i leader sostenevano che il popolo poteva curarsi con i rimedi tradizionali, attingendo alla “saggezza contadina”, e per questo l’uso dei farmaci fu vietato.
Nella visione totalitaria di quel regime sanguinario, solo i contadini erano considerati moralmente puri, immuni dalla “contaminazione capitalista” che secondo i dirigenti aveva avvelenato il Paese. Tutti gli altri – abitanti delle città, letterati, professionisti – erano ritenuti “elementi pericolosi” da rieducare o eliminare.
Gli orrori del regime cambogiano

Uno dei primi ordini impartiti da Pol Pot fu chiaro: epurare tutti i potenziali oppositori. Caddero per primi gli alti funzionari e i militari del vecchio regime, poi toccò a professori, medici, avvocati, chiunque conoscesse una lingua straniera o fosse identificabile come intellettuale. Nessuno era al sicuro: bastava sapere leggere, o anche solo portare gli occhiali, per essere sospettati di essere “nemici della rivoluzione”.
Nella nuova realtà totalitaria della Kampuchea democratica, il nome che i Khmer rossi diedero alla Cambogia negli anni del regime, i cittadini non avevano praticamente più alcun diritto: furono aboliti i diritti civili e politici, la proprietà privata, le pratiche religiose, le lingue minoritarie e gli abiti stranieri. Furono prese di mira le minoranze etniche, in particolare cinesi, vietnamiti e i membri della minoranza cambogiana Cham.
Si stima che in appena quattro anni fu decimato circa il 25 per cento della popolazione cambogiana, uccisa per le violenze inflitte dai Khmer Rossi – magari in prigione o nei tristemente noti Killing Fields, i luoghi di detenzione dove venivano giustiziati gli oppositori – o morta per fame, malattie, esecuzioni sommarie e assenza di cure mediche. A seconda delle fonti, le stime parlano di 1,5-3 milioni di persone uccise.
Gli artefici delle mattanze erano spesso ragazzi giovanissimi, rimasti orfani o strappati alle loro famiglie per essere indottrinati e sottoposti a un’intensa “riforma del pensiero”, che li avrebbe portati a essere vigili non solo nei confronti dei prigionieri, ma anche dei loro compagni, con l’ordine di eliminare qualsiasi elemento contrario alla rivoluzione.
Secondo uno studio pubblicato su Science Direct, nonostante siano passati più di quarant’anni, ancora oggi i sopravvissuti e loro discendenti continuano a soffrire di stress cronico traumatico e angoscia mentale.