«Nell’impossibilità di poterci veder chiaro, almeno vediamo chiaramente le oscurità.»
(Sigmund Freud)
Il ricorso è manifestamente inammissibile, poiché «privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio (imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 3 c.p.c.); di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; di qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima».
In secondo luogo:
- a) tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e quelle poste a fondamento dell’appello;
- b) contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati;
- c) contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Il giudizio della Terza Sezione Civile è tranchant: «Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso»[1].
Senza soluzione di continuità si pongono tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: excerpta multorum, l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il § 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente di “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v. Nygren, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).
D’altronde, la vanità è decisamente il peccato preferito dagli avvocati (semicit. John Milton) e la Corte Suprema di Cassazione ha cercato di emendarlo, perlomeno nella sua variante redazionale.
___________________________________________________________________________
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 16089; Cass. Civ., Sez. VI, 23 settembre 2021, n. 25892; Cass. Civ., Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6546; Cass. Civ., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 24697; Cass. Civ., Sez. VI, 28 maggio 2020, n. 9996; Cass. Civ., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425.










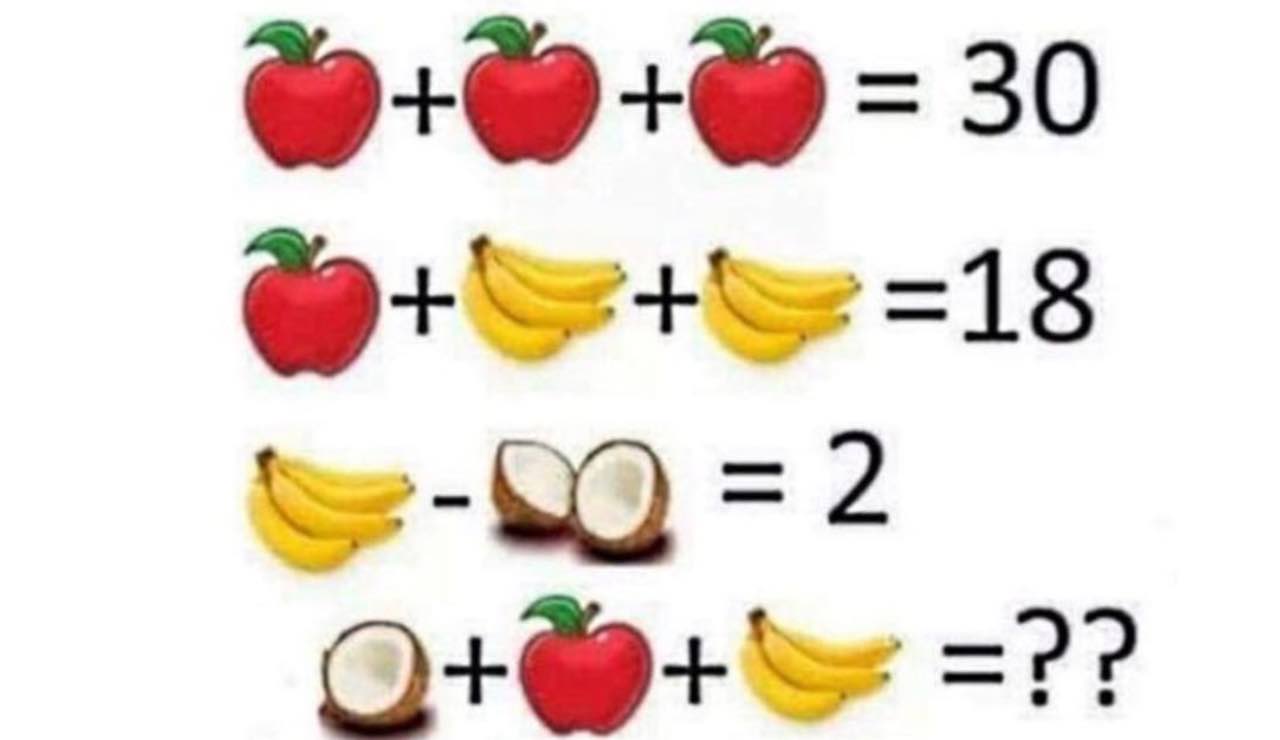






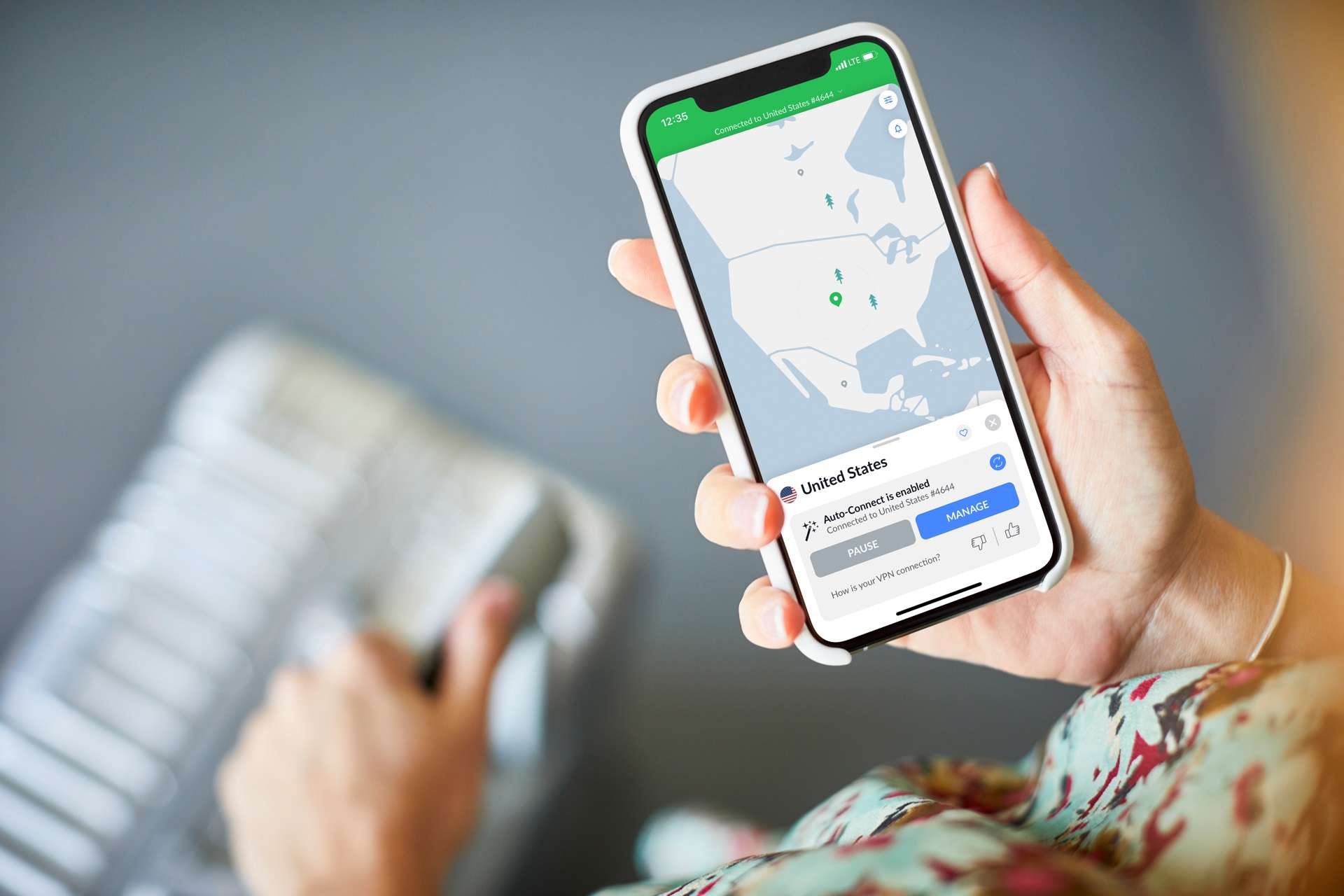























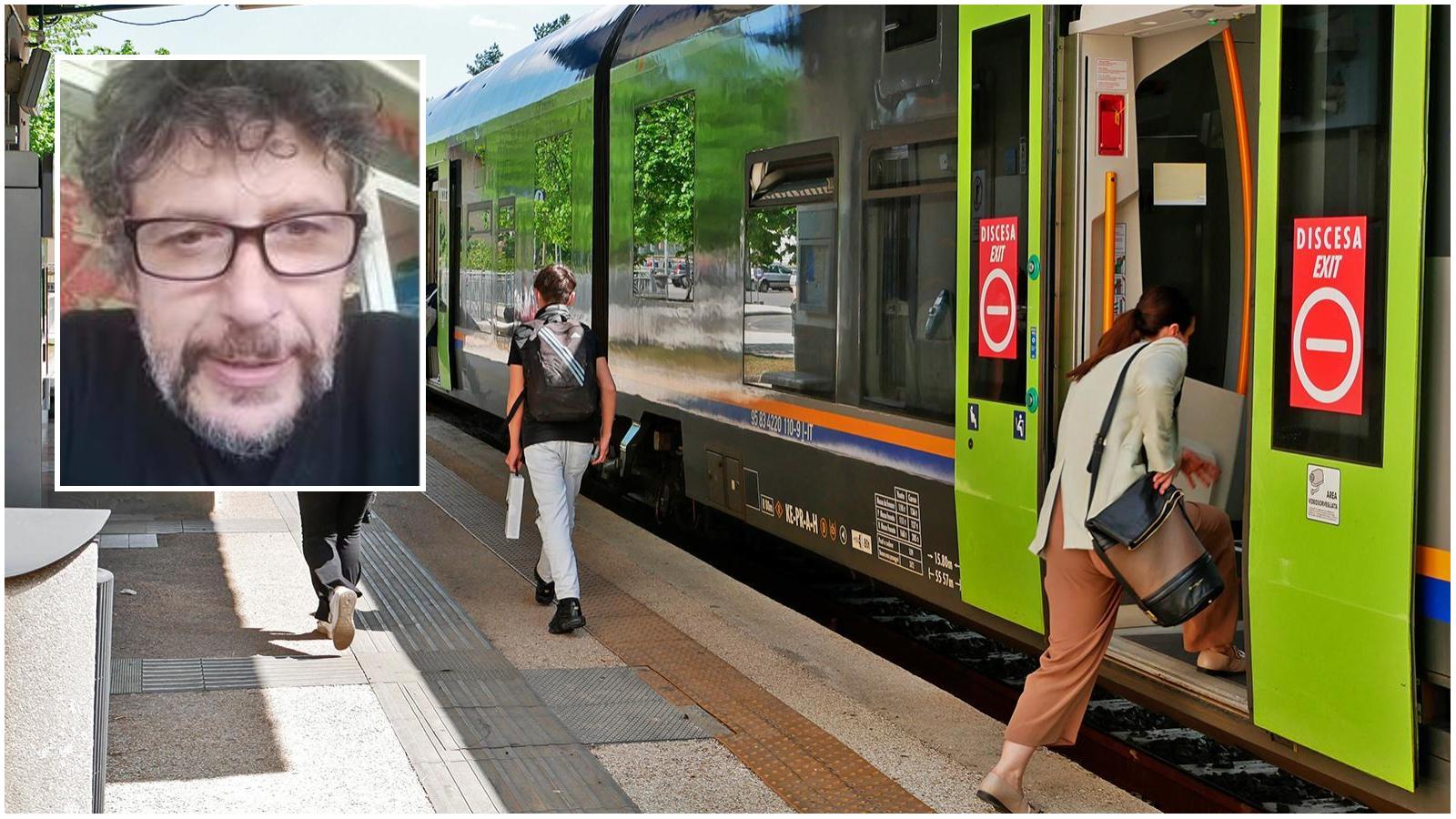














 Iscriviti alla nostra newsletter settimanale
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale


