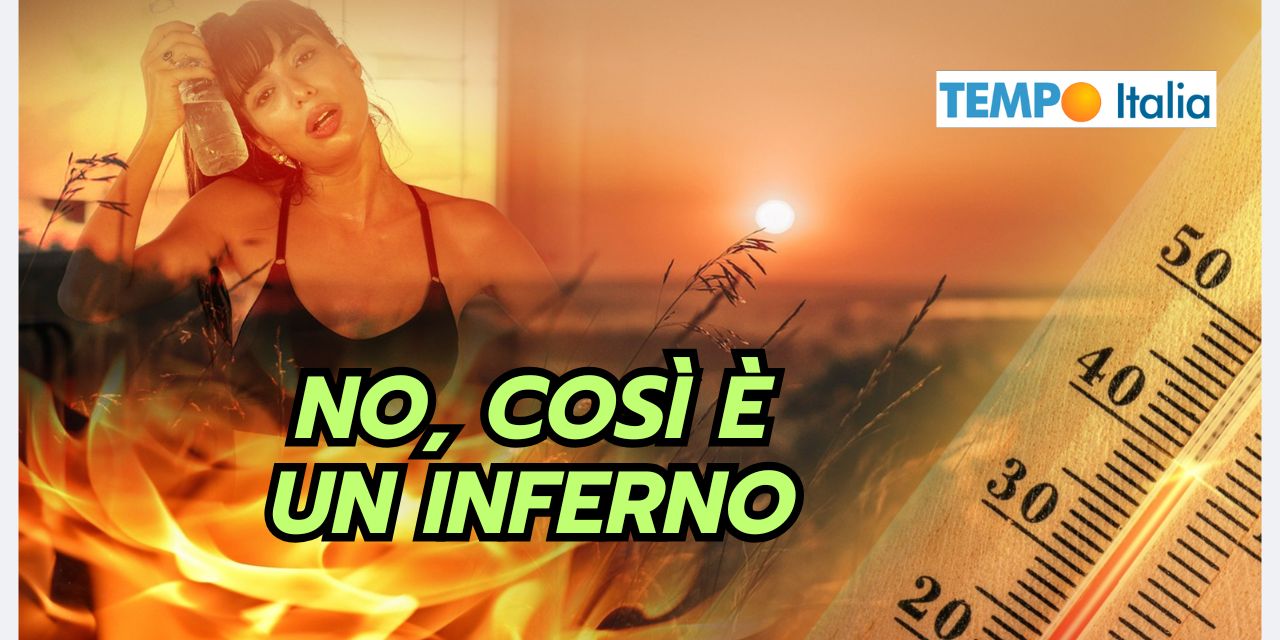Siamo cresciuti incollati al digitale, senza la gioia degli incontri reali. La rivogliamo indietro.
Dopo anni passati a crescere stando incollati agli schermi, ora sentiamo il forte bisogno di recuperare la gioia di relazioni più umane, tornando a incontrarci e conoscerci dal vivo. Siamo infatti arrivati a rimpiangere il rapporto diretto con una realtà che di per sé sarebbe fisicamente vicina, ma che sembra invece allontanarsi sempre di più, dal momento che continuiamo a guardarla attraverso i nostri dispositivi, nonostante il loro impatto sul nostro benessere mentale. L'articolo Siamo cresciuti incollati al digitale, senza la gioia degli incontri reali. La rivogliamo indietro. proviene da THE VISION.

Nel 2013, quando è uscito Her di Spike Jonze, ricordo bene di essere andata a vederlo al cinema appena ne ho avuto l’occasione, come si fa con i film a cui si attribuisce l’aura del cult in potenza. Non capita sempre che le previsioni e le stelline delle anteprime stampa ci azzecchino, ma questo è stato indubbiamente uno di quei casi in cui le aspettative hanno corrisposto con la realtà. Nei dodici anni che sono trascorsi da quel momento Her, il racconto della storia d’amore tra lo scrittore Theodore Twombly – interpretato da Joaquin Phoenix – e un sistema operativo intelligente che si chiama Samantha – e ha la voce di Scarlett Johansson – non solo ha ottenuto il successo previsto, ma continua a essere considerato una lettura sorprendentemente lucida del nostro presente – in cui, tra l’altro, il film è ambientato, dato che la trama si svolge proprio nel 2025. Per questo, se ne continua ancora a parlare da diversi punti di vista: come film profezia sul nostro rapporto con l’AI – che oggi iniziamo a utilizzare come confidente, psicologa, medica di base –, come capsula del tempo che conserva i nostri sogni sul futuro e forse anche l’ingenuità del tecno-ottimismo degli anni Dieci, come opera che ha ampliato il genere della fantascienza, mixandolo in modo inedito con il melò, e molto altro. Quando si parla del potere profetico del film, mi pare però che si dia ancora sempre per scontato che nel giro di un decennio siamo diventati quasi tutti Theodore, innamorati di dispositivi intelligenti che probabilmente non vorremmo fossero dotati di piena coscienza, ma da cui ci aspettiamo la capacità di “ricambiarci” emotivamente, se non altro a fronte di tutte le ore che dedichiamo loro. A ben guardare, però, da tempo non parliamo più del progresso tecnologico come qualcosa che amiamo incondizionatamente, tanto che stando ai dati più recenti, il 95% dei giovani in Italia è convinto che l’utilizzo di dispositivi tecnologici vada limitato per preservare il proprio benessere mentale. Le ragioni alla base di questa presa di coscienza sono numerose – come evidenzia la recente ricerca Changes Unipol svolta su un campione di italiani tra i 16 e i 35 anni – a partire dalla mancanza di sonno percepita dal 57% dei ragazzi, che dichiara di usare lo smartphone fino a tarda notte, passando per la riduzione delle prestazioni a scuola e al lavoro evidenziata dal 30% di loro, per arrivare, soprattutto, al declassamento delle relazioni faccia a faccia, che per il 40% degli intervistati sono ormai decisamente più rare di quelle online.

Quest’ultimo dato, in particolare, giustifica il sentimento di rimpianto che soprattutto i giovani hanno di recente iniziato a provare nei confronti dei rapporti reali, non virtualmente mediati, e del contatto umano, che non rappresentano più un dato scontato dell’esperienza sociale, da quando gli schermi che abbiamo sempre in tasca – e in testa – si sono fatti intermediari di ogni nostro rapporto con il mondo. Per sanare questo sentimento negativo, infatti, sembra che ultimamente tra le nuove generazioni stia rifiorendo l’interesse per la socialità offline, tra locali che chiedono di lasciare il telefono all’ingresso o di oscurare la fotocamera con un adesivo per godersi a pieno feste e concerti, eventi dedicati a persone single esauste delle app di dating, gruppi di lettura, cineforum, incontri culturali che ritornano alla loro forma originaria in presenza, dopo anni di esilio su Zoom.
Quella che oggi deleghiamo alla tecnologia digitale è infatti una parte sostanziale della nostra esperienza emotiva e relazionale. Lo abbiamo fatto a lungo senza preoccuparcene, e trovando modi sempre più capillari e totalizzanti per renderlo possibile: tenendo traccia dei nostri rapporti nel tempo attraverso le chat, godendo delle scariche di dopamina ricevute insieme ai like di approvazione, portandoci dietro uno smartphone da cui siamo inseparabili, quasi fosse un talismano, una memoria esterna in cui custodire parte dei gigabyte del nostro io. Questi fattori hanno determinato un legame intenso, a metà tra la dipendenza e la mutazione antropologica, difficile da spiegare per chi non ci è cresciuto, e quindi non si è abituato a dare per scontata la presenza di una “protesi tecnologica” della nostra dimensione affettiva.

Da un lato, quest’abitudine di filtrare la nostra esperienza relazionale attraverso gli schermi digitali ci ha senz’altro permesso di sentirci protetti, riparati, difesi da uno scudo che ci ha consentito di evitare alcuni degli aspetti più imprevedibili e potenzialmente “scomodi” dei rapporti reali – come l’imbarazzo dei primi incontri, il confronto diretto con l’altro, la possibilità di non piacere a qualcuno che invece ci interessa, nel momento in cui ci conoscerà dal vero e non solo tramite qualche foto e la selezione di informazioni che gli abbiamo fornito in chat. Dall’altro lato, però, questa sensazione di sicurezza e conforto ci ha reso sempre più dipendenti dai dispositivi tecnologici che ci illudono di poterci proteggere dai presunti “inconvenienti” della relazionalità offline – con vari sintomi d’astinenza come l’ansia di non poter rispondere ai messaggi quando il telefono rimane senza batteria, o la frustrazione di non poter condividere un momento appena fotografato con la nostra rete di contatti social, in mancanza di una rete wifi –, disabituandoci inevitabilmente al contatto faccia a faccia. Quasi che per non dover affrontare la parte della realtà e dei rapporti che esula dal nostro potere decisionale, ci stessimo abituando a rinunciare alla stessa capacità di sentire, recepire, incontrare l’altro senza l’aiuto di un’interfaccia digitale.

L’onnipresenza di questa barriera è per me un dato di fatto da quando avevo quindici anni, l’età in cui ho conosciuto in chat la prima persona con cui poi sarei uscita. Non ricordo quasi nulla delle nostre interazioni, ma conservo ancora fissato in mente il suono delle notifiche, la casella di posta virtuale bianca e la cornice blu di Facebook. Ricordo, soprattutto, che nonostante avessi tutte le occasioni di incontrare questa persona dal vivo, e sapessi benissimo come fosse fatta in carne e ossa, quel rapporto epistolare digitalizzato ha rappresentato a lungo il luogo di ogni nostro scambio, perché conoscersi dal vivo faceva troppa paura a entrambi. Sembra banale, se penso a quanti adolescenti possano aver vissuto la stessa esperienza, magari addirittura innamorandosi senza essersi mai parlati al di fuori di una chat room. Ma a guardarla da fuori quella che coltiviamo in rete da anni assomiglia a tutti gli effetti a una nuova categoria del sentire, che per un motivo o per l’altro ci ha portato a vivere sui nostri corpi non ancora adulti il distanziamento dagli affetti analogici, ora sempre più dispersi nel prisma digitale. E questa evoluzione per di più ci è sembrata irresistibile, perché ci ha provocato tonnellate di piacere, garantendoci l’appagamento della socialità senza doverci del tutto impegnare nei suoi oneri – dato che, per esempio, la responsabilità di ciò che scriviamo online sembra appartenerci di meno, nel momento in cui la condividiamo con un avatar digitale, e la possibilità di disattivare le notifiche e archiviare le conversazioni nel caso l’interlocutore o i suoi argomenti non ci vadano più a genio rimane sempre a portata di mano.

Di qui quel distacco tra noi e il mondo si è ispessito sempre più, plasmando la nostra stessa capacità di “sentire” (proprio nel momento in cui era sul punto di formarsi). Il sentimento di mancanza che proviamo per la realtà offline, infatti, è arrivato ad assomigliare alla nostalgia che il filosofo tedesco Martin Heidegger definiva nel suo saggio Chi è lo Zarathustra di Nietzsche? “il dolore per la vicinanza del lontano”. L’accostamento di questi due termini opposti, all’interno dell’opera, serviva ad Heidegger per descrivere quella mancanza in senso temporale che si instaura quando il desiderio di ripercorrere un’esperienza della nostra vita è tanto forte da metterci in conflitto con il nostro passato, proprio perché in un certo senso lo vorremmo poter riavvolgere, vorremmo tenercelo vicino invece di osservarlo mentre si allontana dal presente. Oggi, il desiderio è lo stesso, ma ha cambiato contesto, perché a causa del nostro rapporto disfunzionale con la tecnologia lo vediamo trasposto sul piano spaziale. Siamo infatti arrivati a rimpiangere il rapporto diretto con una realtà che di per sé sarebbe fisicamente vicina, ma che sembra invece allontanarsi sempre di più, dal momento che continuiamo a guardarla attraverso gli schermi dei nostri dispositivi, quasi fossero teche chiuse che ci impediscono di toccarla.

Quello che non ci siamo chiesti con abbastanza insistenza, mentre i dispositivi digitali diventavano contenitori e custodi della nostra esperienza affettiva, è dunque se questa evoluzione corrisponda ai nostri reali desideri di umanità futura, e se ci faccia davvero bene, o se non stia già diventando qualcosa di difficile da sopportare per gran parte di noi. Non abbiamo avuto il coraggio di domandarcelo, probabilmente, perché in un contesto che ci ha insegnato a preoccuparci soltanto di noi stessi come singoli, individui isolati, monadi indipendenti dagli altri, vivere i rapporti umani a una certa distanza ci è sembrata la soluzione più naturale, quella che ci poteva permettere di non distrarci mai dalle richieste del nostro ego, e la tecnologia ci ha semplicemente dato gli strumenti adeguati per realizzarla.
Se gran parte dei giovani italiani ha sviluppato una forte consapevolezza della nocività del proprio rapporto con la tecnologia digitale, però, è perché ora come ora ne vede chiaramente gli effetti sul proprio stato d’animo, soprattutto dal punto di vista relazionale. Questo sentimento di nostalgia sembra infatti essere qui per sottolineare quanto di fatto la realtà che tanto ci manca sia rimasta al suo posto, e stia a noi fare qualcosa per riavvicinarci ad essa e al tipo di socialità che ci offre. Soprattutto, sembra volerci ricordare che nonostante il rapporto di simil fusione con le tecnologie digitali – e la distanza che questo ha determinato rispetto al mondo offline – sia senz’altro l’elemento che ha definito maggiormente l’identità emotiva, psicologica, affettiva e sociale della generazione dei miei coetanei e delle successive, questa evoluzione non abbia rappresentato un passaggio necessario. Al contrario, gli strumenti tecnologici non hanno fatto altro che assecondare le aspirazioni di una società sempre più individualista ed egoriferita, dandoci ciò di cui pensavamo di avere bisogno per stare bene da soli, o al massimo connessi – cioè insieme a metà. Il riemergere di un desiderio di socialità reale, in questo contesto, è quindi rilevante proprio perché va nella direzione diametralmente opposta, dimostrandoci quanto la prospettiva di perdere la porzione della nostra esperienza che riguarda il contatto umano, reale, tangibile con gli altri sia del tutto incompatibile con la nostra felicità – che dipende fortemente, da sempre, anche dalla possibilità di viverci in senso pieno i legami con le persone a cui teniamo.

La spinta aggregatrice che sta facendo lentamente rinascere le occasioni di incontro faccia a faccia può dunque rappresentare un primo momento di riconoscimento di alcune delle incrinature nella nostra relazione con la tecnologia, permettendoci di ragionare, in particolare, su come qualsiasi innovazione tecnologica non faccia altro che facilitare e reiterare dinamiche sociali e umane già presenti in un determinato contesto. In questo caso, è stato infatti l’individualismo che permea la nostra società a sfilacciare e indebolire i nostri rapporti con gli altri, ben prima di fornirci gli schermi dietro i quali ci siamo barricati. Dal punto di vista tecnologico, infatti, una delle grandi sfide del nostro presente – e del prossimo futuro – è quella di ragionare sulla relazione uomo-tecnologia, valutando quali delle dinamiche che caratterizzano il nostro modo di stare insieme possano essere migliorate – o terribilmente peggiorate, o addirittura cancellate – da quest’ultima. Non si tratta quindi di rinunciare a tutto ciò che il progresso tecnologico ci offre, ma di tirarci indietro quando sembra ci stia togliendo qualcosa di essenziale, soprattutto se si tratta di aspetti del nostro stare al mondo a cui non possiamo rinunciare se vogliamo curarci del nostro benessere. Metterlo al centro degli obiettivi delle nuove tecnologie digitaliè è forse l’unico modo per avere dei dispositivi capaci di ricambiarci emotivamente, contribuendo, a loro modo, alla nostra felicità.
L'articolo Siamo cresciuti incollati al digitale, senza la gioia degli incontri reali. La rivogliamo indietro. proviene da THE VISION.







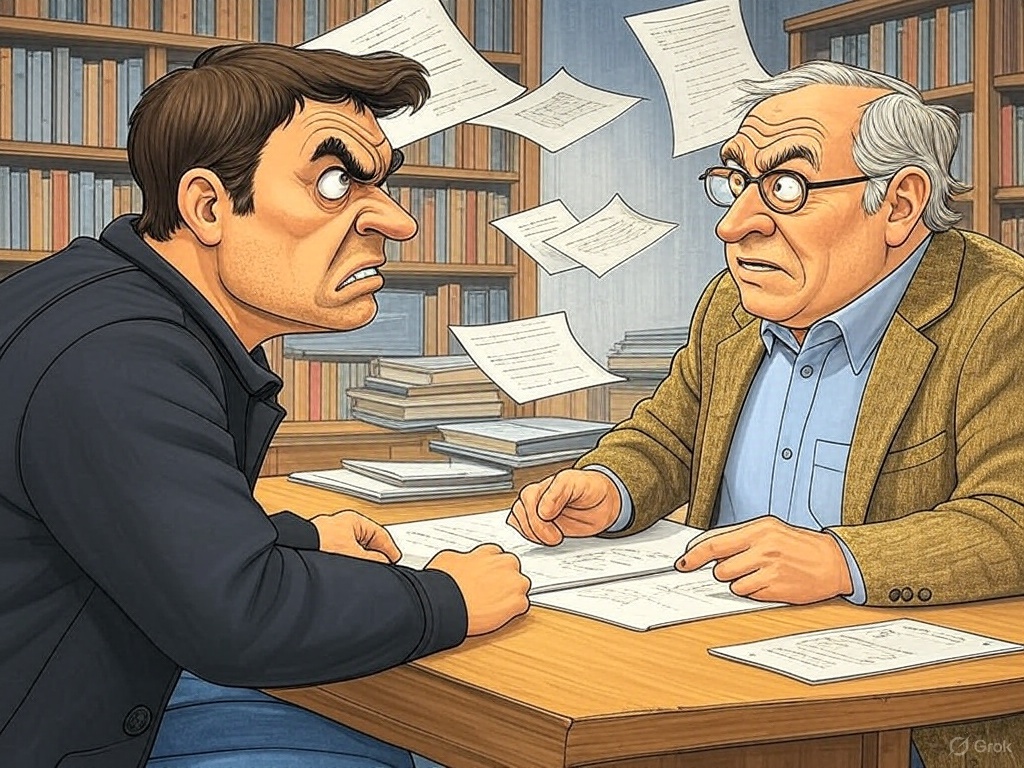


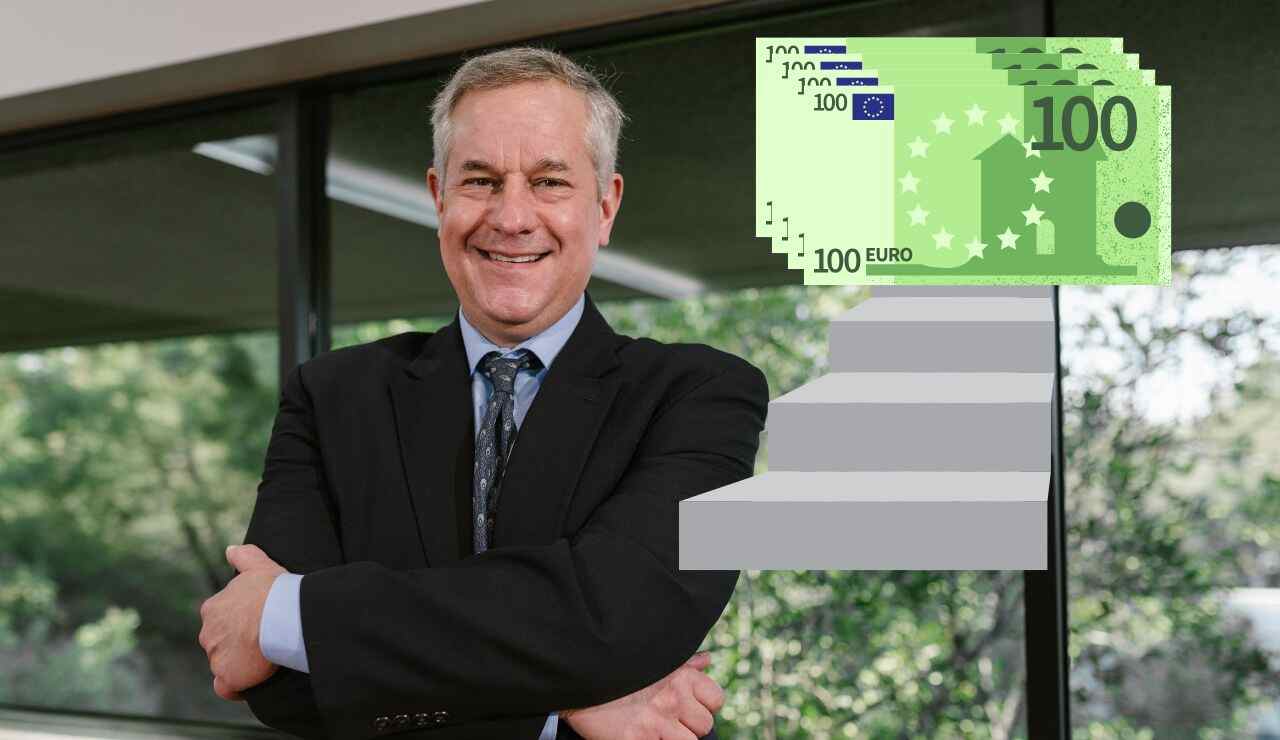
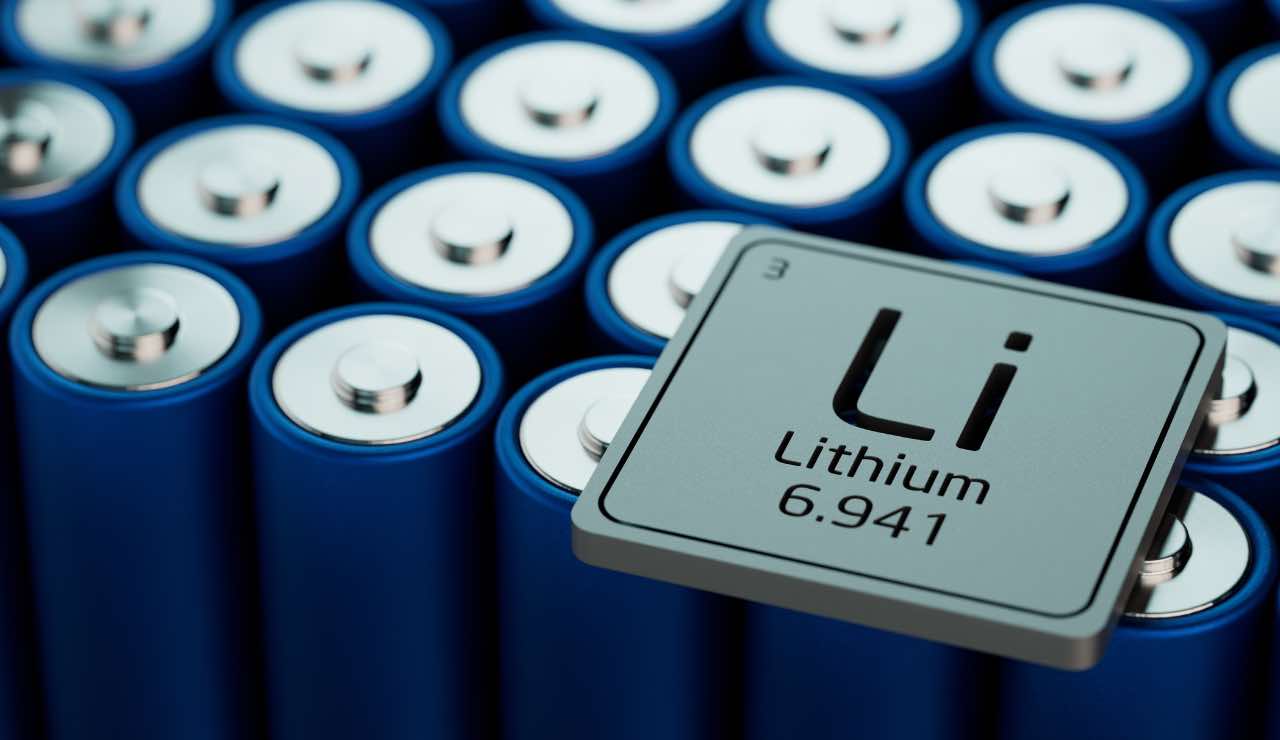







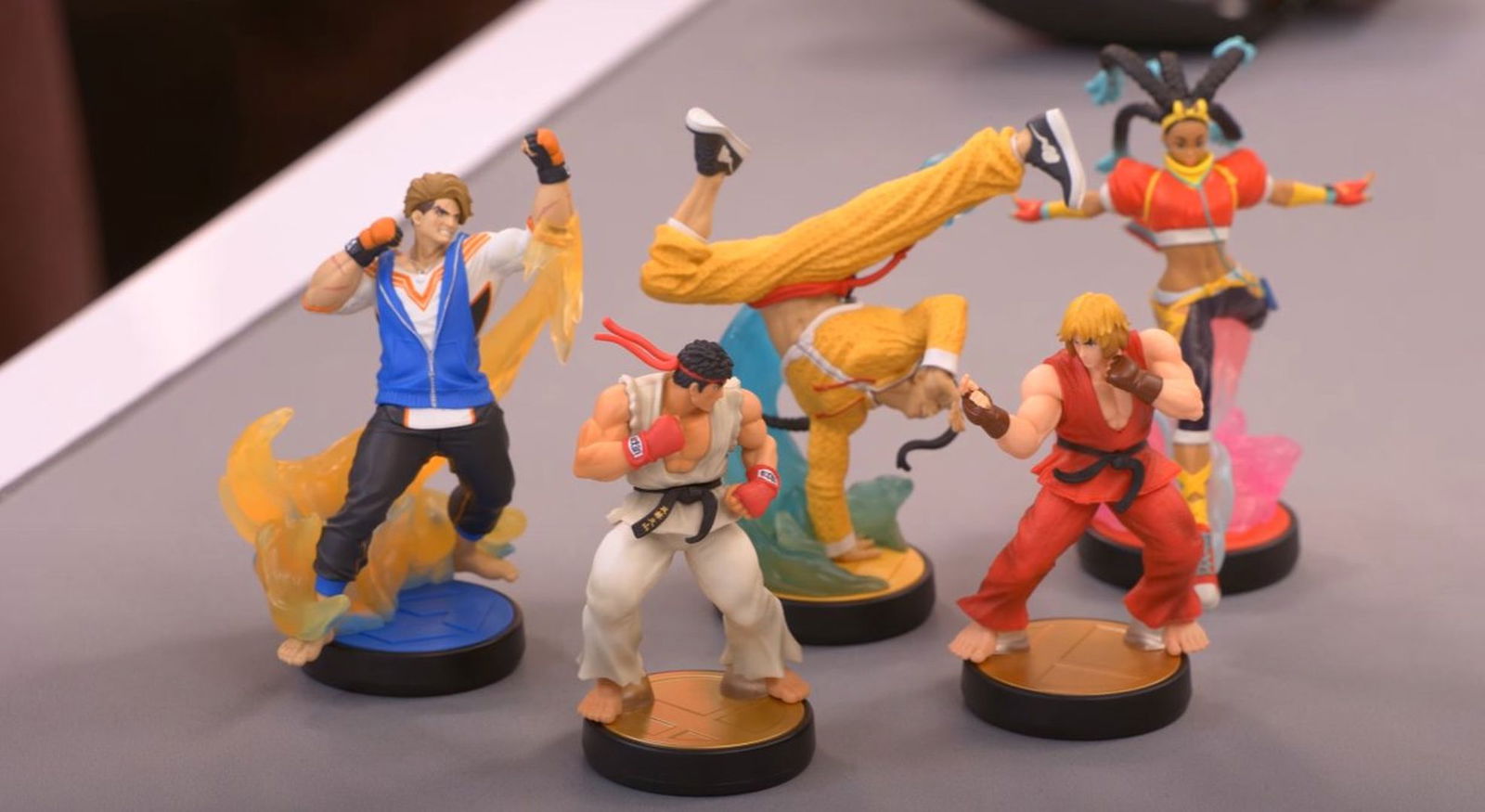

.jpg)