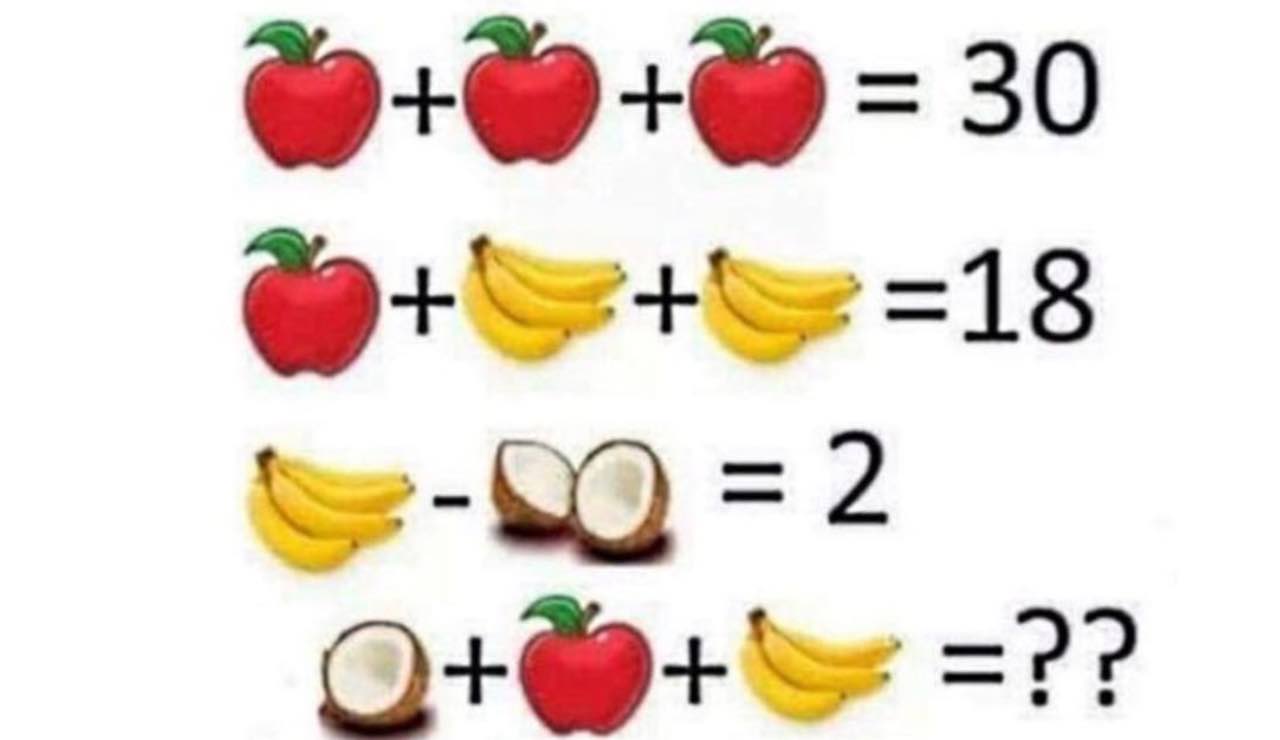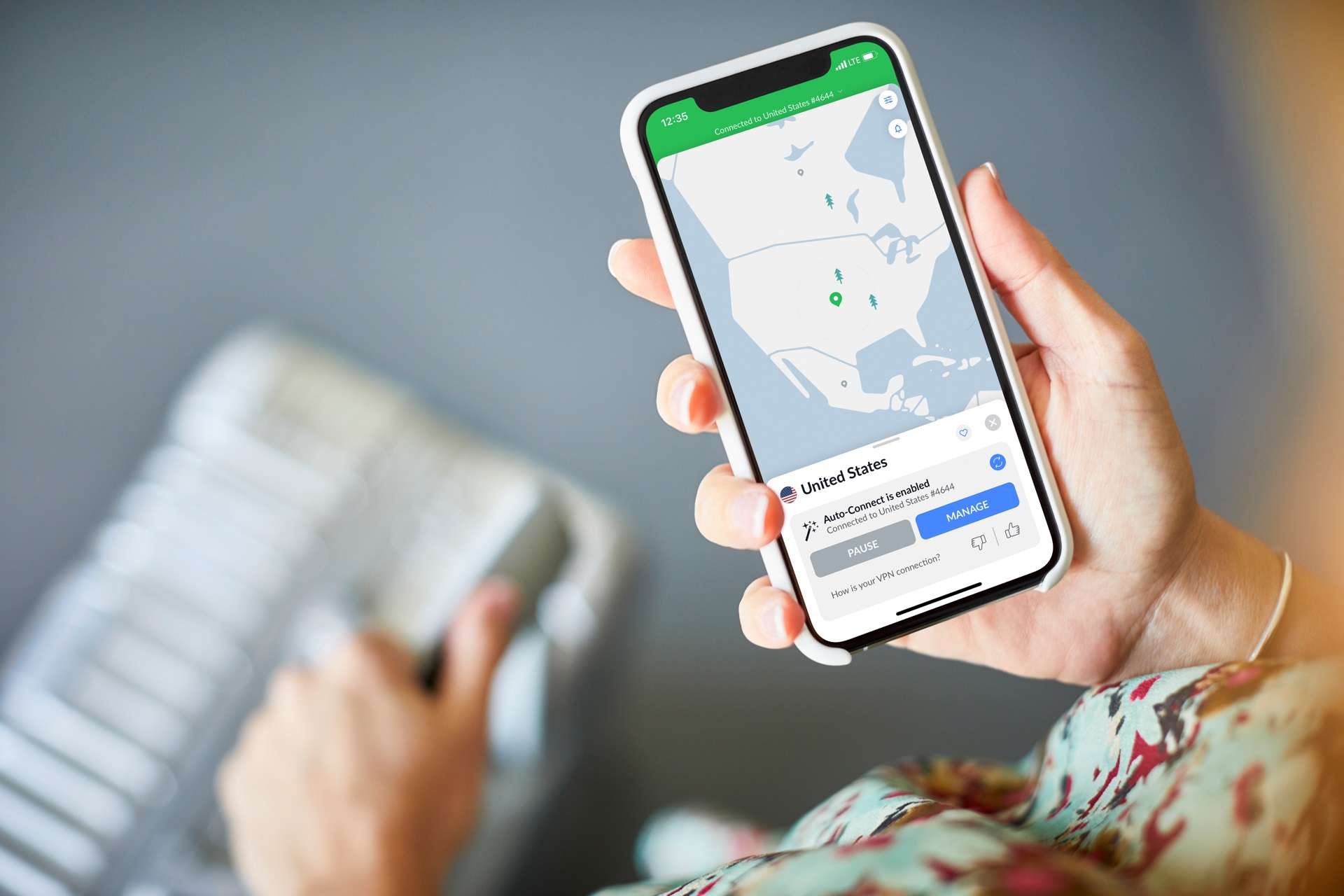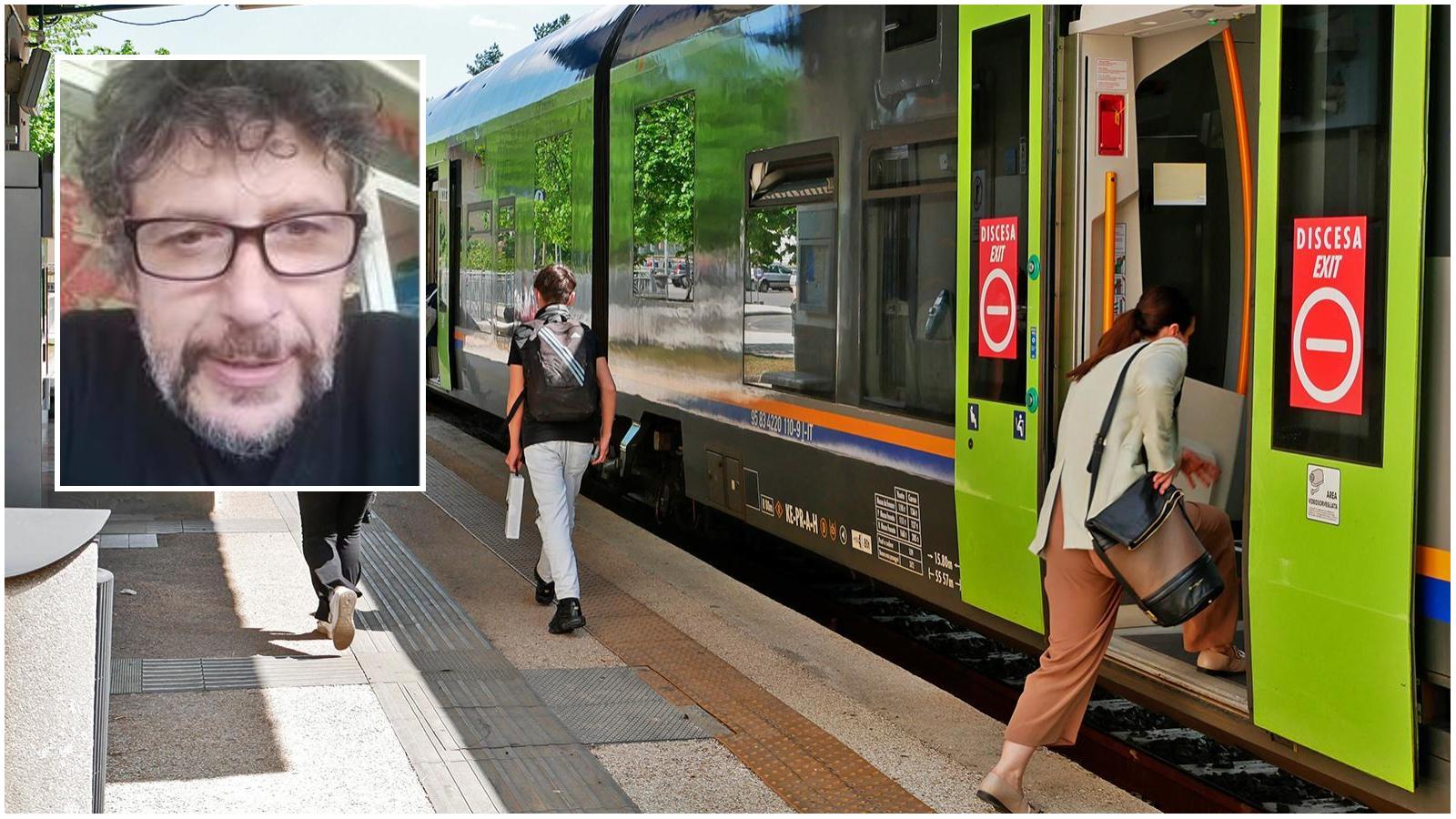PFAS: quei veleni eterni che beviamo ogni giorno (e ancora nessuna legge che li vieti)
Da anni, tra le Province venete di Vicenza, Padova e Verona, si estende una zona rossa invisibile ai più: è un’area pesantemente inquinata da sostanze chimiche perfluoroalchiliche, note come PFAS. È dal 2016 che qui oltre 350.000 persone hanno inconsapevolmente bevuto acqua contaminata, cucinato e irrigato campi con un veleno silenzioso e persistente. Un disastro...

Da anni, tra le Province venete di Vicenza, Padova e Verona, si estende una zona rossa invisibile ai più: è un’area pesantemente inquinata da sostanze chimiche perfluoroalchiliche, note come PFAS. È dal 2016 che qui oltre 350.000 persone hanno inconsapevolmente bevuto acqua contaminata, cucinato e irrigato campi con un veleno silenzioso e persistente.
Un disastro ambientale senza precedenti, silenzioso, che – purtroppo – non si è arrestato ai confini regionali.
Oggi, l’inquinamento da PFAS riguarda oltre 17.000 siti in tutta Europa. Si tratta di sostanze che sono ovunque: padelle antiaderenti, tessuti impermeabili, cosmetici, contenitori alimentari, imballaggi, schiume antincendio, detergenti. Ma il vero allarme è che sono entrate nella catena alimentare, contaminando uova, carne, pesce, latte e perfino il latte materno.
“Inquinanti eterni”: cosa sono davvero i PFAS?
I PFAS (acronimo di sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono composti chimici ultra-resistenti utilizzati in decine di processi industriali per le loro proprietà antiaderenti, idrorepellenti e resistenti alle alte temperature. Il problema? Impiegano oltre 1.000 anni per degradarsi nell’ambiente. Per questo sono chiamati “forever chemicals”, cioè inquinanti eterni.
Come siamo arrivati a questo punto?
Tutto inizia nel 2011, lungo il torrente Poscola, in Veneto. Accanto al corso d’acqua si trova l’ex stabilimento Miteni di Trissino, azienda chimica nata nel 1964, situata sopra una delle falde acquifere più grandi d’Europa. Proprio lì, per anni, i PFAS sono stati sversati nel suolo e nella falda, penetrando progressivamente nell’acqua potabile di 21 comuni veneti.
Le indagini condotte dal NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dei Carabinieri rivelano che la Miteni era consapevole del danno ambientale già nel 2004, quando commissionò uno studio ambientale che evidenziava la contaminazione. Ma la bonifica, costosissima e stimata attorno ai 18 milioni di euro, non partì mai. Così, mentre l’azienda taceva, decine di migliaia di famiglie continuavano a usare acqua contaminata ogni giorno.
Oggi, 15 ex dirigenti della Miteni sono a processo con accuse gravissime: avvelenamento di acque, disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti, reati fallimentari. Intanto lo Stato ha investito oltre 80 milioni di euro per realizzare nuovi acquedotti, ma il danno – ormai – è diffuso: la contaminazione si è spinta fino al mare Adriatico, raggiungendo anche altri Paesi europei e finanche le nevi dell’Antartide.
Un veleno globale, un silenzio normativo
In questo contesto drammatico, una delle domande più inquietanti resta: perché non esiste ancora un divieto totale dei PFAS? In Italia non è stata ancora approvata una legge che vieti l’uso di queste sostanze. Eppure, gli studi scientifici non lasciano dubbi: l’esposizione prolungata ai PFAS è associata a tumori renali, disfunzioni tiroidee, diabete, danni epatici e immunitari, problemi nella gravidanza e riduzione della fertilità.
Il comitato Mamme No PFAS, attivo da anni, denuncia con forza l’inerzia politica. Centinaia di associazioni chiedono un divieto completo entro il 2030. Ma i tempi rischiano di essere troppo lenti rispetto alla portata del problema.
L’Europa accelera (ma l’Italia resta indietro)
A livello europeo, nel Regolamento REACH, la Commissione UE ha avviato nel 2023 una proposta di restrizione totale su oltre 10.000 PFAS, considerata una delle più ampie mai avanzate dall’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche). L’obiettivo è vietare l’immissione sul mercato, l’uso e l’importazione di questi composti, con alcune deroghe temporanee solo per settori dove non esistono alternative.
In parallelo, il Regolamento (UE) 2020/741 sulle acque reflue e la Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità dell’acqua potabile prevedono per la prima volta limiti specifici per i PFAS nell’acqua destinata al consumo umano. Ma la piena applicazione spetta agli Stati membri, e l’Italia è in netto ritardo nell’adozione e nel controllo.
In definitiva? I PFAS sono già dentro di noi. Non è più tempo di studi, inchieste o silenzi. Serve una scelta politica netta e immediata, con una legge nazionale che vieti questi composti tossici, e un investimento strutturale nella bonifica dei territori contaminati. L’ambiente, la salute pubblica e le generazioni future non possono più aspettare.
Non vuoi perdere le nostre notizie?
- Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram
- Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite
Leggi anche:
- Niente più pfas nell’acqua potabile: questo nuovo filtro italiano li elimina in modo semplice ed economico
- Acque minerali contaminate da PFAS e pesticidi: c’è anche la tua preferita tra quelle analizzate nel test svizzero?
- PFAS nelle acque potabili: arriva in Parlamento il decreto che riduce i limiti
- Stop all’uso di Flufenacet in Ue, ma bisogna fare di più: vietare tutti i pesticidi Pfas