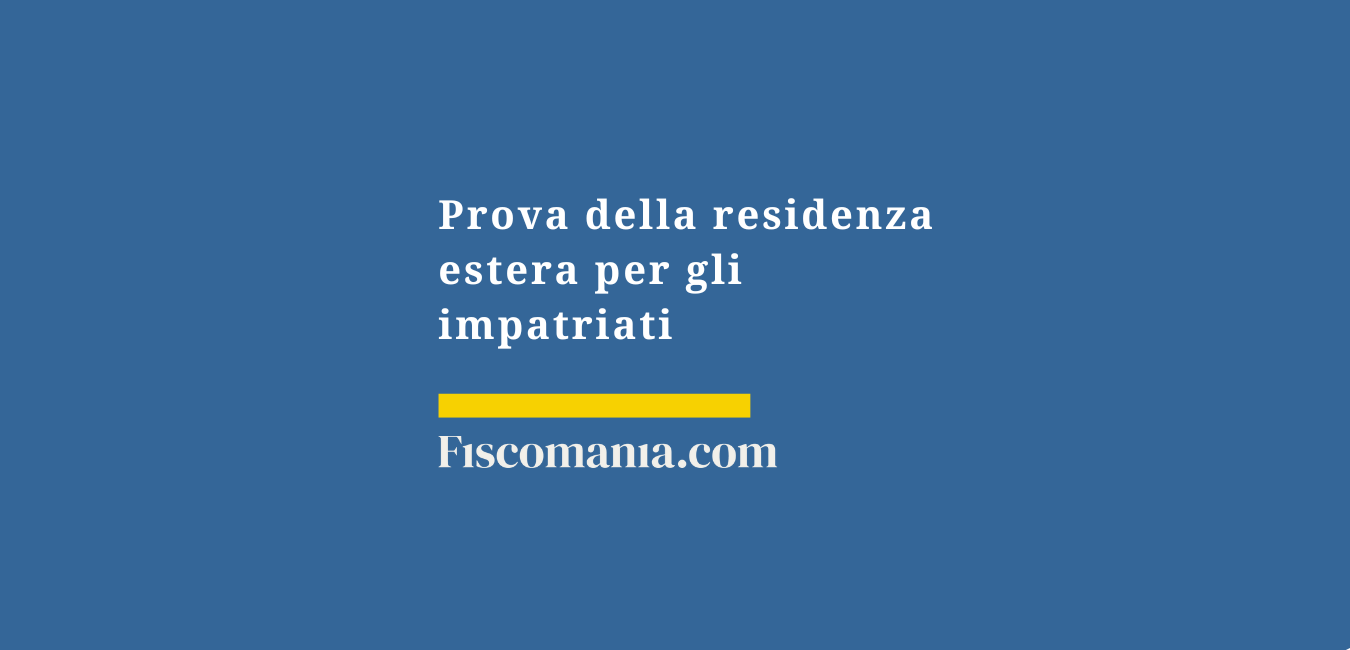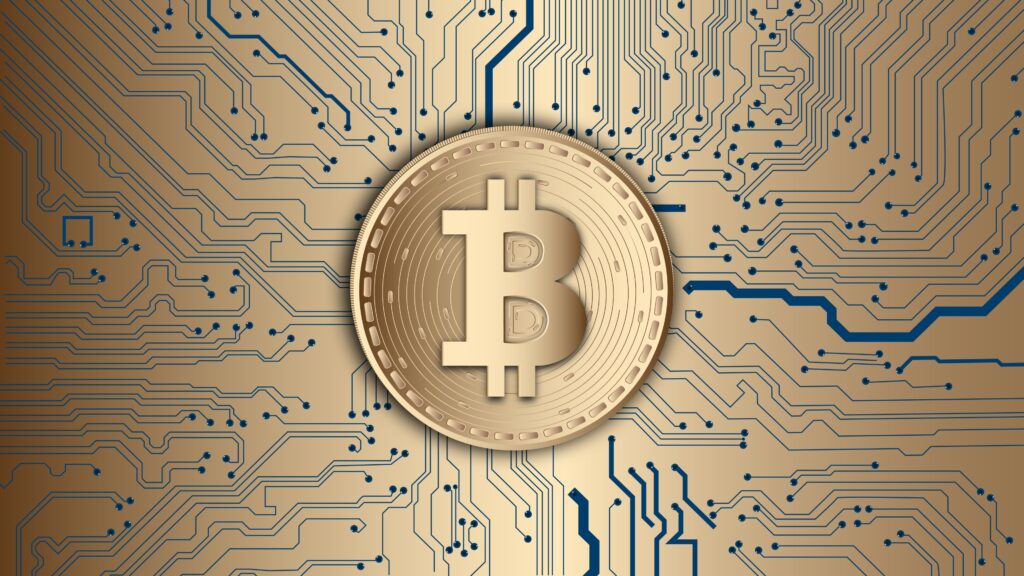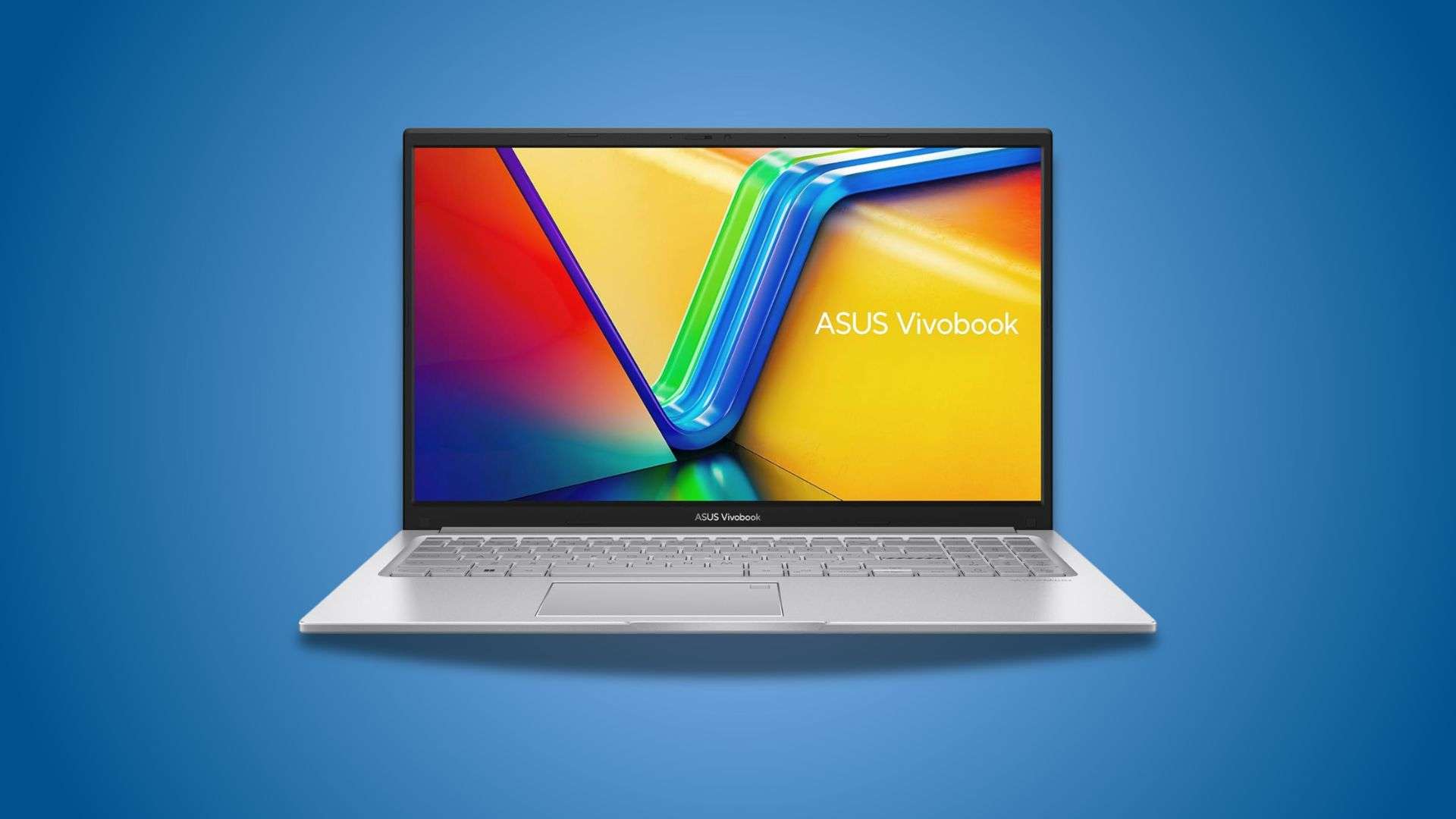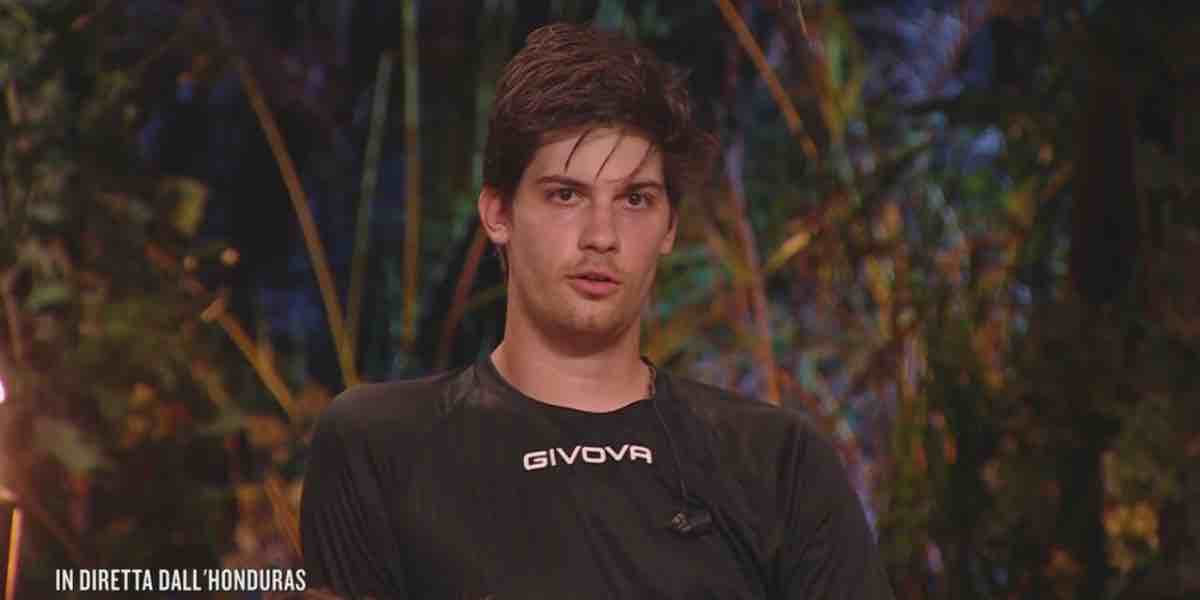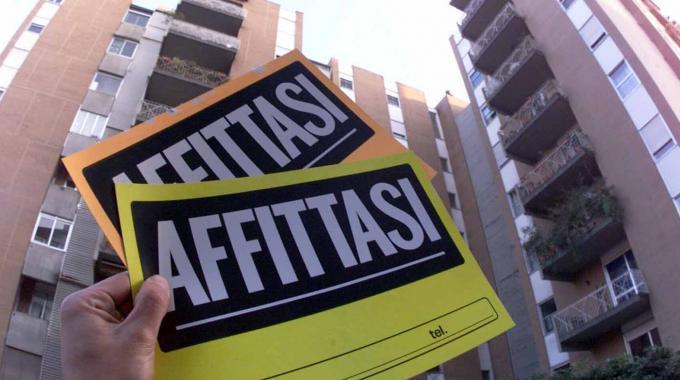Monasteri: così funzionavano le città di Dio nel Medioevo
I monasteri ci insegnano cosa significa mettere in pratica un ideale attraverso l'architettura. Le mura monastiche costituiscono lo scenario della peculiare forma di vita del monaco. Qui le ore del giorno sono scandite meticolosamente da una routine di preghiera, lavoro, contemplazione e riposo che impedisce l'insorgere della temuta acedia, quella svogliatezza che può invadere chi si isola dalle fatiche del mondo. Non è un caso che siano stati i monaci, verso la fine del XIII secolo, a inventare i primi orologi meccanici. Prima di questa creazione rivoluzionaria, gli orologi solari e lunari e altri ingegnosi dispositivi, come i ceri o le clepsidre (meccanismi che funzionavano con l'acqua), servivano a stabilire, attraverso una rigida disciplina oraria, la giornata delle comunità monastiche.In qualsiasi monastero medievale ben conservato è possibile rintracciare questa organizzazione della vita monastica grazie ai diversi spazi che compongono il suo complesso. La chiesa era il luogo di culto della comunità, dove i monaci e i laici (i fratelli di rango inferiore, solitamente impegnati nei lavori più duri), seduti in cori separati, officiavano la liturgia e cantavano le loro preghiere. Su un lato del tempio, la sacrestia era la sala in cui erano conservati gli abiti e gli oggetti destinati al culto, come un camerino situato accanto al palco liturgico. Di seguito si trovava la sala capitolare, dove, dopo la lettura di un capitolo della regola che governava l'ordine (da cui il nome), venivano discussi gli affari economici e di governo del monastero e delle sue spesso vaste proprietà.Stanze quotidianeOltre a questi spazi fondamentali, comuni ad altri templi cristiani come le cattedrali, nei monasteri c'erano sale per il lavoro manuale e uno studio o scriptorium dove venivano scritti, copiati e miniati i libri. Poiché non è possibile scrivere o disegnare con le dita congelate, la sala era dotata di un camino accanto al quale i monaci effettuavano piccole riparazioni o si prendevano cura delle loro calzature. Infine, c'era una lunga serie di stanze di tipo pratico, indispensabili per la routine quotidiana: un ampio dormitorio comune; il refettorio, dove si mangiava in silenzio, rotto solo dalla voce del lettore, salito su un pulpito; la cucina, che di solito era l'unico spazio riscaldato oltre allo scriptorium, e la dispensa, dove venivano conservati gli alimenti.Tutti questi spazi erano distribuiti intorno a un chiostro, con gallerie aperte su un giardino e in uno degli angoli era solitamente collocato un armadio per i libri, in modo che i monaci potessero prenderli e leggerli seduti nella galleria meglio orientata, quella adiacente alla chiesa, mentre prendevano il sole. Inutile dire che il chiostro è un simbolo della vita contemplativa.Non era raro che nel chiostro ci fosse un pozzo o una fontana, che faceva parte di un complesso sistema di approvvigionamento e smaltimento: quando si sceglieva l'ubicazione di un monastero si cercava sempre la presenza di corsi d'acqua naturali. Correttamente incanalata, l'acqua riempiva il lavabo - la fontana del chiostro - dove i monaci si lavavano e si rifornivano di acqua per i pasti, riempiva i bacini degli allevamenti ittici, azionava fucine e mulini e puliva le latrine.Questo modello ideale ci viene solitamente rappresentato sotto forma di monastero cistercense, poiché quell'ordine monastico, nato in risposta agli eccessi materiali e allo sfarzo a cui era giunto l'ordine di Cluny, è forse quello che ci ha lasciato esempi più completi e meglio conservati. Ma ciascuno degli ordini monastici (cluniacense, cistercense, premonstratense, certosino, geronimo...), strutturato secondo la propria regola specifica, aveva le sue peculiarità e il suo modo particolare di organizzarsi, che si riflette nella forma e nella distribuzione dei monasteri. Si tratta di qualcosa che non riguarda gli stili artistici, ma la concezione dei diversi spazi e la loro posizione nell'insieme.Così, i geronimiti possedevano biblioteche particolarmente ampie e ricche e i loro cori erano disposti in spazi alti situati ai piedi delle loro chiese, mentre i certosini portarono all'estremo la solitudine dei loro membri costruendo per loro alloggi individuali, dotati di stanze e di un orto e disposti intorno a un enorme chiostro nel cui giardino venivano sepolti.Per i cistercensi, gli spazi di lavoro erano molto importanti, e i premonstratensi si avvicinavano molto a questo modello, ma con una differenza fondamentale: a differenza dell'ordine cistercense, le loro chiese erano aperte ai fedeli estranei alla comunità.Sebbene i monasteri femminili potessero essere molto potenti e sostenuti dalla Corona, le suore subivano importanti limitazioni. L'impossibilità di officiare la liturgia le costringeva a stare separate dalla zona degli altari, dove erano gli uomini a celebrare la messa e a portare loro la comunione attraverso delle grate e delle finestre chiamate comulgatori. In cambio, riuscirono a dotare i loro spazi

I monasteri ci insegnano cosa significa mettere in pratica un ideale attraverso l'architettura. Le mura monastiche costituiscono lo scenario della peculiare forma di vita del monaco. Qui le ore del giorno sono scandite meticolosamente da una routine di preghiera, lavoro, contemplazione e riposo che impedisce l'insorgere della temuta acedia, quella svogliatezza che può invadere chi si isola dalle fatiche del mondo. Non è un caso che siano stati i monaci, verso la fine del XIII secolo, a inventare i primi orologi meccanici. Prima di questa creazione rivoluzionaria, gli orologi solari e lunari e altri ingegnosi dispositivi, come i ceri o le clepsidre (meccanismi che funzionavano con l'acqua), servivano a stabilire, attraverso una rigida disciplina oraria, la giornata delle comunità monastiche.
In qualsiasi monastero medievale ben conservato è possibile rintracciare questa organizzazione della vita monastica grazie ai diversi spazi che compongono il suo complesso. La chiesa era il luogo di culto della comunità, dove i monaci e i laici (i fratelli di rango inferiore, solitamente impegnati nei lavori più duri), seduti in cori separati, officiavano la liturgia e cantavano le loro preghiere. Su un lato del tempio, la sacrestia era la sala in cui erano conservati gli abiti e gli oggetti destinati al culto, come un camerino situato accanto al palco liturgico. Di seguito si trovava la sala capitolare, dove, dopo la lettura di un capitolo della regola che governava l'ordine (da cui il nome), venivano discussi gli affari economici e di governo del monastero e delle sue spesso vaste proprietà.
Stanze quotidiane
Oltre a questi spazi fondamentali, comuni ad altri templi cristiani come le cattedrali, nei monasteri c'erano sale per il lavoro manuale e uno studio o scriptorium dove venivano scritti, copiati e miniati i libri. Poiché non è possibile scrivere o disegnare con le dita congelate, la sala era dotata di un camino accanto al quale i monaci effettuavano piccole riparazioni o si prendevano cura delle loro calzature. Infine, c'era una lunga serie di stanze di tipo pratico, indispensabili per la routine quotidiana: un ampio dormitorio comune; il refettorio, dove si mangiava in silenzio, rotto solo dalla voce del lettore, salito su un pulpito; la cucina, che di solito era l'unico spazio riscaldato oltre allo scriptorium, e la dispensa, dove venivano conservati gli alimenti.
Tutti questi spazi erano distribuiti intorno a un chiostro, con gallerie aperte su un giardino e in uno degli angoli era solitamente collocato un armadio per i libri, in modo che i monaci potessero prenderli e leggerli seduti nella galleria meglio orientata, quella adiacente alla chiesa, mentre prendevano il sole. Inutile dire che il chiostro è un simbolo della vita contemplativa.
Non era raro che nel chiostro ci fosse un pozzo o una fontana, che faceva parte di un complesso sistema di approvvigionamento e smaltimento: quando si sceglieva l'ubicazione di un monastero si cercava sempre la presenza di corsi d'acqua naturali. Correttamente incanalata, l'acqua riempiva il lavabo - la fontana del chiostro - dove i monaci si lavavano e si rifornivano di acqua per i pasti, riempiva i bacini degli allevamenti ittici, azionava fucine e mulini e puliva le latrine.
Questo modello ideale ci viene solitamente rappresentato sotto forma di monastero cistercense, poiché quell'ordine monastico, nato in risposta agli eccessi materiali e allo sfarzo a cui era giunto l'ordine di Cluny, è forse quello che ci ha lasciato esempi più completi e meglio conservati. Ma ciascuno degli ordini monastici (cluniacense, cistercense, premonstratense, certosino, geronimo...), strutturato secondo la propria regola specifica, aveva le sue peculiarità e il suo modo particolare di organizzarsi, che si riflette nella forma e nella distribuzione dei monasteri. Si tratta di qualcosa che non riguarda gli stili artistici, ma la concezione dei diversi spazi e la loro posizione nell'insieme.
Così, i geronimiti possedevano biblioteche particolarmente ampie e ricche e i loro cori erano disposti in spazi alti situati ai piedi delle loro chiese, mentre i certosini portarono all'estremo la solitudine dei loro membri costruendo per loro alloggi individuali, dotati di stanze e di un orto e disposti intorno a un enorme chiostro nel cui giardino venivano sepolti.
Per i cistercensi, gli spazi di lavoro erano molto importanti, e i premonstratensi si avvicinavano molto a questo modello, ma con una differenza fondamentale: a differenza dell'ordine cistercense, le loro chiese erano aperte ai fedeli estranei alla comunità.
Sebbene i monasteri femminili potessero essere molto potenti e sostenuti dalla Corona, le suore subivano importanti limitazioni. L'impossibilità di officiare la liturgia le costringeva a stare separate dalla zona degli altari, dove erano gli uomini a celebrare la messa e a portare loro la comunione attraverso delle grate e delle finestre chiamate comulgatori. In cambio, riuscirono a dotare i loro spazi di riunione di una monumentalità sconosciuta nei cenobi maschili, in particolare le sale capitolare, come nelle Huelgas, Cañas o San Andrés del Arroyo.
La cella di un monaco certosino
L'ordine dei certos, fondato da Bruno di Colonia nel 1084, prende il nome dal primo monastero fondato nella Sierra de la Chartreuse, nelle Alpi francesi. Il loro stile di vita monastico era originale. I loro conventi erano composti da celle individuali isolate l'una dall'altra, in cui i monaci svolgevano in solitudine tutte le attività quotidiane: pregare, studiare, mangiare e dormire. Si riunivano solo per le funzioni in chiesa - al mattino, al pomeriggio e alla sera - e per mangiare la domenica e nelle grandi festività; inoltre, una volta al mese facevano una passeggiata insieme. Indossavano un abito bianco e un cappuccio o scapolare (un pezzo di stoffa che ricade sul petto e sulla schiena), anch'esso bianco, al quale è attaccato il cappuccio.
L'illustrazione mostra la ricostruzione di una cella monastica del monastero certosino di Mount Grace, nel nord dell'Inghilterra. La stanza, relativamente ampia, contiene un tavolo da studio, un altro da pranzo, un letto e un inginocchiatoio su cui il monaco sta pregando. Un altro monaco gli porta un pasto frugale (senza carne, dato che l'ordine praticava il vegetarianismo) che gli lascia in una piccola apertura. In basso, ricostruzione della certosa di Mount Grace nel XV secolo, prima che fosse sciolta nel secolo successivo. Oggi ne rimangono solo le rovine.
Questo articolo appartiene al numero 194 della rivista Storica National Geographic.