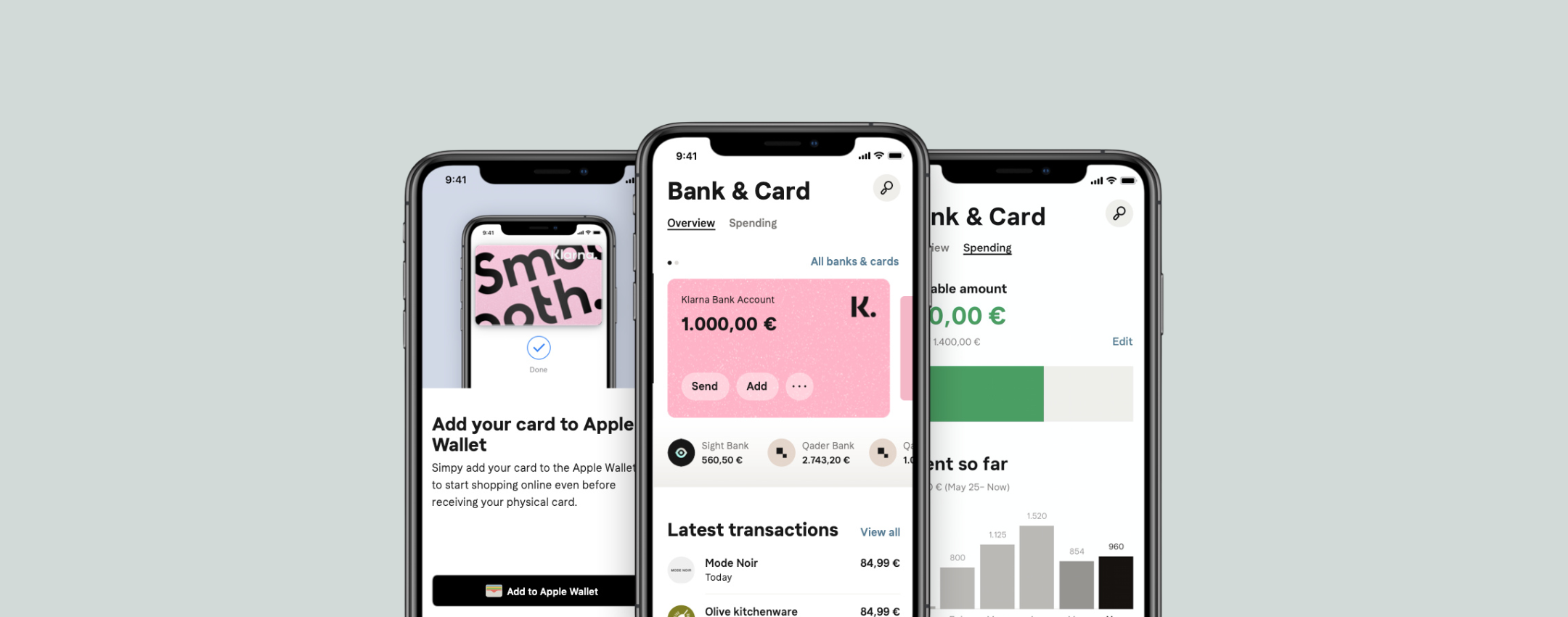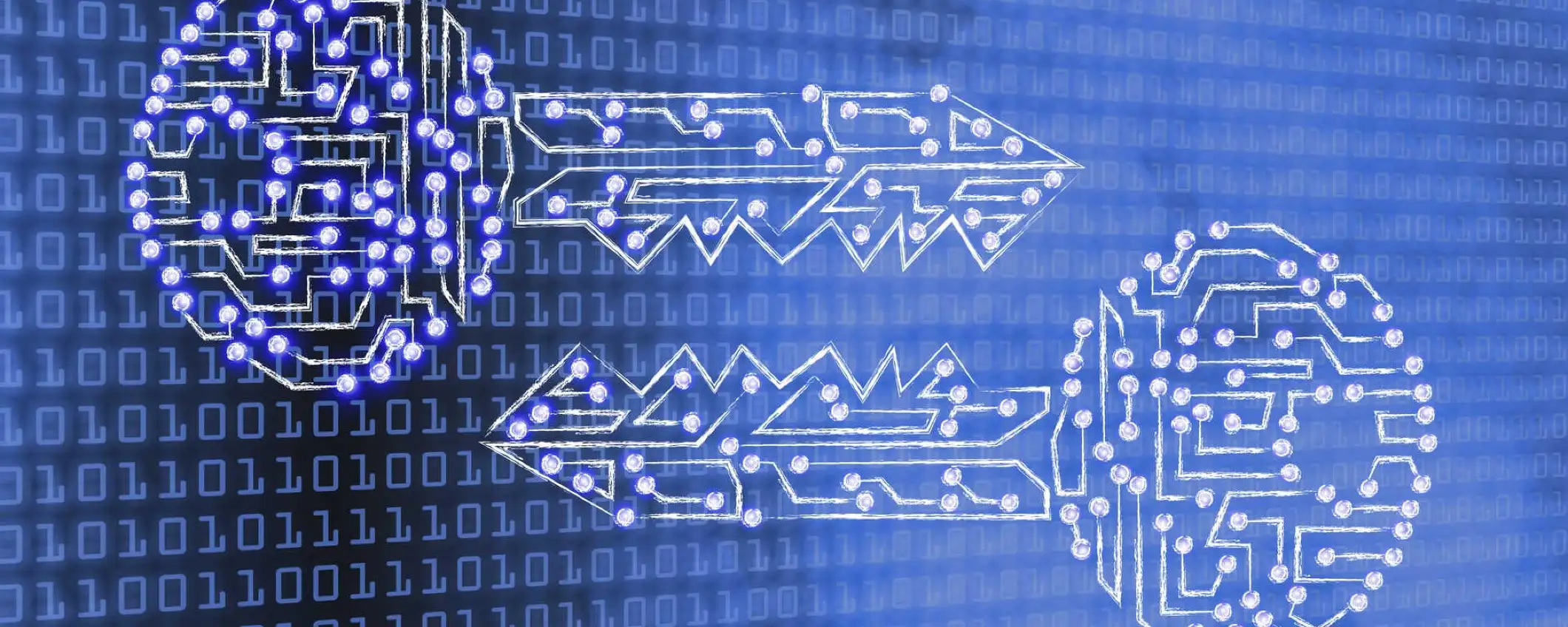Licenziato per una sigaretta (ma i colleghi no): la Cassazione spiega
La Cassazione ribadisce che la tolleranza aziendale verso comportamenti vietati non li rende leciti né crea un diritto acquisito a violare le regole. Il caso del divieto di fumo

Da decenni la legge vieta espressamente di fumare in ufficio. Un’imposizione prevista per ragioni di salute, che si coordina con gli obblighi dell’azienda di cui all’art. 2087 del Codice Civile. E, se per alcuni il fumo è un più che apprezzato rimedio anti-stress, è però altrettanto vero che l’abitudine di accendersi una sigaretta si scontra con il dettato dell’art. 51 della legge 3/2003.
Questa premessa è doverosa se pensiamo alle ultime novità che arrivano dalla giurisprudenza, secondo cui il licenziamento è legittimo se a suo fondamento c’è il fumo in area vietata, e anche se – in tale area – non c’è un cartello che segnala il divieto. Al contempo la massima sanzione disciplinare è giustificata, pur se emessa in un ambiente di lavoro in cui si era creata una sorta di prassi o consuetudine che ammetteva l’uso della sigaretta. Quasi una “anarchica” tolleranza da parte del datore di lavoro.
Su questi temi di estremo interesse è la sentenza n. 7826 del 24 marzo scorso, con cui la Corte di Cassazione ha spiegato – in sostanza – che un’abitudine consolidata non cancella il dato normativo. E chi vìola la legge è tenuto a risponderne anche con la perdita del posto.
La vicenda in sintesi
Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione e deciso dall’appena citato provvedimento, un lavoratore subordinato era stato licenziato per aver fumato in una cd. zona air-side, ossia inclusa in un’area aeroportuale, in cui – pur valendo (almeno sulla carta) regole di sicurezza specifiche – i dipendenti nel tempo erano sempre stati soliti accendersi sigarette per fumare, nei momenti di pausa e di brevi chiacchiere con i colleghi.
Il punto è che il divieto di fumo, pur disapplicato, era noto a tutto il personale: come detto in apertura, la prassi era quella dell’elasticità del comportamento, che perdonava il fumatore “bypassando” il divieto previsto dal legislatore.
Ma la prassi non dura per sempre o, forse, questo avrà pensato il dipendente che si è visto infliggere la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, quasi come la goccia che fa traboccare il vaso. Probabilmente sentendosi capro espiatorio in un ambiente di fumatori, l’uomo ha contestato in tribunale la correttezza del licenziamento disciplinare.
Come si legge nell’ordinanza della Cassazione, la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello della società datrice, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa e condannato la stessa società alla reintegra e al risarcimento del danno. La doccia fredda è però arrivata in Cassazione.
La consuetudine non deroga o cancella la legge
Presso i giudici di piazza Cavour, con l’ordinanza n. 7826 di pochi giorni fa, è stato ricordato che la condivisa (e cattiva) abitudine non cancella l’antigiuridicità – ossia l’illegalità – della condotta vietata dalla legge. La società ha avuto quindi ragione a sbarazzarsi del dipendente amante del tabacco. Anzi, la Cassazione spiega che sia il tribunale che la Corte d’Appello avevano sbagliato a dare ragione al lavoratore, usando queste parole:
Nel caso di specie, la Corte di merito, considerata pacifica l’esistenza del divieto di fumo in quella zona e la sua consapevolezza da parte del lavoratore, ha errato nell’attribuire alla tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni l’effetto di escludere l’antigiuridicità della condotta del dipendente, senza indagare su presenza di elementi ulteriori, atti a ingenerare nel lavoratore l’incolpevole convinzione di liceità della condotta e senza verificare se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo sì che nessun rimprovero poteva essergli mosso oppure avesse unicamente profittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento.
In sostanza, nessuna importanza ha la tolleranza aziendale ai fini dell’esclusione della responsabilità del dipendente che fuma, nonostante un divieto ben noto e conosciuto. O meglio, la presenza di un’eventuale buona fede del lavoratore non era stata indagata dai giudici di merito. Solo la buona fede, infatti, potrebbe escludere la colpa o negligenza del lavoratore e non c’è alcun permesso di fumare “creato” dalla consuetudine, pur radicata da anni e accettata dai superiori.
Non solo. Neanche l’assenza di un richiamo al divieto di fumo, all’interno del regolamento aziendale, può tradursi in un diritto a derogare il divieto di cui all’art. 51 della legge n. 3 del 2003: è vietato fumare in ufficio, in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, chiusi o aperti al pubblico.
Al contempo, il datore di lavoro deve far rispettare il divieto di fumo, applicando – anche – provvedimenti disciplinari. Semmai, lo stesso datore potrà valutare di creare locali riservati ai fumatori, attrezzati, dotati di impianti di ventilazione adeguati e – quindi – aventi i requisiti tecnici di cui al Dpcm del 23 dicembre 2003 attuativo della legge n. 3.
Quando è l’errore è scusabile
La sentenza della Cassazione ci ricorda anche che l’errore del dipendente, che si accende la sigaretta credendo sia possibile, è scusabile e incolpevole se causato da elementi esterni oggettivi, come ad es. una comunicazione aziendale scritta e fuorviante o una segnaletica contraddittoria. Sarà il giudice a fare chiarezza sulla presenza o meno di questi elementi.
Non solo. La buona fede “salverà” il dipendente dal licenziamento solo se quest’ultimo dimostrerà di aver fatto tutto il possibile per rispettare la legge (consultando il regolamento, chiedendo chiarimenti ecc.). In linea generale, nei casi di dubbio, prevale la responsabilità del lavoratore: essendo facile informarsi sulla regola, l’errore non è scusabile.
Come si legge nel testo della decisione della Cassazione:
l’esclusione di responsabilità dell’autore della violazione in tanto è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza.
In estrema sintesi, la buona fede esclude la responsabilità disciplinare solo se l’errore era inevitabile per un lavoratore diligente.
Che cosa cambia
La Cassazione ha stabilito che l’assenza di un cartello di divieto di fumo nel punto esatto dell’infrazione non esime dalla responsabilità, se il divieto era conosciuto ai dipendenti e riguardava l’intera area. Il divieto di fumo è – quindi – valido anche senza cartello locale, se era stato comunicato tramite policy aziendali, circolari interne, formazione o segnaletica generale.
Attenzione però, non serve segnalare ogni metro quadrato, perché basta che il lavoratore fosse consapevole che all’intera zona (es. magazzini, aree produttive, “zona air-side” ecc.) si applicava il divieto. Il dipendente è responsabile – e rischia il licenziamento per giusta causa – se fuma in un’area vietata di cui era a conoscenza, anche senza cartello nel punto specifico.