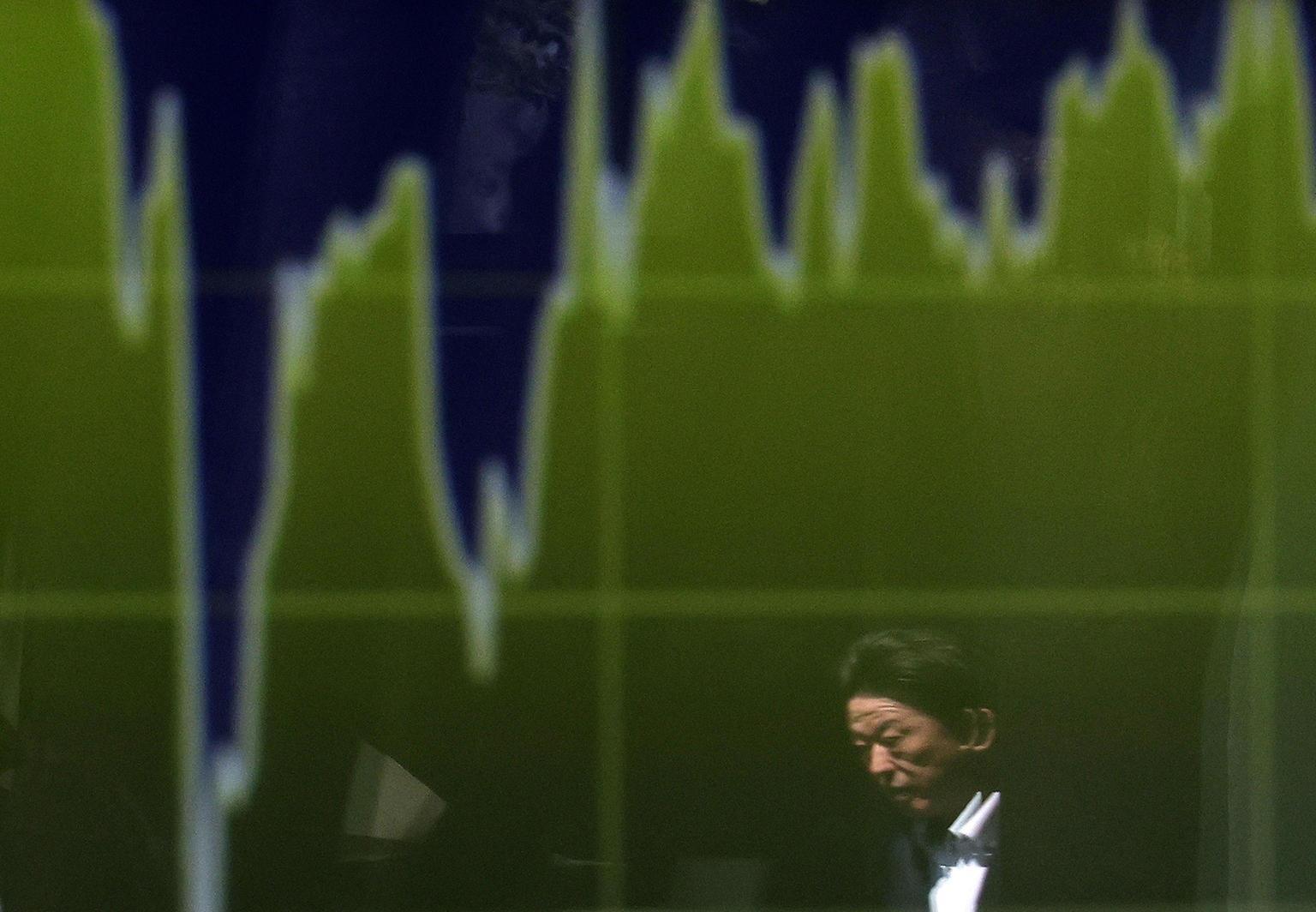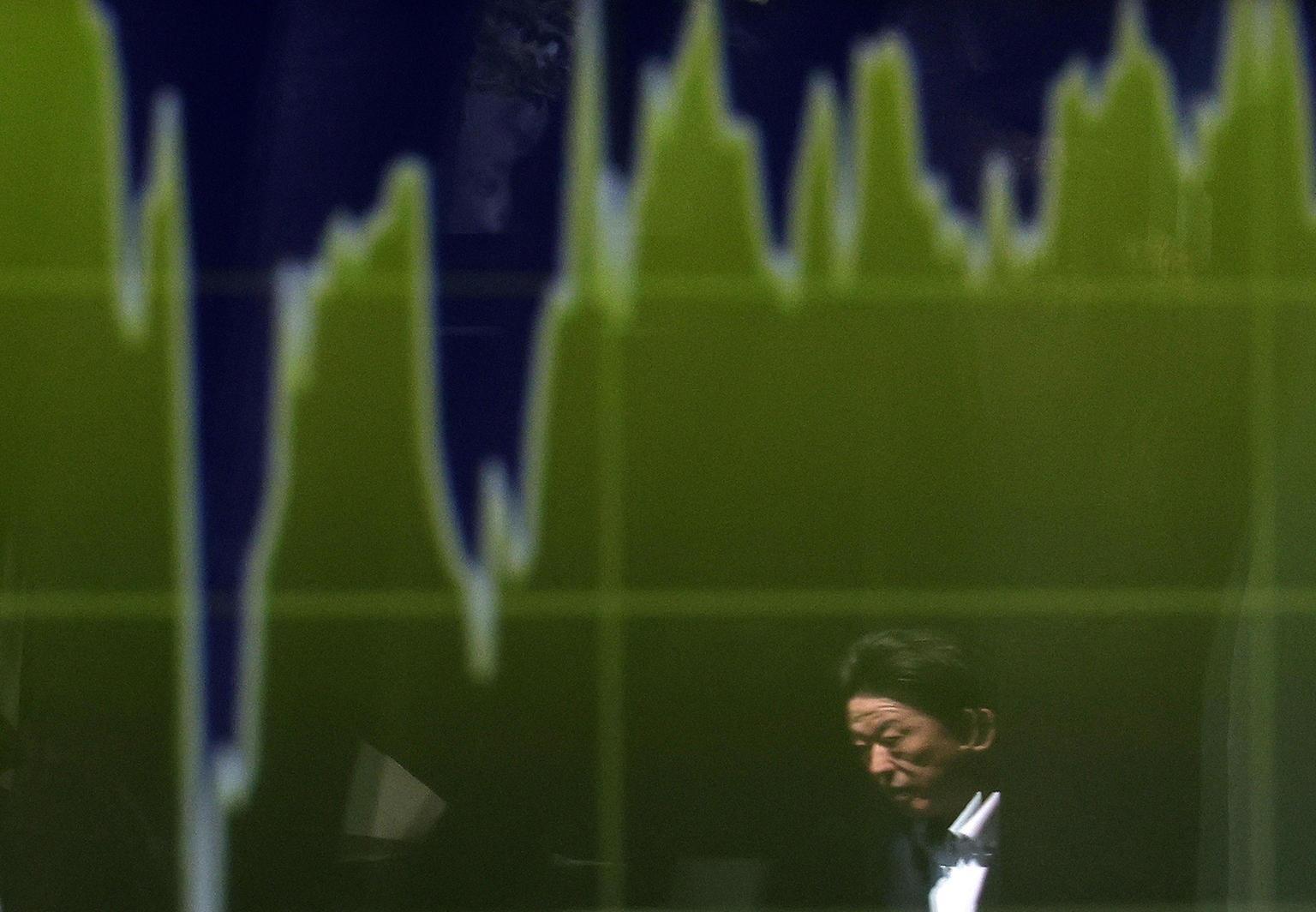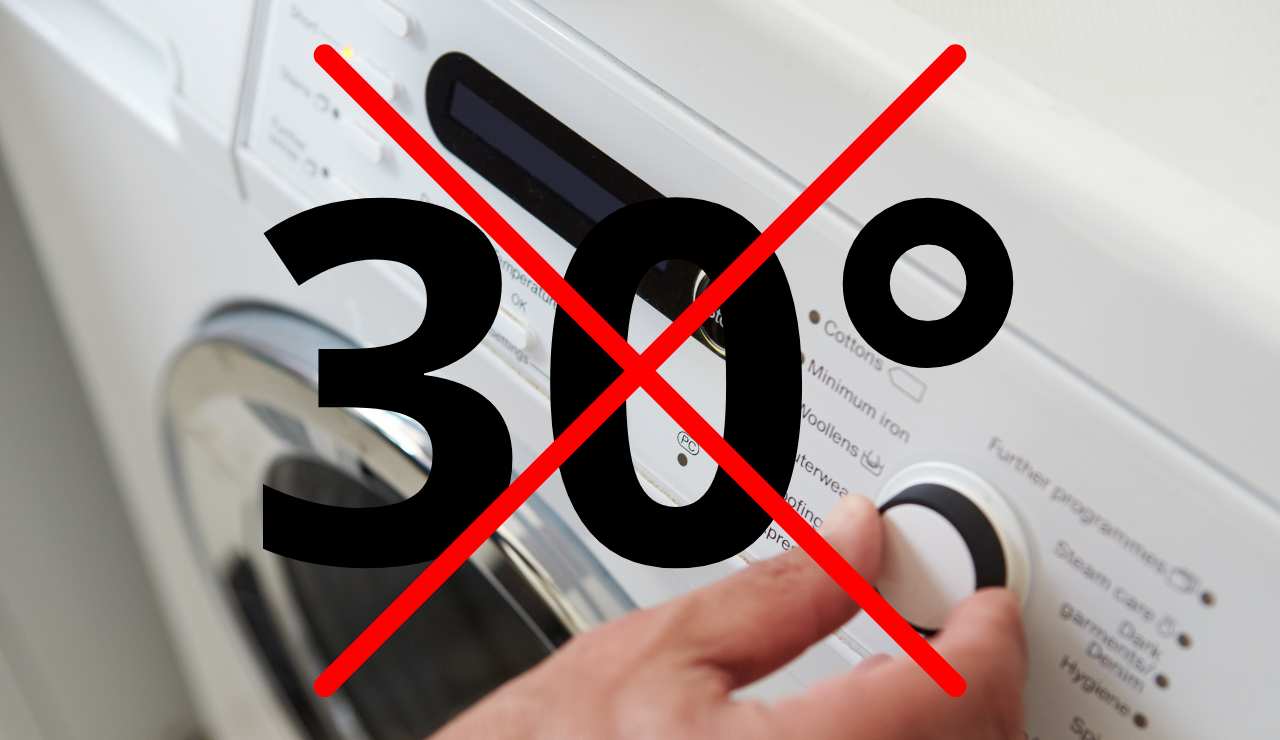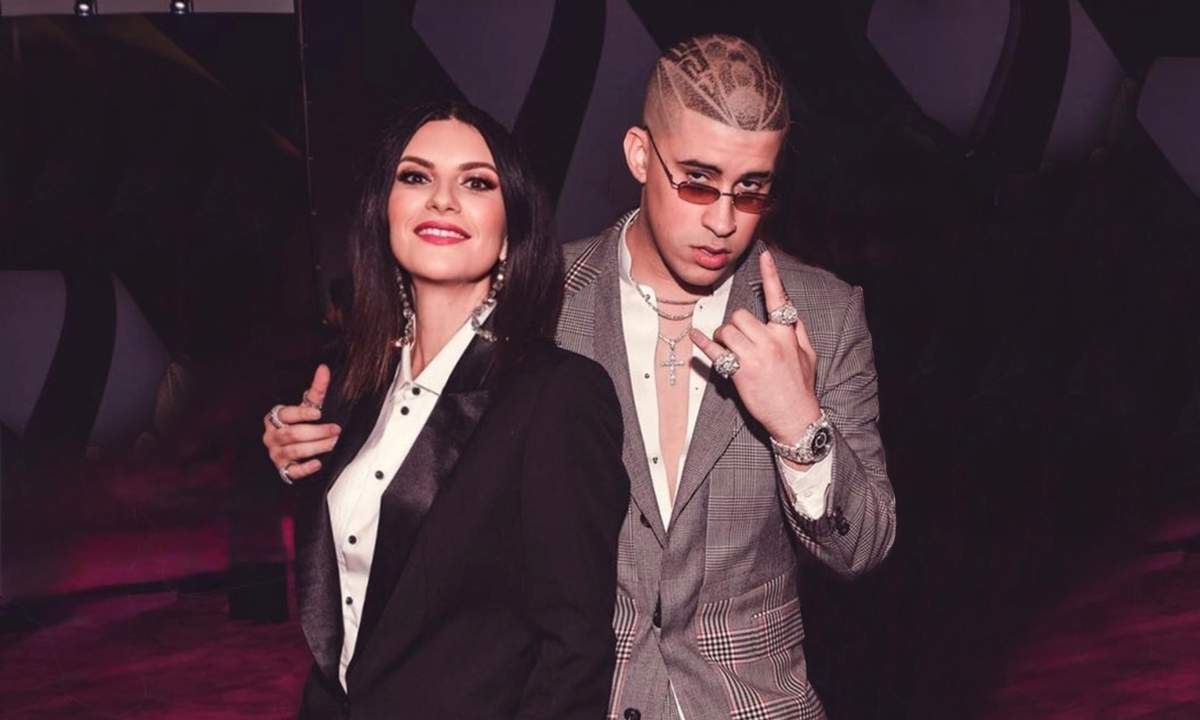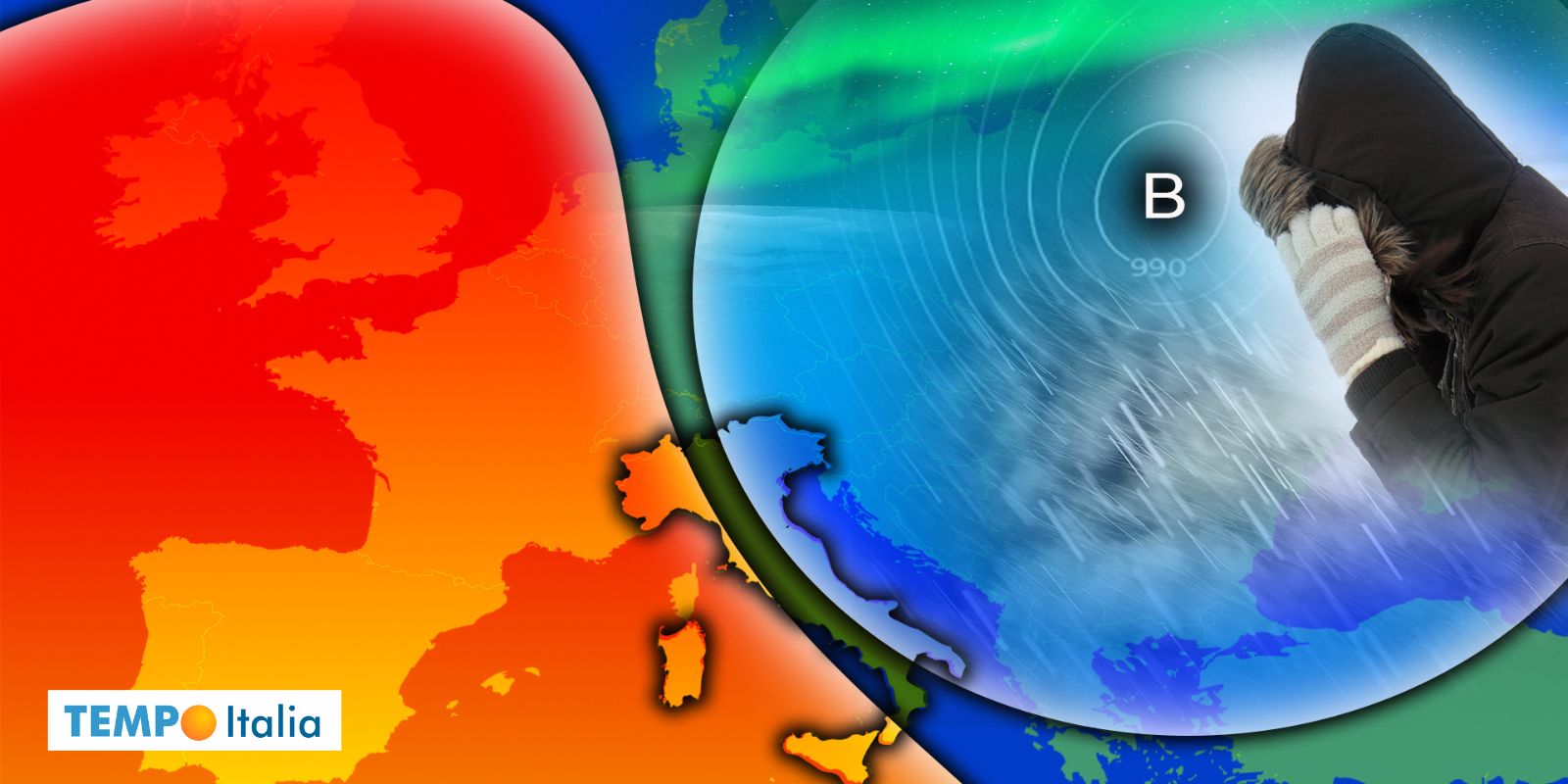L’Alfabeto della Resistenza
Il 25 Aprile è il giorno in cui si ricorda la liberazione d’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista. Il 22 aprile del 1946, con il decreto legislativo luogotenenziale n.185, in materia di ricorrenze festive, il re Umberto II di Savoia stabilì che «a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale». La ricorrenza venne poi istituzionalizzata con la legge n. 260 del 27 maggio 1949.Da quel momento fino a oggi, in tutta Italia e anche all’estero, donne e uomini, giovani e meno giovani, cittadini e membri delle associazioni combattentistiche come l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), insieme ai rappresentanti delle istituzioni a ogni livello, sono impegnati in centinaia di commemorazioni e iniziative che hanno come obiettivo quello di fare “memoria attiva” della Liberazione, della Resistenza e dei suoi “attori”. Ciò significa non limitarsi semplicemente a ricordare i fatti del passato, ma trasformare il ricordo fine a sé stesso in un impegno concreto e quotidiano in difesa dei valori per cui donne e uomini, antifascisti e partigiani di ogni fede e provenienza, lottarono: libertà, democrazia, giustizia sociale, uguaglianza e dignità umana. A tal proposito restano memorabili le parole pronunciate da Maria Cervi, figlia di Antenore, uno dei sette fratelli Cervi, eroi della Resistenza fucilati al poligono di tiro di Reggio Emilia dai fascisti nel dicembre del 1943.«Nessuna conquista è per sempre: c’è sempre qualcuno che è interessato a toglierla. Per cui resistere è, non solo un dovere, ma è anche una necessità dei giovani d’oggi, altrimenti non si va avanti».In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, Storica National Geographic propone un lungo elenco in ordine alfabetico di avvenimenti, personaggi, luoghi, concetti, gruppi e organizzazioni che hanno avuto un peso determinante nel processo di opposizione al nazifascismo chiamato Resistenza che portò alla Liberazione del Paese dalla tirannide. Vista la vastità del tema trattato questo elenco non può dirsi esaustivo: l’obiettivo è quello di dare un inquadramento di carattere generale, un possibile punto di partenza per un utile esercizio di memoria.“A” come “Armistizio”“B” come “Brigate e formazioni partigiane”“C” come “Calamandrei Piero”“D” come “Donne”“E” come “Ernesto Rossi”“F” come “Ferruccio Parri”“G” come “Giovani”“H” come “Hotel”“I” come “IMI (internati militari italiani)”“L” come “Lago Santo”“M” come “Matteotti”“N” come Nidi di Ragno“O” come Ortona“P” come “Piero Gobetti”“Q” come “Quartieri”“R” come “Repubbliche partigiane”“S” come “Stragi”T come “Teatro”“U” come “Università”“V” come Venticinque Aprile 1945Z come “Zamboni Anteo”W come “Walter Audisio”Per saperne di più“A” come “Armistizio”«Il governo italiano riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto l’armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate angloamericane. La richiesta è stata accolta […]». È il testo del proclama con cui, alle 19:45 dell’8 settembre del 1943, il maresciallo Pietro Badoglio annunciò alla radio l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati, siglato segretamente il 3 settembre a Cassibile nei pressi di Siracusa.A seguito della destituzione e dell’arresto del duce, Benito Mussolini, dopo il Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio del 1943, il re Vittorio Emanuele III designò Pietro Badoglio come capo del governo, cui spettava il controllo militare del Paese con pieni poteri. Con l’armistizio di Cassibile, la fine dell’alleanza con la Germania nazista e lo sbarco degli angloamericani che da Salerno risalivano la Penisola, si entrò nella fase più cruenta della Seconda guerra mondiale.Tra l’estate del 1943 e la primavera del 1945 l’Italia piombò in una spirale di violenze inaudite, rastrellamenti e stragi per rappresaglia, fino al 25 aprile del 1945, data che segnò la liberazione del Paese dal nazifascismo.“B” come “Brigate e formazioni partigiane”Si tratta di gruppi armati antifascisti costituitisi su base volontaria a partire dall’8 settembre del 1943 e operanti fino alla fine della guerra, nel maggio del 1945. Dopo la nascita del governo Badoglio, la destituzione di Mussolini e la formazione della repubblica sociale italiana collaborazionista della Germania nazista, s’innescò una vera e propria guerra civile.Nelle file del cosiddetto “partigianato” confluirono gli sbandati delle forze militari regolari che cercano di sfuggire alla cattura da parte dei tedeschi o ai bandi di reclutamento della repubblica sociale italiana. A questi si unirono contadini, operai, intellettuali, ma anche donne che ricoprirono i ruoli di staffette, infermiere, informatrici ma anche combattenti. Aderirono alle formazioni partigiane tutti coloro che avevano coraggio e la capacità d’imbracciare un fucile. Insieme a loro si trovavano e

Il 25 Aprile è il giorno in cui si ricorda la liberazione d’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista. Il 22 aprile del 1946, con il decreto legislativo luogotenenziale n.185, in materia di ricorrenze festive, il re Umberto II di Savoia stabilì che «a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale». La ricorrenza venne poi istituzionalizzata con la legge n. 260 del 27 maggio 1949.
Da quel momento fino a oggi, in tutta Italia e anche all’estero, donne e uomini, giovani e meno giovani, cittadini e membri delle associazioni combattentistiche come l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), insieme ai rappresentanti delle istituzioni a ogni livello, sono impegnati in centinaia di commemorazioni e iniziative che hanno come obiettivo quello di fare “memoria attiva” della Liberazione, della Resistenza e dei suoi “attori”. Ciò significa non limitarsi semplicemente a ricordare i fatti del passato, ma trasformare il ricordo fine a sé stesso in un impegno concreto e quotidiano in difesa dei valori per cui donne e uomini, antifascisti e partigiani di ogni fede e provenienza, lottarono: libertà, democrazia, giustizia sociale, uguaglianza e dignità umana. A tal proposito restano memorabili le parole pronunciate da Maria Cervi, figlia di Antenore, uno dei sette fratelli Cervi, eroi della Resistenza fucilati al poligono di tiro di Reggio Emilia dai fascisti nel dicembre del 1943.
«Nessuna conquista è per sempre: c’è sempre qualcuno che è interessato a toglierla. Per cui resistere è, non solo un dovere, ma è anche una necessità dei giovani d’oggi, altrimenti non si va avanti».

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, Storica National Geographic propone un lungo elenco in ordine alfabetico di avvenimenti, personaggi, luoghi, concetti, gruppi e organizzazioni che hanno avuto un peso determinante nel processo di opposizione al nazifascismo chiamato Resistenza che portò alla Liberazione del Paese dalla tirannide. Vista la vastità del tema trattato questo elenco non può dirsi esaustivo: l’obiettivo è quello di dare un inquadramento di carattere generale, un possibile punto di partenza per un utile esercizio di memoria.
- “A” come “Armistizio”
- “B” come “Brigate e formazioni partigiane”
- “C” come “Calamandrei Piero”
- “D” come “Donne”
- “E” come “Ernesto Rossi”
- “F” come “Ferruccio Parri”
- “G” come “Giovani”
- “H” come “Hotel”
- “I” come “IMI (internati militari italiani)”
- “L” come “Lago Santo”
- “M” come “Matteotti”
- “N” come Nidi di Ragno
- “O” come Ortona
- “P” come “Piero Gobetti”
- “Q” come “Quartieri”
- “R” come “Repubbliche partigiane”
- “S” come “Stragi”
- T come “Teatro”
- “U” come “Università”
- “V” come Venticinque Aprile 1945
- Z come “Zamboni Anteo”
- W come “Walter Audisio”
- Per saperne di più
“A” come “Armistizio”
«Il governo italiano riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto l’armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate angloamericane. La richiesta è stata accolta […]». È il testo del proclama con cui, alle 19:45 dell’8 settembre del 1943, il maresciallo Pietro Badoglio annunciò alla radio l’armistizio tra l’Italia e gli Alleati, siglato segretamente il 3 settembre a Cassibile nei pressi di Siracusa.
A seguito della destituzione e dell’arresto del duce, Benito Mussolini, dopo il Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio del 1943, il re Vittorio Emanuele III designò Pietro Badoglio come capo del governo, cui spettava il controllo militare del Paese con pieni poteri. Con l’armistizio di Cassibile, la fine dell’alleanza con la Germania nazista e lo sbarco degli angloamericani che da Salerno risalivano la Penisola, si entrò nella fase più cruenta della Seconda guerra mondiale.
Tra l’estate del 1943 e la primavera del 1945 l’Italia piombò in una spirale di violenze inaudite, rastrellamenti e stragi per rappresaglia, fino al 25 aprile del 1945, data che segnò la liberazione del Paese dal nazifascismo.
“B” come “Brigate e formazioni partigiane”
Si tratta di gruppi armati antifascisti costituitisi su base volontaria a partire dall’8 settembre del 1943 e operanti fino alla fine della guerra, nel maggio del 1945. Dopo la nascita del governo Badoglio, la destituzione di Mussolini e la formazione della repubblica sociale italiana collaborazionista della Germania nazista, s’innescò una vera e propria guerra civile.
Nelle file del cosiddetto “partigianato” confluirono gli sbandati delle forze militari regolari che cercano di sfuggire alla cattura da parte dei tedeschi o ai bandi di reclutamento della repubblica sociale italiana. A questi si unirono contadini, operai, intellettuali, ma anche donne che ricoprirono i ruoli di staffette, infermiere, informatrici ma anche combattenti. Aderirono alle formazioni partigiane tutti coloro che avevano coraggio e la capacità d’imbracciare un fucile. Insieme a loro si trovavano ex confinati, prigionieri politici e antifascisti storici. A questi ultimi toccò il compito di coordinare le formazioni partigiane nelle vesti di commissari politici.
Dal 1944 la maggior parte delle formazioni partigiane (strutturate militarmente in squadre, compagnie, battaglioni, brigate e divisioni) vennero coordinate dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), espressione dei vari partiti antifascisti, e dal Comando Generale del Corpo dei Volontari della Libertà (CVL). Le principali formazioni all’interno del CVL erano le Brigate “Garibaldi”, insieme ai GAP e alle SAP, gruppi e squadre di azione patriottica, organizzate dal Partita comunista italiano; le formazioni di “Giustizia e Libertà”, coordinate dal Partito d’Azione; mentre il Partito socialista di unità proletaria coordinava le formazioni che recavano il nome di “Giacomo Matteotti”.
“C” come “Calamandrei Piero”
Avvocato fiorentino, docente di diritto processuale civile e uno dei maggiori giuristi della propria epoca, tra i fondatori del Partito d’azione e padre della Costituzione repubblicana, Piero Calamandrei non indietreggiò dinanzi alla violenza fascista. Prese parte alla pubblicazione di diversi documenti che osteggiavano il regime, come Il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Fu uno dei principali ispiratori del Codice di procedura civile del 1940, ma quando gli fu chiesto di sottoscrivere una lettera di sottomissione a Mussolini, Calamandrei preferì dimettersi dall'incarico universitario, che avrebbe ufficialmente ripreso, come rettore, alla caduta del fascismo.
Tra i tanti testi di Piero Calamandrei scolpiti nella memoria collettiva, spicca l’epigrafe Lapide ad ignominia del 1952, come risposta all’affermazione del criminale nazista Albert Kesserling, graziato in quello stesso anno. Secondo il capo delle forze di occupazione tedesca in Italia dal 1943 al 1945, gli italiani avrebbero dovuto dedicargli un monumento. Calamandrei rispose: «Lo avrai camerata Kesselring/ il monumento che pretendi da noi italiani/ ma con che pietra si costruirà/ a deciderlo tocca a noi/ […] Su queste strade se vorrai tornare/ ai nostri posti ci ritroverai / morti e vivi collo stesso impegno/ popolo serrato intorno al monumento/ che si chiama/ ora e sempre Resistenza».
Nel Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza del 1955 si premurò poi di rammentare: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione».
“D” come “Donne”
Fu una ragazza di diciassette anni, Germana Boldrini, a lanciare il segnale che la sera del 7 novembre 1944 segnò l’inizio della battaglia di Porta Lame a Bologna tra partigiani e i nazifascisti: «Quando arrivai a Porta Lame con la mia arma automatica e le bombe a mano lanciai il fuoco, i miei compagni mi seguirono e ci fu un grande combattimento».
Non erano delle fanatiche, né portavano per partito preso il coltello in mano o fra i denti le 35mila donne che dal 1943 al 1945 parteciparono alle azioni di guerriglia partigiana per liberare l’Italia dal nazifascismo. Le oltre 4.500 arrestate, torturate, condannate, le 623 fucilate, impiccate o cadute in combattimento, oppure le circa tremila deportate in Germania cercavano semplicemente un’esistenza più dignitosa in un Paese libero dall’autoritarismo fascista.
Agognavano spazi di libertà al di fuori dagli schemi precostituiti di un regime che le aveva relegate sempre più a fondo nella sfera familiare e domestica. Molte combatterono in montagna dimostrando abnegazione e coraggio, altre cospirarono, fiancheggiarono, fornirono supporto di ogni tipo ai ribelli nella più totale clandestinità, altre ancora tennero tenacemente in piedi famiglie divise, segnate da violenze e lutti.
“E” come “Ernesto Rossi”
«Sono nettamente e decisamente antifascista […] gli stessi principi demo-liberali, ripeto, mi hanno portato dalla marcia su Roma in poi ad assumere una posizione nettamente contraria al fascismo». Con queste parole Ernesto Rossi, imprigionato nel carcere romano di Regina Coeli e condannato a 20 anni di reclusione, rivendicava nel 1930 la propria contrarietà al fascismo.
Rossi era uno dei personaggi più in vista nel campo dell’antifascismo non comunista. Per un breve periodo nel 1919 si avvicinò ai fasci di combattimento, ma se ne tirò fuori prima della marcia su Roma. Alla professione di docente di economia Rossi univa un’intensa attività clandestina, che lo portò nel 1928 a costituire una formazione clandestina repubblicana legata al gruppo di Giustizia e Libertà.
La retata della fine di ottobre del 1930, con decine di arresti tra i militanti, lo avrebbe condotto prima in carcere e poi al confino di polizia sull’isola di Ventotene come “elemento socialmente pericoloso”. Qui, insieme a Eugenio Colorni e Altiero Spinelli, s’interrogò sulla situazione europea dando vita nel 1941 a una sorta di appello ai resistenti dal titolo Per un’Europa libera e unita, divenuto poi noto come Manifesto di Ventotene. Si tratta di uno dei documenti fondativi dell’idea di Europa unita, ed è considerato una pietra miliare del federalismo europeo oltre che un progetto di pace duratura.
“F” come “Ferruccio Parri”
«E discorrendo delle cose fatte e rimaste da fare, mi pareva di veder avanzare dal fondo della sala sprezzante e ghignante l’immenso esercito parafascista, l’obeso ventre della storia d’Italia, che aveva vinto, mi aveva vinto. E dissi che moderate politiche si potevano accettare, ma una sola doveva essere intransigentemente respinta, quella che apriva la porta al fascismo» [F. Parri, Come farla finita con il fascismo, Laterza 2019]. È una delle frasi più iconiche di Ferruccio Parri, nome di battaglia “Maurizio”, che rappresentò l’anima della direzione operativa della rete partigiana. Fu promotore del Partito d'Azione (PdA) e suo rappresentante all’interno del Comitato militare del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (CLNAI), poi Vice comandante del corpo volontari della libertà (CVL).
Nato a Pinerolo nel 1890 si laureò in lettere e col grado di ufficiale prese parte alla Prima guerra mondiale, fu ferito e pluridecorato. Esercitò la professione d’insegnante e di giornalista. Considerato oppositore dal regime fascista, nella seconda metà degli anni ‘20 venne arrestato e mandato al confino di polizia. Arrestato dai tedeschi, fu trasportato in Svizzera nel quadro di uno scambio concordato di prigionieri con ufficiali germanici nelle mani dei partigiani. Partecipò attivamente alla fase conclusiva della Resistenza e all'insurrezione di Milano. Venne eletto presidente del Consiglio dei ministri nell’immediato dopoguerra.
“G” come “Giovani”
Il 75 per cento dei combattenti per la libertà dell’Italia dal nazifascismo era costituito da ragazzi nati dal 1922 al 1925. Furono 22mila i giovanissimi tra i 17 e i 19 anni che in modi e tempi diversi aderirono alla Resistenza per un «atto libero della volontà».
«Nella mia vita c’è stata una grande vacanza: ed è stato il partigianato, venti mesi di virile giovinezza, sradicato davvero, e staccato da ogni vecchia cosa». Come ricordava il partigiano e alpinista cuneese Dante Livio Bianco la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, frutto della Resistenza, fu un fatto prettamente giovanile. È fuor di dubbio che al raggiungimento dell’obiettivo supremo contribuirono in molti: uomini e donne, civili e militari, diversi tra loro per estrazione sociale, colore politico ed età.
Tuttavia, all’indomani dell’armistizio avevano abbracciato la Resistenza oltre 22mila giovanissimi tra i diciassette e i diciannove anni. Erano circa 24mila i giovani tra i venti e i ventitré anni, mentre circa 14mila tra i ventiquattro ai trent’anni.
“H” come “Hotel”
Gli hotel, gli alberghi e le ville delle principali città italiane, simboli di accoglienza, si trasformarono durante l’occupazione nazista in luoghi di orrore, tra i primi a essere liberati dalle forze partigiane. L’hotel o albergo Regina di Milano divenne uno dei luoghi più temuti dagli oppositori del regime. Dal settembre del 1943 fino alla fine di aprile del 1945 venne occupato e trasformato in sede del comando delle SS e il quartier generale della Gestapo, la struttura fu un luogo di detenzioni, interrogatori, torture.
I partigiani catturati venivano rinchiusi e brutalizzati tra le sue mura, prima di essere trasferiti nel carcere di San Vittore, condotti a morte oppure al tristemente noto “Binario” 21 della stazione Centrale di Milano per essere deportati e internati nel lager nazisti.
Analoga sorte subì l’hotel Excelsior di Firenze: occupato dai nazisti divenne la residenza di alti ufficiali del comando, ma anche luogo indecoroso di festini e scandali. Venne liberato l’8 agosto del 1944 dai partigiani delle brigate Sinigaglia e Lanciotto. A Roma, dal settembre 1943 al gennaio del 1944, le sale del Grand Hotel Flora erano zeppe di nazisti da quando la Wehrmacht ne utilizzò il secondo piano come sede dell’alto comando. Nell’hotel Meina, a Meina in provincia di Novara, tra il 22 e il 23 settembre del 1943 si registrò il primo sterminio di ebrei in Italia. Sedici persone tra cui anziani e bambini furono arrestate e tenute prigionieri in un’unica stanza dell’albergo, poi ferocemente uccisi e gettati nel lago Maggiore.
“I” come “IMI (internati militari italiani)”
All’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 quasi 700mila soldati italiani, che si trovavano di stanza nei Balcani e sul mar Egeo, videro d’un sol colpo modificato il loro status: da occupanti a esercito sconfitto. Si trovarono dinnanzi a un bivio: la resa e l’internamento nei lager della Germania nazista, continuare a combattere al fianco del vecchio alleato germanico oppure unirsi alle formazioni partigiane greche e jugoslave combattute fino a poco tempo prima.
La maggior parte decise di schierarsi contro la barbarie nazista ricevendo l’etichetta di Italianische Militärinternierten (internati militari), una sorta di “stigma” che li privò dello status di prigionieri di guerra e dunque dalle garanzie della Convenzione di Ginevra e del controllo della Croce Rossa.
Gli IMI patirono la fame, le intemperie, le malattie e poi violenze, soprusi, angherie, il sovraffollamento delle baracche in cui erano stipati e con esso le scarsa se non inesistente igiene. «Non abbiamo vissuto come i bruti. Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra terra non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili, uomini con un passato e un avvenire» affermò nel dopoguerra lo scrittore Giovannino Guareschi, rimembrando il proprio passato.
La vicenda degli IMI mostra come la Resistenza non fu solo lotta armata, ma anche resistenza morale e civile, passiva anche in condizioni estreme. La considerazione degli IMI come parte integrante della Resistenza al nazifascismo è un’acquisizione storiografica recente.
“L” come “Lago Santo”
«Da questo rifugio nove partigiani dopo venti ore di dura battaglia dispersero soverchianti forze nemiche. Il grido di vittoria echeggiò per le convalli e insorse la nuova Italia». Una lapide racconta cosa accadde il 18 marzo 1944 sul Lago Santo, tra le montagne dell’alta Val di Parma, sull’Appennino parmense.
Per sfuggire agli incessanti rastrellamenti nazisti, nove partigiani appartenenti al distaccamento “Guido Picelli”, operante in Lunigiana, ripararono nel rifugio “Mariotti”, attendendo l’arrivo dei rinforzi. A sera i nove partigiani vennero circondati e attaccati da un centinaio di militi fascisti della XMas e da numerosi nazisti. Dopo circa 24 ore di combattimento gli assedianti si ritirarono lasciando sul campo 16 morti e decine di feriti.
A guidare il distaccamento partigiano è il calabrese Dante Castellucci, nome di battaglia “Facio”, che insieme al suo distaccamento venne ricordato come «uno dei più nutriti e agguerriti battaglioni partigiani del territorio». L’eroe del Lago Santo, Dante Castellucci, è considerato una delle vittime più celebri di giustizia sommaria intra-partigiana. Invidie e contrasti gli valsero l’accusa di essersi appropriato di equipaggiamento militare destinato a un’atra formazione partigiana e la condanna a morte per fucilazione all’alba del 22 luglio del 1944.
“M” come “Matteotti”
Nel Polesine degli inizi del Novecento, una delle aree più depresse d’Italia, i braccianti stretti in una morsa di fame, miseria e pellagra, deposero tutte le speranze nel giovane Giacomo Matteotti. Li accolse tutti tra le sue larghe braccia, parlava loro di riforme, cooperazione e istruzione equa e popolare, fiducia nello stato, passaggi graduali verso un socialismo che rifuggiva le soluzioni rivoluzionarie e violente. Dinanzi alle “squadracce” fasciste che parlavano esclusivamente il linguaggio del manganello, il deputato socialista Giacomo Matteotti frappose tutto sé stesso. Insultato, sputato, spintonato, pestato, umiliato, finanche violato nella più profonda intimità, pugnalato e, infine, occultato. Correva l’anno 1924.
Il corpo di Giacomo Matteotti, rinvenuto in un bosco a Riano dopo due mesi dal rapimento e segnato da torture e pugnalate, non fu solo la scoperta di un cadavere. Fu la materializzazione delle atrocità del fascismo che si preparava a diventare regime, ma incarnò soprattutto il coraggio e la coerenza di un uomo disposto a sacrificare la vita per l’espressione d’idee di libertà e giustizia. La “stella” di Giacomo Matteotti tornò a brillare durante la Resistenza sulle divise dei partigiani delle omonime brigate legate al Partito socialista italiano di unità proletaria.
“N” come Nidi di Ragno
«Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale […] Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni: per l’operaio dal suo sfruttamento, per il contadino dalla sua ignoranza, per il piccolo borghese dalle sue inibizioni, per il paria dalla sua corruzione». Restano indelebilmente scolpite della memoria antifascista le parole che lo scrittore Italo Calvino nel suo romanzo d’esordioIl sentiero dei nidi di ragno (1947) mette in bocca al commissario Kim, lo studente universitario comandante di una brigata partigiana che spiega ai compagni le ragioni profonde, politiche ma soprattutto etico-esistenziali dell’adesione alla Resistenza.
Tra il 1944 e il 1945 lo scrittore partecipò alle fasi più cruente della Resistenza sanremese al nazifascismo e tra bombardamenti e rappresaglie conobbe quel «lancinante mondo umano» che avrebbe orientato la sua attività di scrittore.
“O” come Ortona
Tra il 20 e il 28 dicembre del 1943 la città abruzzese fu teatro di uno degli scontri più duri sul fronte italiano durante la Seconda guerra mondiale. Vi presero parte le truppe tedesche della Prima divisione paracadutisti e le forze canadesi della Prima divisione fanteria.
Ortona aveva un’importanza strategica per la risalita Alleata lungo la costa adriatica, perciò i combattimenti furono intensi, ebbero luogo casa per casa, producendo devastazioni e numerose perdite civili. Dopo otto giorni di durissimi scontri alla fine i tedeschi si ritirarono, ma la città abruzzese fu quasi completamente rasa al suolo.
La battaglia di Ortona è ricordata come “piccola Stalingrado d’Italia” per la ferocia e il grande numero di vittime civili (oltre 1300) simbolo del sacrificio di civili e militari nella lotta per la Liberazione. Pertanto, la città venne insignita della medaglia d’oro al valore civile.
“P” come “Piero Gobetti”
Nelle formazioni partigiane legate al gruppo di Giustizia e Libertà militavano Ada Prospero e il giovane Paolo Gobetti. Erano rispettivamente la moglie e il figlio di un antifascista della prima ora, spentosi nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 1926 a Parigi, dove si trovava in esilio, a soli 25 anni.
L’intellettuale antifascista Piero Gobetti da diversi mesi era oggetto di persecuzioni e pestaggi da parte dei fascisti. La relazione con Ada Prospero, nata "tra le righe" della rivista Energie Nove, si nutrì di scambi epistolari molto intensi su amore, senso della vita e rivoluzione.
Fiaccato nel fisico ma non nella mente, da una clinica parigina la sera prima di morire, Pier prometteva ad Ada un più roseo avvenire: «Anch’io penso con fede e gioia alla vita nuova che ci costruiremo laggiù, sotto un altro cielo». Così si spegneva uno degli oppositori più tenaci di Benito Mussolini e della tirannide da lui instaurata, che lo stesso duce aveva “raccomandato” alla pubblica sicurezza: «Vigilare per rendere nuovamente difficile vita questo insulso oppositore di governo e fascismo».
Per Gobetti il fascismo era il condensato delle peggiori tradizioni italiane: autoritarismo, opportunismo e servilismo. Al contrario, con la sua rivista Rivoluzione liberale, Gobetti si era fatto promotore di un’idea di antifascismo come rigenerazione morale e civile del Paese, opponendo alla dittatura del partito unico una rivoluzione di tipo liberale, cioè un processo di emancipazione individuale e collettiva fondato su libertà, responsabilità, coscienza critica e autonomia morale. Le idee di Piero Gobetti sopravvissero negli intellettuali antifascisti legati a Giustizia e Libertà e nei cattolici democratici. Pur non avendo partecipato alla Resistenza con le armi, Gobetti ne è a pieno titolo uno dei padri spirituali.
“Q” come “Quartieri”
Durante la Resistenza, i quartieri popolari di alcune grandi città italiane furono luoghi strategici di opposizione al nazifascismo. Nei contesti urbani si sviluppò una resistenza dal basso, spesso spontanea, fatta di sacrificio e coraggio e di una forte coscienza civile.
San Lorenzo, cuore operaio e antifascista di Roma, dopo il tragico bombardamento di luglio del 1943, la popolazione partecipò attivamente alla lotta partigiana, nascose perseguitati politici, sostenne la stampa clandestina, portò avanti azioni di sabotaggio delle linee fasciste. A Barriera di Milano, quartiere operaio e periferico di Torino, si crearono reti di solidarietà tra lavoratori, studenti e partigiani urbani che diedero vita a episodi di sabotaggio. Anche Porta San Vitale a Bologna vide la nascita di numerosi gruppi partigiani urbani: le vie strette e i portici offrivano rifugi e passaggi sicuri alle staffette, e molte abitazioni ospitarono riunioni clandestine.
“R” come “Repubbliche partigiane”
Note anche come “zone libere”, “zone partigiane” oppure “distretti partigiani” erano in definitiva territori temporaneamente sottratti dai partigiani al controllo nazifascista tra l’estate e l’autunno del 1944. Nacquero per «la volontà di trasformare la lotta armata in un’istituzione politica democratica, basata sul sostanziale rinnovamento sociale» scrivono gli storici Marcello Flores e Mimmo Franzinelli.
Qui le bande partigiane, con il supporto della popolazione civile, istituirono governi provvisori con giunte che si occupavano di amministrare la giustizia, gestire gli approvvigionamenti, i servizi postali, telegrafici e i trasporti ma allo stesso tempo prendersi cura di feriti e malati. Si trattava di esperienze locali di autonomia democratica, con i relativi pregi e storture, ma proprio per questo furono considerate come “prove generali” di autogoverno e partecipazione popolare.
Secondo molti studiosi le repubbliche partigiane rappresentarono un tentativo di passare alla fase successiva rispetto a quella delle armi, tentare cioè di costruire un futuro fatto di libertà, uguaglianza e partecipazione. Le zone libere e le repubbliche si insediano in Piemonte (Langhe e Alto Monferrato, Ossola, Lanzo, Mombercelli), Liguria (Torriglia), Lombardia (Saviore, Varzi), Emilia-Romagna (Bardi, Bobbio, Montefiorino), Friuli Venezia Giulia (Carnia e Friuli orientale, Nimis) e Umbria (Cascia).
“S” come “Stragi”
Tra l’estate del 1943 e la primavera del 1945 l’Italia piombò in una spirale di violenze inaudite, rastrellamenti e stragi per rappresaglia, fino al 25 aprile del 1945, data che segnò la liberazione del Paese dal nazifascismo e la fine della guerra.
Secondo i dati raccolti nell’Atlante delle stragi nazifasciste si contano in totale 23.662 vittime in oltre 5mila episodi di violenza, stragi e uccisioni perpetrate ai danni della popolazione civile inerme e dei partigiani da parte dei reparti armati tedeschi e dei “repubblichini” di Salò. Il picco di vittime (11744 in 2071 episodi) si raggiunse tra la primavera e l’estate del 1944 con stragi frutto di una precisa strategia, definita “eliminazionista”. Si trattava di operazioni che nascevano come rastrellamenti partigiani o come operazioni di ripulitura di aree militarmente strategiche, ma che «affiancano all’obiettivo strategico la finalità di giustiziare e sterminare una intera comunità, donne e bambini inclusi. Stragi che conducono quindi all’eliminazione di intere comunità di civili; o in alternativa allo sterminio di interi gruppi di prigionieri» scrivono i redattori dell’Atlante.
Nate per rappresaglia per intimidire la popolazione e ostacolare la Resistenza, le stragi ebbero l’effetto opposto: rafforzarono l’odio contro l’occupazione nazifascista e alimentarono il sostegno alla lotta partigiana. Le tre stragi principali commesse dai nazisti in Italia durante l’occupazione:
- Fosse Ardeatine (Roma, 24 marzo 1944). Il 24 marzo del 1944 nelle cave di pozzolana nei pressi della via Ardeatina a Roma 335 persone furono trucidate dai nazifascisti al comando di Herbert Kappler come rappresaglia per l’attentato partigiano di via Rasella.
- Marzabotto o “eccidio di Monte Sole” (settembre-ottobre 1944). Circa 800 civili, tra cui donne e bambini, vennero massacrati dalle truppe naziste nei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana nei pressi di Bologna.
- Sant’Anna di Stazzema. Il 12 agosto 1944 vari reparti tedeschi mitragliarono centinaia di civili a Sant’Anna e nelle altre frazioni di Stazzema (Lucca), dando i loro corpi alle fiamme per coprire l’eccidio.
T come “Teatro”
Nel 1941 giunse nella pianura reggiana una compagnia di teatranti girovaghi mandata dal Partito comunista. Interpretavano opere della tradizione, come la Tosca di Puccini, e con esse predicavano la dignità dell’uomo e la liberazione dalla schiavitù. Si opponevano al fascismo. «La mia vita prendetevela, che non abbia più l’orrore di vedervi. Sgherri infami di una più infame tirannia, sole vigliacco che le dai la tua luce» tuonava sulla scena Lucia Sarzi, la “stella” della compagnia.
Il pensiero unico imposto dal regime non ammetteva satira, canzonature e motteggi. Secondo il giurista Pietro Calamandrei «uno degli effetti più visibili del totalitarismo era stato quello di paralizzare il senso del ridicolo». In tal senso la famiglia Sarzi insegnò a una grigia e pavida provincia italiana l’arte e la forza dirompente della satira, nemica di ogni dittatura. Erano giovani, sfrontati e disposti con abili giochi di parole, contesti e simbologie a prendersi gioco dei fascisti.
“U” come “Università”
Durante il ventennio fascista, molte università italiane subirono epurazioni, intimidazioni e furono soggette a rigida censura e propaganda. Già prima dell’8 settembre del 1943, in diversi atenei si formarono nuclei di opposizione al regime.
Dopo l’occupazione nazista, alcune università divennero veri e propri centri di resistenza, laboratori di libertà, fucine di pensiero ma anche azione concreta. A Padova professori e studenti crearono reti clandestine fornendo supporto ai partigiani. A Palazzo Bo una grande stele di pietra porta il nome dei 116 caduti dell’università nella lotta al nazifascismo, di cui 107 sono studenti. Il 12 novembre 1945 l’ateneo fu insignito della medaglia d’oro al valor militare. A Firenze l’università ospitò riunioni del Partito d’Azione e la lotta coinvolse intellettuali come Ernesto Rossi e Tristano Codignola. Tra gli studenti dell’ateneo fiorentino nella facoltà di lettere e filosofia spicca la bolognese Anna Maria Enriques Agnoletti, di padre ebreo, dovette rinunciare al proprio incarico all’Archivio di Stato di Firenze e abbracciò la Resistenza. Proprio a Firenze, dopo l’Armistizio, Anna Maria aiutò molte famiglie ebree a reperire quei documenti che gli avrebbero consentito di mettersi in salvo. Venne arrestata dai nazifascisti il 15 maggio 1944, torturata e uccisa. Dopo la Liberazione venne insignita della medaglia d’oro al valor militare. A Torino la resistenza degli studenti si saldò a quella operaia nelle fabbriche e nei quartieri popolari, mentre l’ateneo di Bologna fu coinvolto negli scioperi e nelle azioni contro i nazifascisti. Anche l’università di Roma fu teatro di proteste e arresti nei GAP (Gruppi di Azione Patriottica). A Milano la Cattolica offrì un contributo in termini di resistenza civile e religiosa, mentre numerosi docenti e studenti della Statale si unirono in prima persona alla resistenza armata.
“V” come "Venticinque Aprile 1945"
La mattina del 15 Aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) riunitosi nell’Istituto dei salesiani in via Copernico a Milano, decise per l’insurrezione e allo stesso tempo assunse i poteri civili e militari in nome del popolo italiano e in qualità di delegato del governo.
Nel corso dello stesso incontro venne approvato un decreto che sciolse i tribunali di guerra, i reparti fascisti e decise le modalità di trattamento dei prigionieri fascisti e dello stesso Mussolini: «I membri e i gerarchi del Governo fascista ed i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del Paese e di averlo meglio condotto all’attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l’ergastolo».
Nel tardo pomeriggio Mussolini, che si trovava in prefettura a Milano, dopo aver rifiutato la resa incondizionata, fuggiva verso Como protetto da una colonna di militi. Da quel momento in poi «risuonano lungamente in città le sirene degli stabilimenti: è l’annuncio dell’occupazione delle fabbriche, ma la situazione rimane militarmente fluida, anche perché in città vi sono oltre diecimila fascisti armati» scrivono gli storici Flores e Franzinelli. La prima città lombarda a essere liberata è Busto Arsizio, preludio alla liberazione di Varese e di Milano.
"Z" come “Zamboni Anteo”
«Se tu vedessi, babbo, che faccia da delinquente ha Mussolini» confidò il sedicenne Anteo Zamboni al padre Mammolo, tipografo bolognese d’idee antifasciste. Il 31 ottobre 1926, quarto anniversario della marcia su Roma, Mussolini si trovava a Bologna per una serie d’inaugurazioni e poco prima delle 18 si apprestava a raggiungere, a bordo di un’Alfa Romeo scoperta guidata dal gerarca bolognese Arpinati, la stazione ferroviaria per far ritorno a Roma.
Tra via Rizzoli e via Indipendenza ci fu «uno sparo. Il colpo lacera la sciarpa mauriziana e la giubba di Mussolini, poi buca il polsino della camicia nera del podestà di Bologna. Sul marciapiede a destra dell’auto, il subbuglio. Novanta secondi dopo lo sparo, giace con quattordici pugnalate, segni di strangolamento e un colpo di pistola, un ragazzo esile, slanciato, i capelli biondicci. Ha sedici anni, si chiama Anteo Zamboni, tipografo…».
Anteo Zamboni è il più giovane dei sei, cinque uomini e una donna (Tito Zaniboni, Violet Gibson, Gino Lucetti, Michele Schirru e Angelo Pellegrino Sbardellotto), che tra il 1925 e il 1932 tentarono di assassinare il capo del fascismo Benito Mussolini. Il duce sfruttò gli attentati per rafforzare il proprio potere, presentandosi come vittima e giustificando la repressione. Tuttavia, questi tentativi mostrarono l’esistenza di un dissenso attivo e radicale, pronto a mettere a repentaglio la propria incolumità fisica pur di metter fine alla dittatura.
W come “Walter Audisio”
È il nome, poco noto, di un uomo cui il 28 aprile del 1925 toccò il compito di giustiziare Benito Mussolini, capo della Repubblica sociale italiana e già duce del fascismo. Walter Audisio, del comando generale del CVL (Corpo Volontari della Libertà) di Milano, nome di battaglia “colonnello Valerio”, fu mandato a Dongo, dove Mussolini era stato catturato e preso in custodia, per eseguirne la condanna a morte deliberata all’unanimità dal triumvirato insurrezionale e comunicata al “colonnello Valerio” da Luigi Longo.
Nel pomeriggio del 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra, sul lago di Como, una raffica di mitra pose fine alla vita di Benito Mussolini e dell’amata Claretta Petacci. Il compito di Audisio non finì lì: caricati su di un camion i corpi di Mussolini, di Petacci e di una quindicina di gerarchi, nella notte tra il 28 e il 29 aprile 1945 vennero trasportati alla volta di Milano, dove la mattina successiva furono esposti allo sguardo della folla, appesi a testa in giù alle travi metalliche di un distributore di benzina di piazzale Loreto. Porre fine alla vita dell’ex capo del fascismo significava chiudere definitivamente un ventennio di dittatura, guerre e repressione e marcare così una rottura netta con il passato fascista.
Per saperne di più
Storia della Resistenza. Marcello Flores, Mimmo Franzinelli. Laterza, Roma-Bari, 2019.
La resistenza lunga. Storia dell’antifascismo (1919-1945). Simona Colarizi. Laterza, Roma-Bari,
2023.
La Resistenza delle donne. Benedetta Tobagi. Einaudi, Torino, 2022.