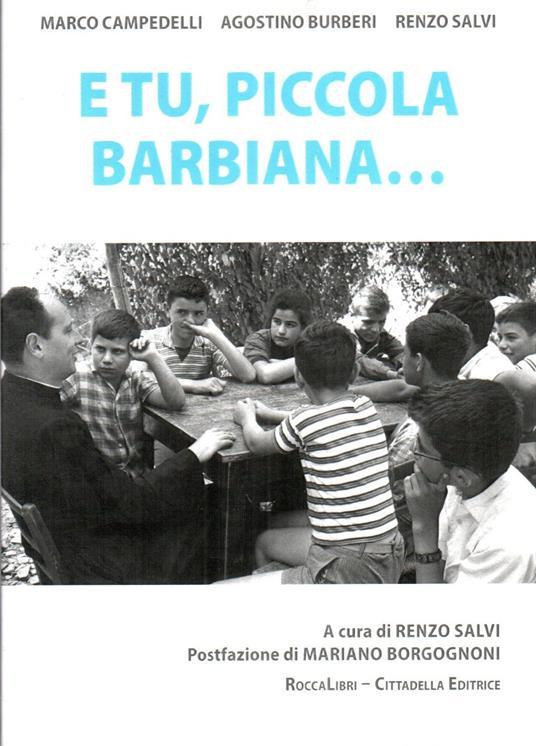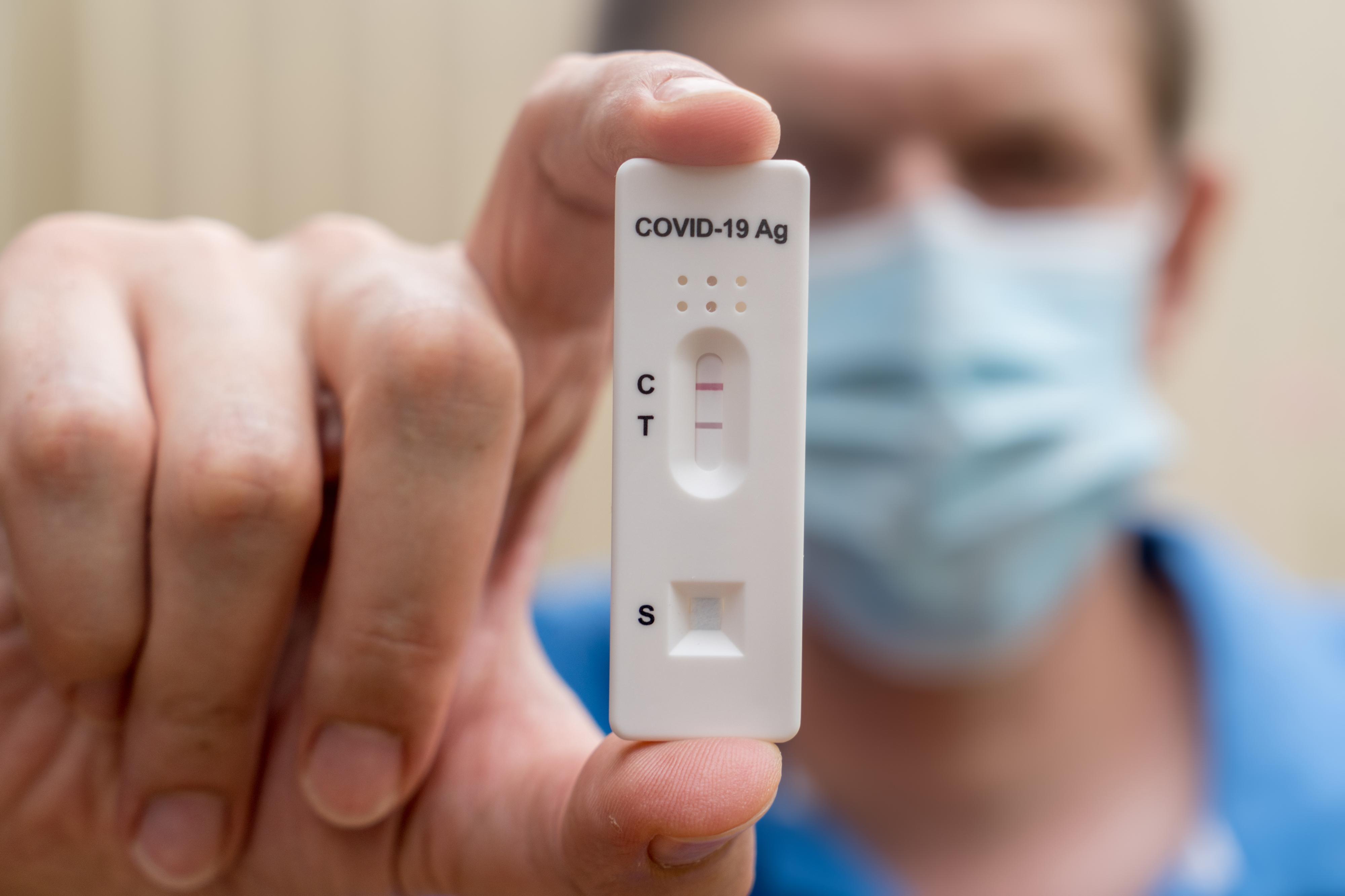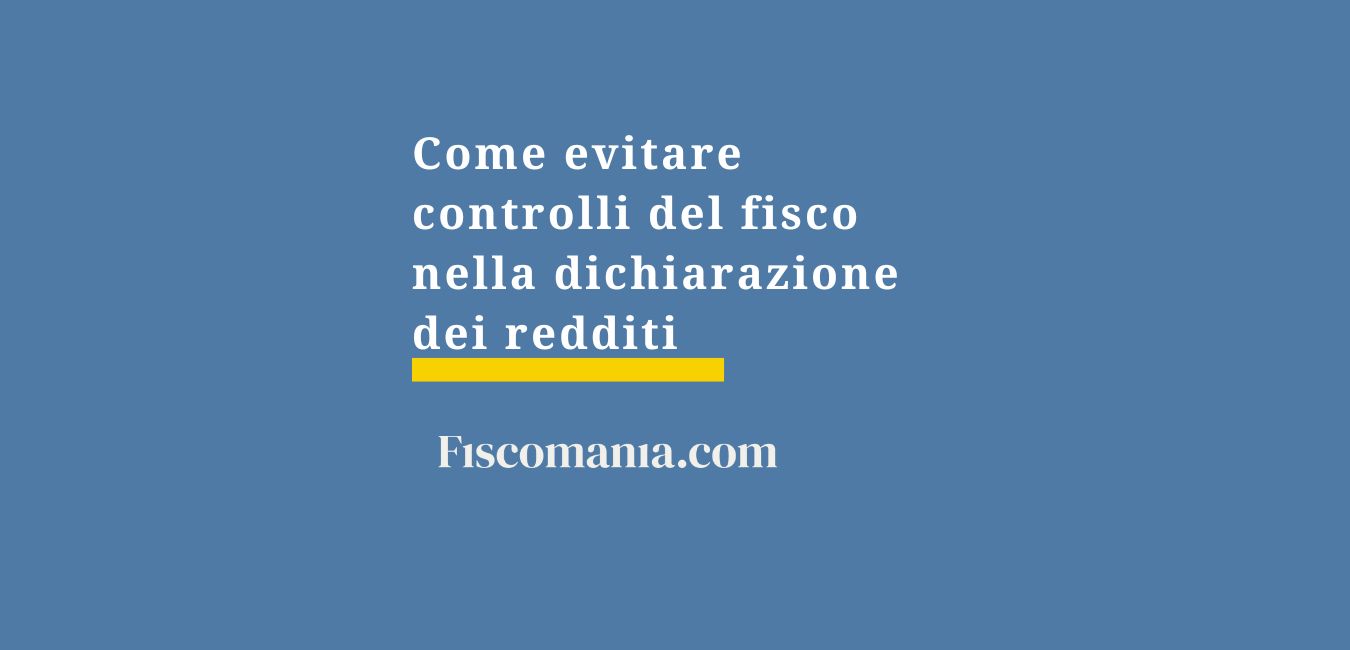La questione della cittadinanza nell’epoca delle migrazioni di massa
PER UNO IUS CULTURAE CHE SOSTENGA L’INCLUSIONE PERCHÉ IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA AVANZATA I CRITERI DI CONCESSIONE BREVE E AUTOMATICA DEL DIRITTO DI VOTO NON RAPPRESENTANO UN VANTAGGIO Nel dibattito […]

PER UNO IUS CULTURAE CHE SOSTENGA L’INCLUSIONE
PERCHÉ IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA AVANZATA I CRITERI DI CONCESSIONE BREVE E AUTOMATICA DEL DIRITTO DI VOTO NON RAPPRESENTANO UN VANTAGGIO
Nel dibattito nazionale vi è una giustapposizione tra la questione inerente le condizioni di accesso allo status di cittadino e quella del riconoscimento dei diritti dei migranti con il conseguente valore dell’accoglienza e integrazione degli stessi. Questa, però, è spesso fuorviante e non permette di comprendere appieno il significato del concetto di cittadinanza e le reali conseguenze che si possono avere con la facilitazione dei relativi criteri di accesso.
1) Profili politici sulla cittadinanza ed il connesso diritto di voto.
E’ bene ricordare che lo status della cittadinanza è un elemento importante della sovranità democratica, ontologicamente una prerogativa della nazione, a vantaggio degli interessi dei suoi membri che giustifica l’esercizio discrezionale della sua “concessione”. Solo in secondo luogo subentra la questione della convenienza, ovvero interesse, del cittadino straniero ad ottenere la cittadinanza anche del Paese in cui è residente. Questo si differenzia dal caso, al contrario, del “riconoscimento” di un diritto, in cui, sempre in uno stato democratico (e liberale), si deve considerare in primo luogo l’interesse dell’individuo e, solo in secondo luogo e in maniera marginale, l’interesse dell’istituzione statale.
Quanto sopra è rilevante anche perché, diversamente che in passato – come, ad esempio, ai tempi dell’estensione della cittadinanza da parte dell’imperatore romano Antonino Pio – oggi tale status permette di esercitare il diritto politico del voto il quale ha conseguenze su un intero popolo e non, quindi, solo sulla persona che vi accede.
In una società democratica, tale diritto appartiene ai consociati di un Stato, ovvero al suo popolo. A riguardo, l’art. 1 della nostra Costituzione è chiaro sul punto: “La sovranità appartiene al popolo”; dunque, non alla popolazione, ossia ai meri abitanti di un territorio. Questo comporta l’esistenza di un soggetto titolare che va al di là di una mera sommatoria di individui, anche se questi condividono un territorio e dei governanti. Il popolo possiede qualcosa in più rispetto alla popolazione: gli è affidata la massima espressione dell’attività politica, ossia l’esercizio della sovranità di uno Stato; esso è l’insieme degli individui che si considerano appartenenti a una stessa collettività caratterizzata da fattori omogenei rilevanti e, per essere più precisi, citando la Dichiarazione Universale dei Diritti Collettivi dei Popoli, costituisce un popolo “ogni collettività umana avente un riferimento comune ad una propria cultura e una propria tradizione storica, sviluppate su un territorio geograficamente determinato (…)”. Questo comporta che ogni nazione, attraverso l’attività politica ed il voto in particolare, si autodetermina escludendo naturalmente altri popoli dall’ingerenza negli affari della propria collettività.
Da questo consegue che votano coloro che, almeno di base, hanno una storia e una cultura, dunque una memoria, condivisa nonché un senso di appartenenza e un destino che sentono comune. Pensiamo, in questo ultimo caso, alla memoria dei propri antenati o anche nonni che hanno condiviso percorsi, drammi, speranze ma anche divisioni, scontri, aspirazioni e lavoro comune da cui è scaturita la nazione così com’è. Da qui sorge un particolare legame con scrittori, artisti ed altri intellettuali nazionali del passato e non solo, che ci consegnano il senso anche dell’importanza del preservare memorie, sentimenti, opere, compresi i monumenti, ed altri valori e simboli condivisi. Patrimoni, questi, che non possono rischiare di essere ignorati o cancellati da qualsiasi esigenza, tendenza, convenienza del momento che li ignori, proprio per la loro portata storico-culturale-affettiva costituente un legame importante per un popolo, con cui questo si preserva e può meglio guardare al nuovo. Allora, ci si deve chiedere chi garantisce che persone che non abbiano questo passato o, comunque, non lo sentano come proprio possano contribuire ad averne cura e preservare tutto questo.
2) Immigrazione, società e Comunità politica.
Quanto sopra ha una rilevanza collettiva e prospettiva politica tali, per cui occorrerebbe soffermarvisi adeguatamente, a causa del suo impatto sulle odierne democrazie, sul concetto di sovranità e popolo, nonché sui rapporti tra Stati.
Tali questioni si devono porre ancor più oggi, dinnanzi al cambiamento epocale rappresentato dal fenomeno delle migrazioni di massa che caratterizza fortemente il nostro tempo e che lo farà ancora a lungo; fenomeno che sta modificando fortemente e visibilmente il tessuto sociale delle nostre società occidentali. I modi di essere, di sentire, di pensare, di integrarsi e includersi in Italia di tali stranieri sono alquanto differenti tra loro, benché molte volte possano ritrovarsi forti caratteristiche comuni per nazionalità a cui si appartiene; quindi, è pressoché impossibile operare qui generalizzazioni. Molti di loro abitano, studiano o lavorano in Italia ma, tuttavia, vivono in un contesto di vita e di orizzonte pienamente dentro la propria nazione, frequentando principalmente propri connazionali, raggruppati spesso in determinati quartieri, con proprie letture, canali TV, reti di protezione, negozi, botteghe e interessi vari interni a quel proprio orizzonte, con le rispettive lingue.Infatti, la rete internet e i canali satellitari, in particolare, permettono oggi ad un immigrato di rimanere ancora con la testa e il cuore nella propria nazione anche se vive in un’altra, con il tipico stile di vita dei Paesi di provenienza, riuscendo in diversi modi a replicarlo in buona parte sul nostro territorio; quindi in una dimensione culturale, di costume nonché, spesso, di mentalità, di origine e a prescindere dal loro grado di integrazione in Italia.
L’afflusso di nuovi immigrati continuerà inesorabile ed una società multietnica è un’orizzonte inarrestabile; allora, dinnanzi a tale forte e progressivo impatto numerico, la questione non è certo l’ostacolare il fenomeno. Si impone, però, come dimostrato dal relativo dibattito, una questione inerente l’accesso alla cittadinanza per quegli stranieri – si immagina sostanzialmente tutti – che lo desiderano, nonché su cosa questo comporti e debba significare.
Iniziando a considerare che la cittadinanza è rappresentativa di un “noi”, ciò dovrebbe comportare, appunto, un minimo di identità e di condiviso senso di comunità. Un noi che, in quanto tale, prevede necessariamente gli “altri”. La questione, allora, è il rapporto da avere con questi “altri” e, in proposito, è anche dalla qualità di questo rapporto che si misura il grado di civiltà di una nazione. La storia e cultura italiane hanno generato valori costituenti una identità che oggi possiamo definire repubblicana. Tali valori si fondano su temi quali la forma di Stato, la qualità del suo rapporto con i cittadini nonché i rapporti tra questi ultimi. Si pensi, in particolare, al divieto di pena di morte, ai diritti delle donne, a quelli di parola e pensiero, alle garanzie del processo penale, la stessa legislazione a protezione degli stranieri e rifugiati, ma anche la protezione dei nostri beni culturali, che spesso si dà per scontati, ma che sono da difendere e consolidare. In proposito, sarebbe utile confrontarsi con stranieri integrati, talvolta neo cittadini, in merito alle loro idee su questi principi e, anche, sulle stesse politiche di accoglienza di migranti e rifugiati che noi adottiamo, per comprendere meglio quanto sopra.
Dunque, dato che i concittadini concorrono a determinare con il voto la vita politica nazionale, è opportuno che questi sentano come propri tali valori, ancor più considerando che nella generalità dei Paesi di provenienza degli immigrati tali rapporti e principi sono differenti.
Di conseguenza occorrerebbe disciplinare sapientemente l’accesso alla nuova cittadinanza con la contemporanea previsione di appositi efficaci percorsi per ottenerla, al fine di garantire la difesa di principi fondamentali, di una idea comune di progresso, insieme alla tenuta del sistema politico e socio-economico dell’Italia, nonché dei diritti e degli interessi sottesi. Con questo, consapevoli che la cittadinanza, almeno in uno Stato democratico come il nostro, giustamente non è condizione per il godimento dei diritti umani, civili e sociali.
Tuttavia, in Italia, la discussione a favore della modifica delle condizioni per la concessione della cittadinanza agli stranieri è incentrata, principalmente, su un’argomentazione di carattere prettamente umanitario; ma, posta in tali termini, essa non è, appunto, fondata, specie quando, tale status viene idealizzato, quasi fosse un surrogato a zero spese di servizi sociali carenti. E, per fortuna, i rapporti sociali, sia tra adulti che tra bambini, non sono certo generalmente condizionati dal tipo di documento posseduto, quanto, piuttosto, dalle caratteristiche e condizioni personali di ciascuno.
Vero è che non possedere la cittadinanza italiana può avere piuttosto conseguenze burocratiche, a volte anche molto fastidiose. Allora, per non sacrificare i rilevanti principi sin qui menzionati, la soluzione ai problemi di chi possiede un permesso di soggiorno va cercata in quello stesso ambito amministrativo, rendendo, cioè, più agevole il rapporto con la burocrazia, come, ad esempio, con le pratiche di rinnovo di tali permessi che sono in effetti troppo lunghi, così come quelli per ottenere una risposta alla stessa richiesta di cittadinanza, una volta posseduti i requisiti.
3) L’accesso breve alla cittadinanza come fattore di rischio per il processo di inclusione.
Il fatto è che, attraverso un accesso breve alla cittadinanza, si prospetterebbe un rischio per niente considerato dai suoi sostenitori: cioè, quello di avere come effetto il giungere a dare per scontato per i neo cittadini il verificarsi dei processi di integrazione ed inclusione, anche quando questi siano del tutto assenti, con il conseguente venir meno del relativo interesse da parte delle istituzioni a promuoverli e sino a giungere ad intaccarne le ragioni. Infatti, lo straniero che continui a vivere la propria dimensione nazionale anche nel Paese di immigrazione e che riceva presto la cittadinanza non si sentirebbe più tanto spinto a una integrazione nel tessuto della nazione in cui è emigrato. Perché mai dovrebbe adeguarsi a vivere nella dimensione di quelli che sono ormai suoi concittadini, quando si sente consolidato nella sua comunità di provenienza? E perché i primi, diciamo autoctoni, dovrebbero invitare altri gruppi di neo cittadini ad integrarsi come prima? Perché, ad esempio, i nostri concittadini bangladesi, con ormai comunità etniche organizzate, dovrebbero sentirsi indotti ad avvicinarsi alla nostra cultura, ovvero ad aspirare a far parte della nostra comunità nazionale? In tal modo, i nuovi cittadini potrebbero ben consolidare il proprio orizzonte di integrazione essenzialmente nelle proprie comunità nazionali, ovvero etnico-linguistiche, di provenienza, diventando queste esaurienti per costruirvi il proprio futuro. Quindi, all’integrazione sul territorio ci penserebbero da soli ma all’inclusione potrebbero non avere più interesse, semmai ve ne fosse ancora senso. La lingua italiana si ridurrebbe a una sorta di lingua franca sul nostro territorio, almeno fino a quando la progressiva anglicizzazione del nostro linguaggio avrà fatto il suo corso. Si rischierebbe seriamente, in tal modo, di creare in Italia una società – a questo punto, “territoriale” – di fatto divisa in più comunità; più che multietnica sarebbe plurinazionale, cristallizzando, almeno nel medio periodo, tale condizione.
A meno che, i sostenitori della cittadinanza facile ritengano che questo non sia affatto un problema; allora, si attende che essi esplicitino la loro idea di tale società ed, eventuale sistema politico, con cui confrontarsi con interesse.
Nel frattempo, occorrerebbe chiedersi con quale pretesa (perché alla fine si tratterebbe di questo) noi (“noi” chi, a questo punto?) dovremmo voler integrare o, comunque, aprire percorsi di inclusione di altri, ormai, (neo)concittadini che non hanno dimostrato già di essere inclusi. Dinnanzi a questa realtà, un relativo senso di responsabilità ad accogliere rischia di non trovare più spazio né legittimazione. Questo ci porrebbe anche di fronte ad interrogativi sul futuro dei nostri assetti sociali, culturali e politici, considerando anche le conseguenze che vi sarebbero a causa dell’esercizio del diritto di voto tra realtà così differenti, ove voterebbero anche persone cresciute in contesti e/o sistemi socio-politici e culturali differenti se non opposti. Dovremmo forse immaginare futuri compromessi tra i nostri principi politici e giuridici ed i loro? Inoltre, ad esempio, le scuole autonome interne alle comunità cinesi, in cui queste mandano i propri ragazzi, pretenderanno e, magari, otterranno il riconoscimento di scuole paritarie, con i loro specifici programmi e lingua di insegnamento?
Forse, allora, dovremmo anche immaginare una nuova conformazione della nostra popolazione – che popolo e, sicuramente, nazione, sarebbe difficile col tempo definirla – dato che poi potrebbe seguirne il venir meno di quella tradizionale unità di cultura, lingua, tradizione e memoria storica di cittadini di uno stesso Stato, con conseguenze impreviste e tutte da verificare. Sperando, inoltre, che da questo non sorgano anche contrasti violenti. D’altronde, come visto con l’esperienza francese, i fenomeni di ghettizzazione e di esclusione sociale nelle periferie urbane prescindono dal possesso o meno della cittadinanza la quale, appunto, dà per scontata l’integrazione e non contempla percorsi di inclusione.
Invero, il processo di integrazione e di inclusione di chi vive stabilmente in un’altra nazione è importante per gli immigrati come per gli autoctoni e la meta della cittadinanza deve essere lo strumento da utilizzare a tale fine. Questo, affinché la società multietnica sia una ricchezza e non sia di ostacolo al consolidamento e sviluppo, magari anche in forme rinnovate, di una comune società civile, democratica e solidale.
4) geopolitica e interesse nazionale.
Altra importante questione collegata riguarda il rapporto con l’attuale mondo in cui nazioni e grandi società multinazionali perseguono i loro interessi a scapito delle nazioni più deboli – specie laddove queste ultime non preservino una consistente idea di sé, della loro peculiarità, del loro ruolo – anche attraverso l’imposizione di immaginari e stili di vita mondialmente egemoni. Si pensi, a tal proposito, all’egemonia del mondo anglosassone, ma anche ad altre che vi aspirano. Ad esempio, si può anche osservare la Cina – nazione fortemente sovranizzata – ed il suo forte ascendente e probabile condizionamento sulle sue ben compatte e, possiamo dire, pressoché autonome comunità di emigrati nel mondo, dinnanzi a cui l’estensione facile e automatica della cittadinanza a costoro è suscettibile di porre interrogativi nelle nazioni di accoglienza. Insomma, non è difficile immaginare il ben possibile perseguimento degli interessi dei Paesi di provenienza, attraverso il voto, presso quelli di accoglienza da parte delle grandi comunità di immigrati, laddove ancora ancorati ai primi.
Allora, occorre anche chiedersi se sia possibile condividere la sovranità popolare, affrontare preoccupazioni ed avere aspirazioni e interessi comuni, tra cui il perseguimento di un comune interesse nazionale, anche con quegli stranieri che rimangono nei propri diversi suindicati orizzonti. Non ci si riferisce qui, naturalmente, a quelle persone di origine straniera che si sono ben inserite nel tessuto nazionale – vedasi i modelli sui quali insiste generalmente la stampa – ma ad altre tipologie di esse.
Per cui, il diritto di voto – conquista importante, spesso a caro prezzo – per la sovranità democratica che vi si esercita dev’essere curato e presidiato, richiedendo una certa prudenza e attenzione nella sua estensione. Pertanto, il criterio di acquisizione della relativa cittadinanza non può essere ridotto a mero consenso, convenienza o desiderio da parte di chiunque sia residente da qualche anno in Italia; questo anche – per i valori costituzionali summenzionati – nell’interesse della generalità di questi ultimi.
5) Prospettive e proposte: la cittadinanza per “ius culturae”.
Ci sarebbe da notare che le insistenze sulla cittadinanza automatica provengono, per lo più, da una parte di italiani, più che essere un’aspirazione generalmente espressa dagli stranieri, e ancor più da quelle forze politiche che, dopo aver gravemente fatto perdere agli italiani un importante patrimonio di diritti sociali ed economici, prova a rifarsi con quella di supposti “diritti” a buon mercato ed accettati dal grande Capitale. La propaganda di questi connazionali sullo ius soli o ius scholae propone esclusivamente esempi di stranieri fortemente inseriti nel tessuto nazionale (si noti bene: non tanto nel territorio ma nel tessuto, appunto, della nazione) Sulla concessione della cittadinanza a quest’ultima categoria di stranieri non vi è nulla da obiettare, appunto. Ma la domanda è se questa lettura della realtà si possa generalizzare, cioè ritenere che di regola “l’italianizzazione” – diciamo pure così – di uno straniero dipenda automaticamente solo da quanto tempo viva in Italia o dove abbia studiato. Qui, invece, si vuole guardare la realtà di cui si discute in uno spettro più ampio. Molti stranieri, anche se inseriti solo nelle loro comunità etniche, oggi per il solo fatto che vivono e lavorano sul territorio italiano sono considerati automaticamente integrati, ovvero se qui studiano e, in questo caso, non solo i figli di diplomatici stranieri nati in Italia, ma anche quelli di immigrati, laddove pure rimangano in Italia, specie se ancorati alle loro comunità nazionali, non è escluso che crescano come piccoli, pakistani, nigeriani, cingalesi, pur vivendo nel territorio italiano. Legittimo questo, ma il sentirsi effettivamente parte di una nazione non è costituito solo dal vivere nel suo territorio con in più la dicitura “cittadinanza italiana” indicata sulla carta d’identità.
Questo tipo di integrazione si riferisce piuttosto al collegamento tra l’individuo e il territorio in cui questi vive, lavora o va a scuola, anche se poi rimanga immerso nella dimensione culturale, sociale e etnica di provenienza che l’epoca dei social media facilita. Ne consegue, allora, se si aderisce a quanto sin qui argomentato, che sarebbe opportuna una valutazione più attenta sulla concessione della cittadinanza. Per questi motivi, non è condivisibile il recente quesito referendario che vorrebbe dimezzare i tempi per l’ottenimento della cittadinanza, a meno che non ne segua una normativa che preveda criteri di verifica di effettiva inclusione di tali aspiranti cittadini.
Preme precisare che qui non si crede affatto che occorra essere cittadini “per sangue” per sentirsi di appartenere a questa nostra Storia, nella consapevolezza che il concetto di nazione nella tradizione storica italiana, così come in altre quale quella francese – e contrariamente a quella tradizionalmente germanica – si basa storicamente sull’appartenenza di tipo culturale (non considerando l’eccezione rappresentata dalla terribile e vergognosa esperienza fascista delle leggi razziali, di importazione, tra l’altro, nazista). Per cui, non sono tanto importanti le proprie origini nazionali, il colore della pelle, altre caratteristiche fisiognomiche e così via, ma lo deve essere il sentirsi almeno in sintonia con il popolo italiano e i suoi principi fondamentali, avere familiarità con la sua lingua così come con la sua cultura, tra cui sarebbe da aggiungervi anche la conoscenza della nostra musica, cinema e trasmissioni radiotelevisive; rilevanti, queste, per la verifica dell’effettivo sentimento di appartenenza comune. Per fortuna, sono tante le persone di origine straniere così inserite.
Quindi, il criterio per la concessione della cittadinanza, anziché basarsi sul mero fatto dell’integrazione, ossia sul solo stabile inserimento nel territorio italiano, deve fondarsi su quello dell’inclusione, cioè l’effettivo inserimento, invece, nel tessuto nazionale.
Per il resto, la naturale e giustificabile aspirazione di quegli stranieri che desiderano e sentono – e non tanto solo perché vi abbiano mero interesse – di poter entrare a far parte della nostra comunità nazionale, dev’essere la benvenuta e fa molto piacere anche per l’idea di attrazione che la nostra nazione dimostrerebbe, così, di avere. A tal fine, è bene che siano promosse politiche per rendere effettive tali attrazione e percorsi di inclusione che favorirebbero l’acquisizione della cittadinanza italiana. Questo, senza pretendere che l’aspirante italiano abbandoni tutti i suoi legami di origine, ma che perlomeno viva, almeno in buona parte, in una dimensione effettivamente italiana.
In conclusione, un corretto criterio di accesso alla cittadinanza sarebbe quello definibile, quindi, di “ius culturae”, che terrebbe conto della diversità di condizione degli stranieri residenti in Italia decidendo caso per caso, ma senza alcun approccio etnico nella concessione del diritto di voto. Questo comporterebbe il sostenere un senso di responsabilità e di accoglienza effettiva da parte dei cittadini, salvaguardando la coesione sociale nonché l’efficace tutela dei diritti umani e civili, insieme all’indipendenza nazionale. Questo, perché occorre non perdere di vista che tale status ha natura prettamente politica, prima che sociale, in ossequio alla nostra Storia migliore, con il suo portato di sviluppo e diritti che tanti stranieri attrae e tutela.