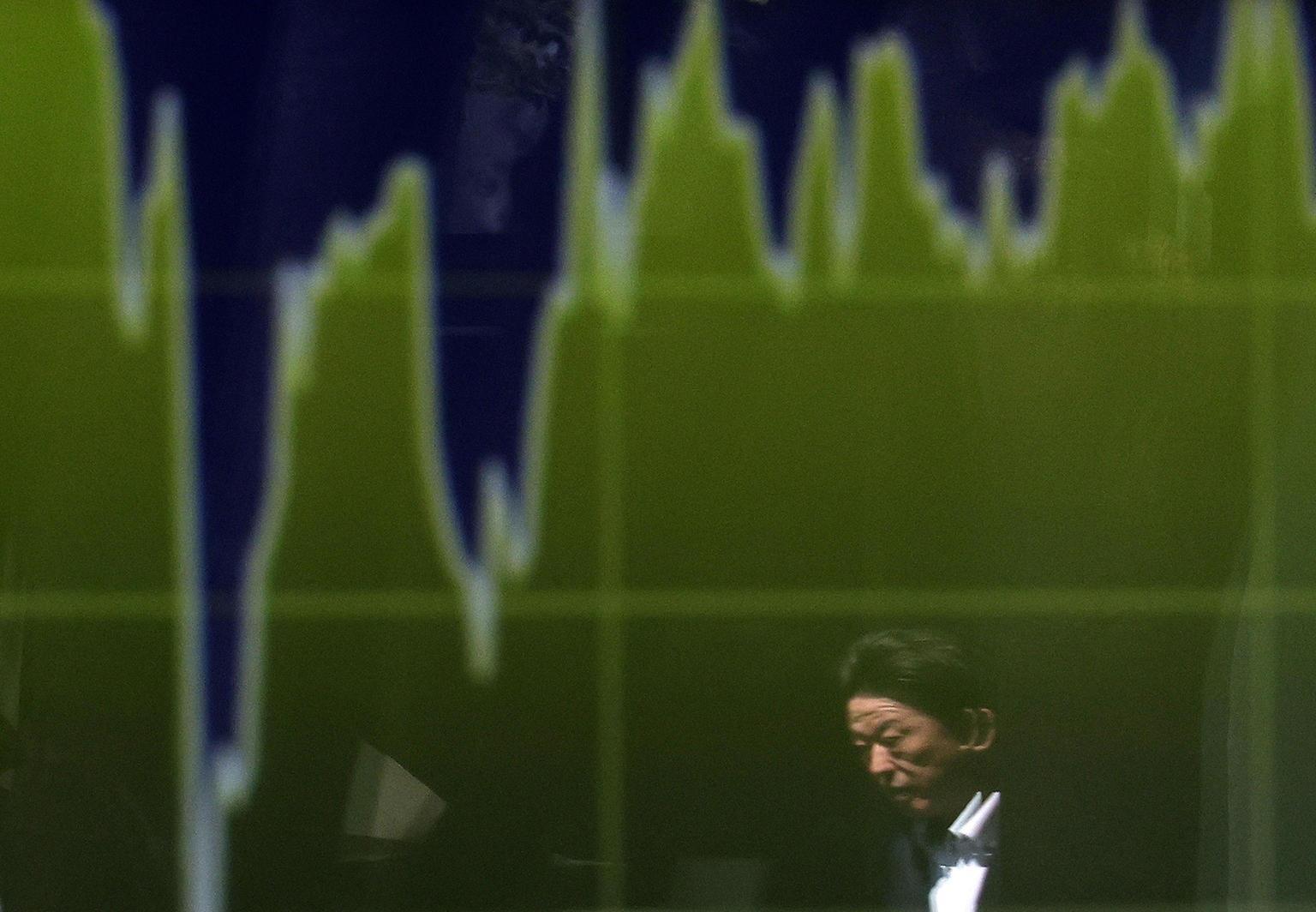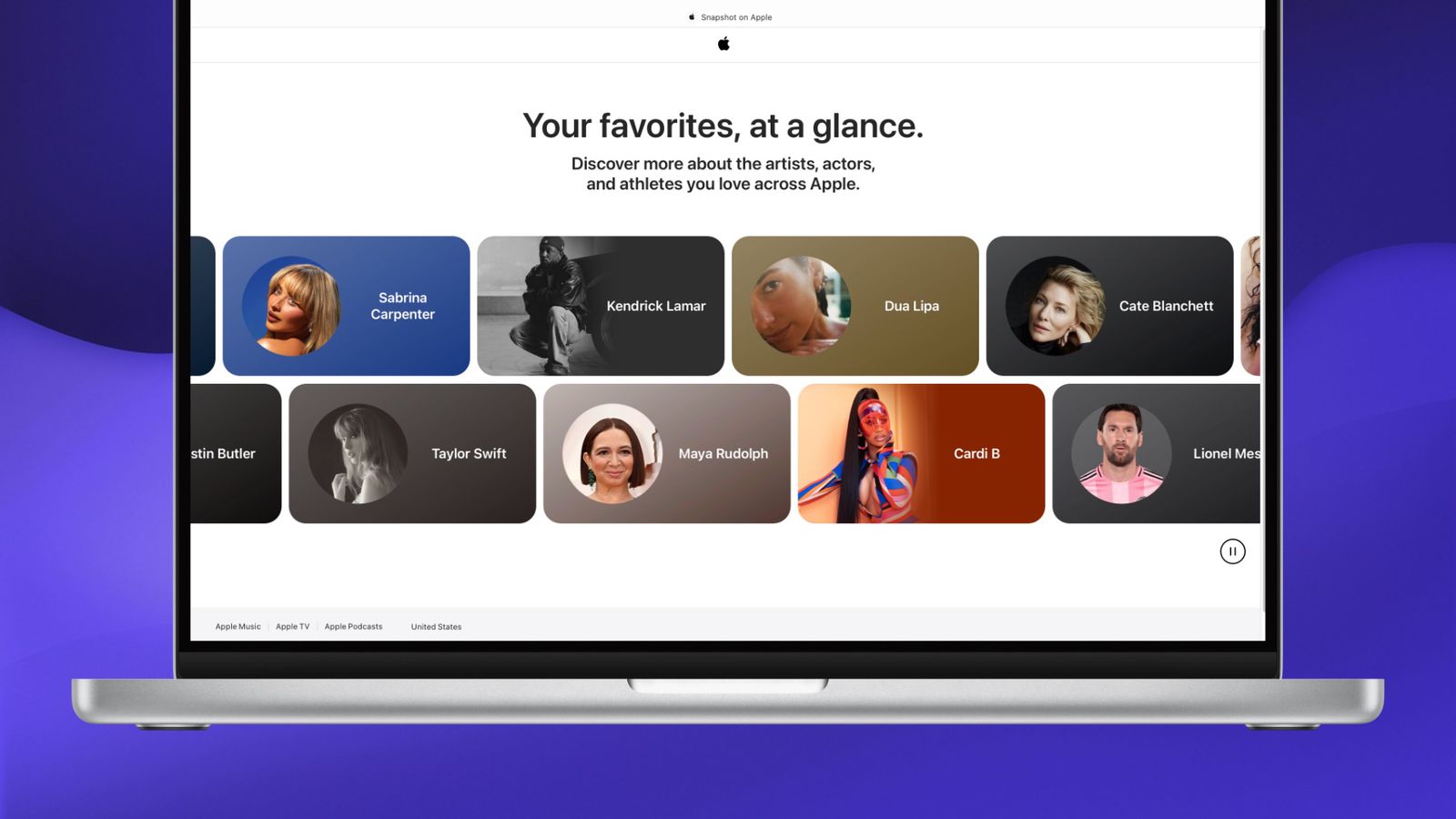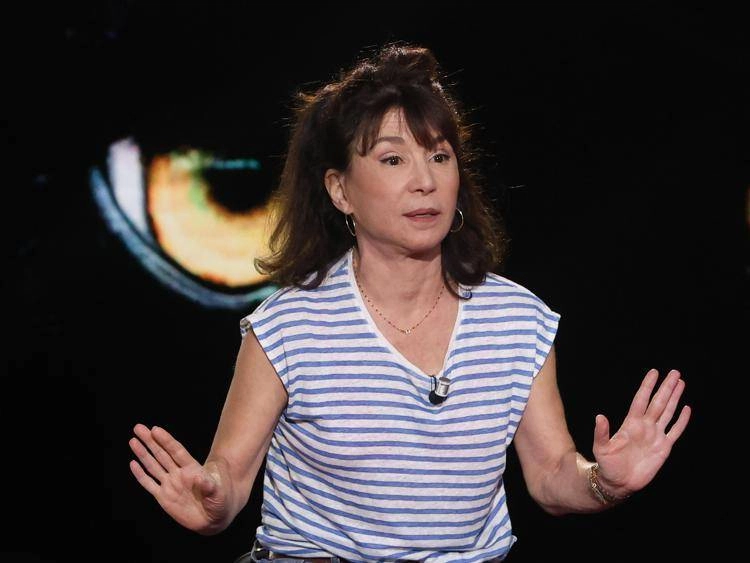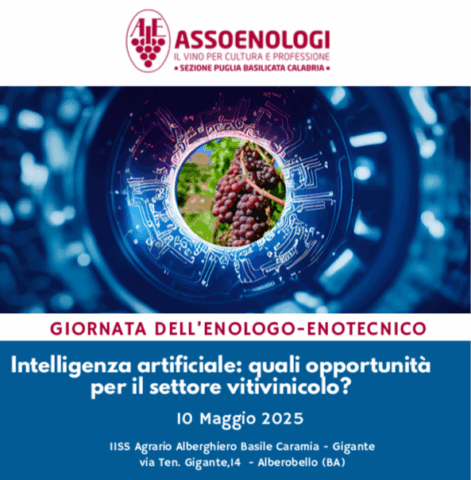La corsa per estrarre minerali dagli oceani era già iniziata. Con Trump ora è diventata spietata.
Oggi, guardando ai fondali oceanici come a giacimenti da sfruttare, anziché come a ecosistemi da proteggere, stiamo commettendo un errore che rischiamo di pagare molto alto. Trump, infatti, ha preso una decisione tra le più pericolose per il futuro del nostro pianeta: ha dato il via libera all’estrazione di minerali dai fondali oceanici in acque internazionali, bypassando l’Onu. E no, non è una cosa che poteva fare. L'articolo La corsa per estrarre minerali dagli oceani era già iniziata. Con Trump ora è diventata spietata. proviene da THE VISION.

Fin dagli albori della civiltà umana, l’acqua ha rappresentato molto più di una risorsa a cui la nostra sopravvivenza era indissolubilmente legata: è stata simbolo di origine, trasformazione, mistero, vita e morte. Nelle culture di tutto il mondo, i fiumi, i laghi, i mari e gli oceani sono stati considerati portali tra i mondi, specchi che riflettono non solo il volto della natura, ma quello stesso dell’umanità. Nel mito di Narciso, è proprio l’acqua, limpida e immobile, a mostrare al giovane uomo la sua immagine, condannandolo a innamorarsi di sé fino alla distruzione. L’acqua non giudica: si limita a restituire ciò che vede, a opporre una forza uguale e contraria, oppure a lasciarci sprofondare nei suoi abissi, accogliendoci in un abbraccio che può diventare letale.

Oggi, guardando ai fondali oceanici come a giacimenti da sfruttare, anziché come a ecosistemi da proteggere, stiamo ripetendo lo stesso gesto fatale di Narciso: chini su uno specchio che riflette il nostro desiderio, sempre più simile a una vera e propria brama incontrollabile, la nostra incapacità di vedere oltre l’immediato rischia di farci precipitare nella nostra stessa rovina. L’oceano, silenziosamente, ci mostra cosa siamo diventati, e il nostro fallimento rischia di aprirsi tutto davanti ai nostri occhi, come un orizzonte sconfinato da cui è impossibile nascondersi, spostare lo sguardo. Ma non è ancora detta l’ultima parola, e tutti insieme, possiamo – dobbiamo – fare la differenza, perché oggi i nostri oceani sono più in pericolo che mai.
Il 24 aprile 2025, Trump ha preso una decisione che potrebbe entrare nella storia non solo come una delle più controverse del suo secondo mandato, ma come una delle più pericolose per il futuro del nostro pianeta, peraltro come se non fosse già abbastanza grave l’uscita degli USA dagli Accordi di Parigi sul clima. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti dato il via libera all’estrazione di minerali dai fondali oceanici in acque internazionali, bypassando l’Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA) delle Nazioni Unite – l’organismo preposto alla regolamentazione di questo tipo di attività.

Basandosi su una legge americana del 1980, il Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, Trump ha deciso che, siccome gli Stati Uniti non hanno mai ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), possono fare quello che vogliono, autorizzando società private a iniziare a trivellare le profondità oceaniche alla ricerca di nichel, cobalto e manganese, tre metalli rari essenziali per l’industria tecnologica e la difesa. Nonostante l’ONU avesse recentemente imposto una moratoria de facto su queste operazioni (anche grazie all’impegno indefesso di diversi attivisti e attiviste, come le Ong SeaLegacy e Deep Sea Conservation Coalition), riconoscendo il rischio immenso che rappresentano per l’ecosistema marino, gli Stati Uniti hanno deciso di ignorarla, per guadagnarci e ovviamente “per ridurre la dipendenza dalla Cina per le forniture strategiche” come si legge sul comunicato stampa della Casa Bianca. La guerra commerciale tra USA e Cina d’altronde è un fatto, ma non ci sono motivazioni abbastanza serie per giustificare un’azione del genere, alla cui base sta la solita logica estrattivista miope e a breve termine, che sacrifica ancora una volta il bene collettivo (non solo umano), sull’altare degli interessi privati.
La corsa ai minerali critici è già iniziata da tempo. La transizione tecnologica – dalle auto elettriche, passando per le batterie fino alle infrastrutture militari – ha reso elementi come il cobalto e il nichel preziosissimi. Finora, gran parte delle riserve di questi metalli venivano estratte in condizioni eticamente discutibili in Paesi come la Repubblica Democratica del Congo. Ma ora gli occhi si sono spostati verso il fondo dell’oceano, un ambiente estremamente fragile, remoto e sconosciuto (perché non è mai convenuto a nessuno studiarlo, e dunque solo pochi ricercatori autonomi e visionari gli rivolgevano l’attenzione). Ma i fondali profondi – stiamo parlando di una profondità che si aggira intorno ai 2500 metri – sono una sorta di archivio vivente della storia naturale: ospitano ecosistemi unici, basati su forme di vita che esistono da milioni di anni e che non non sono presenti in nessun altro luogo. Creature che si sono evolute senza mai vedere la luce del sole, comunità microbiche che giocano ruoli essenziali nei cicli biogeochimici del pianeta. Sono, letteralmente, una delle culle della vita sulla Terra. Distruggere questi ambienti per estrarre noduli polimetallici – ovvero agglomerati di metalli preziosi – significa cancellare interi ecosistemi prima ancora di averli studiati, senza sapere che effetti tutto questo potrebbe avere sugli equilibri chimici del pianeta. Significa compromettere cicli vitali come quello del carbonio, mettere a rischio la regolazione climatica globale e aprire un nuovo fronte di devastazione ecologica da cui, questa volta, potremmo non riprenderci.

Come se non bastasse, la decisione della Casa Bianca sembra essere macchiata da un notevole conflitto di interessi. Howard Lutnick, attuale Segretario al Commercio scelto da Trump, è stato CEO e presidente di Cantor Fitzgerald, il principale istituto di credito che sostiene la TMC (The Metals Company), una delle aziende candidate a guidare l’estrazione sui fondali. Cantor Fitzgerald è il maggiore finanziatore di TMC, e TMC è una delle poche aziende già pronte a operare non appena la normativa americana ha tolto il freno (dopo aver rischiato la bancarotta quando appunto sembrava che gli attivisti fossero riusciti a fermare questa mira predatoria). Ma oltre ai legami diretti di Lutnick, membro chiave del governo, con chi beneficerà economicamente di questa decisione, si sta anche usando la leva dell’interesse nazionale per legittimare un’operazione che di “nazionale” ha ben poco, e che invece arricchirà principalmente attori privati. L’amministrazione Trump sta sostanzialmente privatizzando il fondo degli oceani, calpestando il diritto internazionale. E no, non è una cosa che può fare.
La mossa statunitense rischia infatti di avere conseguenze devastanti anche sul piano della diplomazia internazionale – o quantomeno sarebbe giusto li avesse, perché è assurdo sopportare prepotenze simili. Fino a oggi, l’alto mare – e in particolare i fondali oceanici – erano considerati patrimonio comune dell’umanità, secondo il principio sancito proprio dalla Convenzione UNCLOS: nessun Paese ha il diritto esclusivo di sfruttare queste risorse senza il consenso della comunità internazionale. Trump, invece, ha inaugurato un nuovo modus operandi al grido di “Chi può trivellare, trivelli”. E questo rischia di innescare una nuova corsa agli armamenti, una corsa tecnologica e industriale dove chi ha più soldi e tecnologie si approprierà delle risorse comuni. Cina, Russia e altri attori globali potrebbero ora sentirsi legittimati a ignorare i trattati internazionali e avviare loro stessi operazioni minerarie, magari ancora più impattanti. La fragile governance degli oceani, costruita con decenni di negoziati, potrebbe sgretolarsi in pochi anni. E anche tutto questo appare come riflesso di un sintomo più ampio: il declino del rispetto e della fiducia nelle istituzioni multilaterali, l’erosione del diritto internazionale, il trionfo della logica autarchica e individualista ognuno per sé. Peccato che la vita sul nostro pianeta non abbia mai funzionato così: siamo infatti tutti interconnessi.

Gli scienziati sono stati molto chiari: le conseguenze dell’estrazione mineraria sottomarina potrebbero essere devastanti e irreversibili (quantomeno rispetto ai cicli della nostra breve vita). A differenza delle miniere terrestri, dove esiste una, seppur minima, possibilità di ripristino ambientale, il fondo oceanico è estremamente lento nel rigenerarsi, lo strato di detriti che lo riveste si forma in milioni di anni – così come i noduli polimetallici che si vorrebbero prelevare. Alcuni habitat potrebbero richiedere migliaia (se non milioni) di anni per riprendersi, sempre che ciò sia possibile. Stiamo infatti parlando di enormi ruspe sottomarine che raschieranno il fondo marino, sollevando nubi di sedimenti che possono soffocare la vita per chilometri; di rilascio di metalli pesanti, che potrebbero contaminare la catena alimentare marina, già pesantemente vittima del nostro inquinamento; di una devastazione capillare e invisibile, che si sommerebbe a quella già in corso a causa dell’inquinamento, del riscaldamento globale e dell’acidificazione degli oceani, che già sembrano impattare sulla fondamentale corrente del golfo. Un recente studio pubblicato su Nature ha evidenziato che anche operazioni pilota di estrazione hanno causato danni persistenti ancora dopo decenni. Non esiste, insomma, a oggi e forse a mai, nessun modo sicuro di estrarre minerali dal fondo marino senza causare impatti devastanti.
Ma c’è un’ulteriore assurdità in questa vicenda: molti dei minerali che si vogliono estrarre sono fondamentali per la “transizione verde”: batterie per auto elettriche, pannelli solari, turbine eoliche. Senza nichel, cobalto e manganese, è infatti difficile pensare di decarbonizzare il nostro sistema energetico. Ovviamente un’autentica transizione sostenibile non può basarsi sulla semplice sostituzione tecnologica, ma deve implicare un ripensamento radicale dei modelli di produzione e consumo, di tutti i nostri paradigmi. Estrarre nuovi minerali per continuare a produrre, consumare e buttare non è una transizione, è la prosecuzione dello stesso modello distruttivo, solo con un sottile strato di retorica verde sopra. Se non troviamo il coraggio e il modo di rallentare, ridurre e riparare continueremo a correre verso il collasso, più o meno rapido.

La decisione di Trump è il sintomo di un fallimento culturale e politico profondo. Stiamo riducendo anche il fondo degli oceani, il luogo più incontaminato e irraggiungibile del mondo (per certi aspetti più ancora dello spazio), nell’ennesimo giacimento da sfruttare. Non riusciamo più a vedere nella natura qualcosa che non sia un mero oggetto, utile solo in funzione dei nostri bisogni immediati da soddisfare, senza alcun pensiero, senza alcun amore, senza alcun rispetto e comprensione profonda. E rischiamo di pagarne un prezzo molto salato. Perché se c’è una cosa che proprio gli abissi ci insegnano è che tutto è interconnesso: la vita sulla superficie dipende da ciò che accade a migliaia di metri sotto di noi. Ferire l’oceano significa ferire noi stessi. È una corsa contro il tempo, e c’è il rischio che quando ce ne renderemo conto, sarà troppo tardi.
L'articolo La corsa per estrarre minerali dagli oceani era già iniziata. Con Trump ora è diventata spietata. proviene da THE VISION.