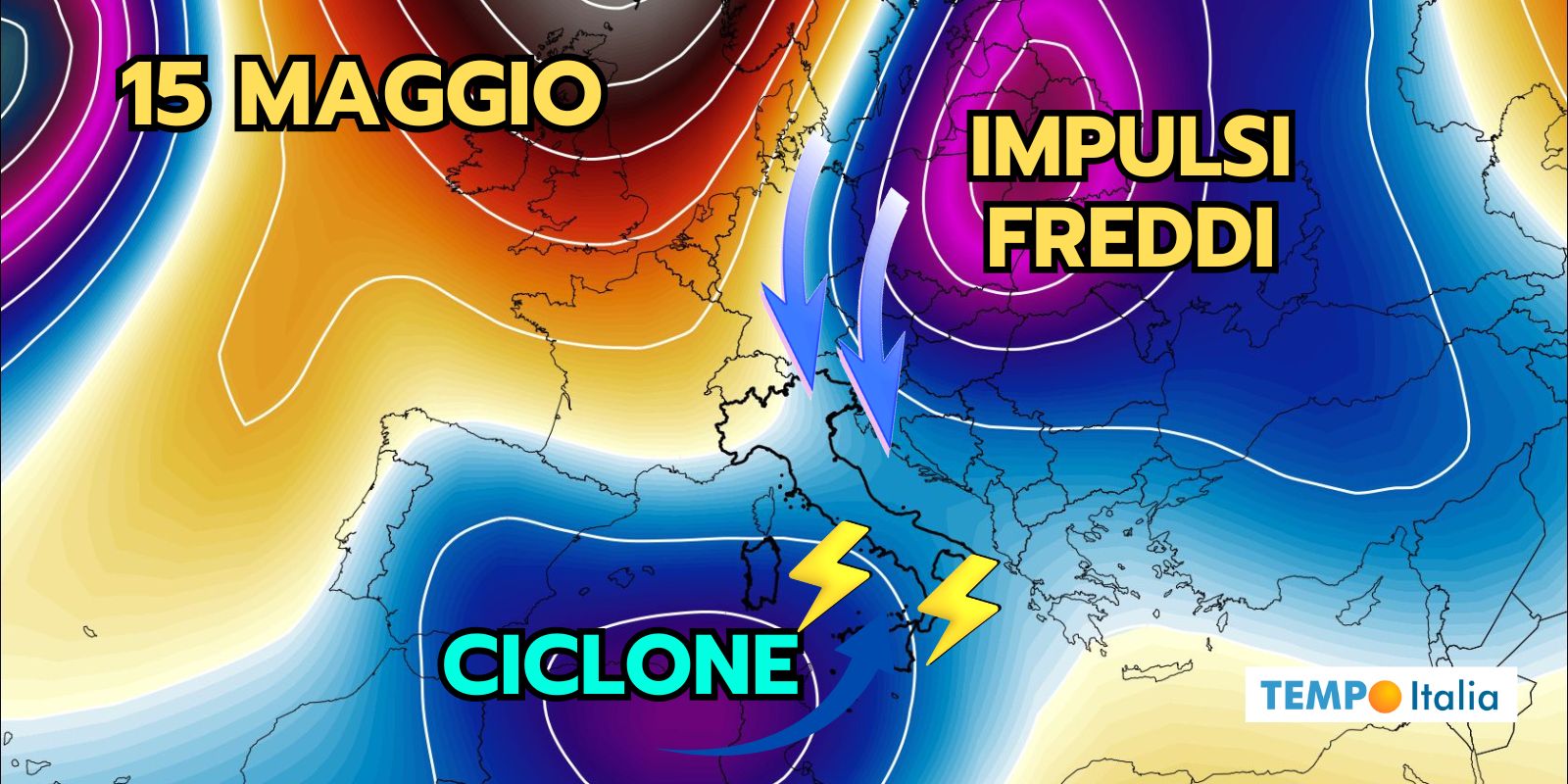LA CITTÀ PROIBITA di Gabriele Mainetti (2025) o la ragazza del sogno
La città proibita (2025) di Gabriele Mainetti si apre con un dettaglio. Della protagonista Mei, agli inizi della storia ancora bambina, Mainetti ci mostra prima di tutto il pugno chiuso, […]

La città proibita (2025) di Gabriele Mainetti si apre con un dettaglio. Della protagonista Mei, agli inizi della storia ancora bambina, Mainetti ci mostra prima di tutto il pugno chiuso, mentre l’inquadratura si allarga a guadagnare al nostro sguardo la totale di un piccolo giardino cinese, ordinato e domestico. Ecco allora lei e la sorella Yun, che si allenano alle arti marziali insieme al padre. Si allenano alla lotta, loro, perché nonostante il luogo elegante e pulito, e nonostante il florido paesaggio collinare che lo avvolge, esotico e lontano nei suoi tratti da sogno, nonostante l’utopia, una legge iniqua pende sui loro destini. Vigeva, ed era il 1995, la Legge del Figlio unico, che era stata introdotta nel 1979 da Deng Xiaoping per controllare le nascite: e loro, Mei e Yun, erano due sorelle, perché l’amore era stato, ci dice il film, più grande della legge. Per questo Mainetti ci introduce ad un gentile e rigoroso esercizio marziale: in un’utopia segnata dall’ingiustizia, ci si deve preparare alla lotta. Il ritorno al sogno chiede sempre la sfida.
Poi finisce la prima sequenza, e la luce al neon che connota il nuovo ambiente chiuso (uno scantinato, un non-luogo di prostituzione) è faticosa da sopportare, sgradevole nei suoi toni apertamente distopici. Quelle colline lussureggianti, quel nido d’amore, quel “lontano”, d’un balzo di montaggio si erano resi inarrivabili e “stranieri”. Si intuisce perché: la sorella di Mei era stata scoperta, era finita in un mercato nero, e andava salvata a ogni costo. La lotta, quella lotta iniziale, preparata nella falsa quiete, doveva essere, a quel punto, messa al servizio della giustizia. Il Cinema, sembra dirci subito Mainetti, interviene lì dove il degrado dell’umano necessita di uno sguardo nuovo, che in qualche modo lo salvi. Davanti alla concretezza oscena del mercato della donna, degli sfruttati, degli emarginati, il Cinema può romanzare il conflitto per la giustizia. Può stare, diciamo così, dalla loro parte. Intanto Mei (vent’anni dopo) era diventata una giovane donna, tanto bella quanto letale (Yaxi Liu). E quindi si trovava il compito, per queste due ore e mezza di film, di salvare la realtà.
Sì, perché la sua lotta (ritrovare Yun) ci riguarda, e da vicino. E non solo per il fatto che, di questa rabbia nata dall’ingiustizia del reale, anche noi dovremmo imparare a fare qualcosa di risollevante, e catartico. Mei, in sequenze magistrali di combattimento coordinate da Liang Yang, ne fa letteralmente Cinema: nei suoi calci, nei suoi salti, nei suoi pugni sta rappresa tutta la rabbia di quella ingiustizia originaria, e la speranza di un equilibrio da ristabilire anche a costo del sangue. Dietro quella rabbia messa in scena sta la furia di Bruce Lee, la vendetta di Beatrix Kiddo (Kill Bill), la violenza di John Wick, perché la rabbia, e il pugno, e il calcio, siano prima di tutto artefatto di abilità, e onorino un cinema della tecnica, fatto di movimento di corpi, e di sguardi, e di camera.
Ma soprattutto perché quella lotta (germogliata in una ferita antica, in un luogo ameno che è ben presente in qualche nostro anfratto profondo, e non solo in una Cina sognata) ricade nel teatro “realissimo” della nostra decadente condizione occidentale, sempre più “globale”, e comune. E quindi ci può e ci deve interrogare di fronte, nella sua tensione ultima. Mainetti lo intuisce benissimo, e ce lo dice con una straordinaria trovata scenica, che sembra un gioco di prestigio, alla fine della prima sequenza di combattimento: iniziata nello scantinato del postribolo, e poi condotta in climax ascendente nell’ambito rosseggiante di un ristorante della malavita cinese, la scena si concluderà, varcata la soglia del locale (dopo straordinarie acrobazie visive in fighting-movie), nelle strade di Roma. La nostra Roma, anno 2025: precisamente, questa città proibita, è situata a Termini.
Ed è la Roma di un romanzo, a metà tra i resti di una grandezza passata (la Roma dei Fori, rigorosamente notturna) di una borghesia in disfacimento (Lorena, Sabrina Ferilli), di un retroterra passatista e ignorante (Annibale, Marco Giallini), di una giovinezza frustrata, che fatica a trovare il suo posto, e il suo destino nel mondo (il co-protagonista Marcello, interpretato da Enrico Borello), imbavagliata dai legacci di un contesto soffocato, e “senza visione”: Marcello siamo proprio noi. Ed è soprattutto la Roma del brulicante nuovo, di un crogiolo di culture straniere, di poveri, di sfruttati, di ultimi. È questo il teatro di una lotta che si fa comune, mai davvero (soltanto) individuale, e che reclama giustizia per tutti (Yun trovata, salvata, o meno). Roma di invisibili, di ampie case abbandonate, di ristoranti casalinghi, di mercati popolari; Roma ombrosa di casolari, di fabbriche, di fumi, di cadaveri, di sfruttati, di sfruttatori, di ferite aperte, sanguinanti. La lotta deve essere portata lì, dove il tessuto della vita è più debole e il dolore esce allo scoperto, e nemmeno può comunicarsi: Mei e Marcello parlano lingue diverse; eppure entrambi si trovano alleati in un salto contro il male che li attanaglia. E Mainetti guarda al cinema come al racconto di questo salto acrobatico e marziale. Nell’immagine, infatti, la loro lingua coincide, e si fa amicizia, e amore.
È per mezzo dell’immagine che il cinema opera nel mondo. La Città proibita ci mostra allora un cinema del nascosto che appare e deflagra nel combattimento del giusto contro l’ingiusto. È un cinema che sente come autentico il messaggio di Tarantino, perché non vuole che la tragedia della storia (e della realtà) trionfi contro gli innocenti. Un cinema che si schiera contro le iniquità degli esseri egoisti e la tirannia degli uomini malvagi. Certo infatti che ci sono i cattivi, i ruffiani, gli scagnozzi, i lenoni, i mafiosi. Certo che c’è la prepotenza ferita dello zio Annibale; che c’è Mr. Wang (Chunyu Shanshan); che non ci sono più i Padri (quello di Marcello, interpretato da Zingaretti, a simbolo di tutti gli altri). Ma l’immagine, il Cinema, accoglie anche loro, perché accoglie, come ci ha insegnato a fare Sergio Leone, il romanzo della realtà. E quindi non li può né li vuole condannare: li vede, li comprende, forse li perdona; comunque li accoglie nell’immagine, perché in fondo solidarizza anche con loro. Non importa nemmeno che sia “tutto finto” (Annibale, romanissimo, accuserà Mr. Wang, cinesissimo, proprio di questo, “Tutto finto”). Per Mei e per Marcello, (e quindi per Mainetti, e per noi) si trattava di entrare esattamente lì, nel regno in cui “tutto è finto”, per accettare le sue regole, e combattervi. Entrare dentro l’immagine, dove “tutto è finto”, per ricercare l’origine, e guarire, combattendo.
Una domanda verticale si insinua però silenziosa tra gli anfratti di questa rappresentazione perfetta, dalla regia intensa, dal ritmo elegante e aggressivo. Domanda antica, forse archetipica: è possibile addentrarsi, come Mei, lì dove è “tutto finto” (nel Cinema) per distillarne un bene, e un vero, che sia davvero bene, e vero, senza che quella finzione contagi, e comprometta, quello stesso anelito? Può il cinema (questo cinema) salvare davvero la realtà? Tarantino, appunto, o Spielberg, o Coppola risponderebbero, probabilmente, di sì: Dracula, in Bram Stoker’s Dracula (1992), veniva salvato eternamente dall’amore di Mina, cioè nell’Immagine, dal Cinema. Lì, in Transilvania, il Cinema salvava la realtà. Questo è sicuro. Sarebbe accaduto anche a Hollywood, quando nel 2019 Cliff Booth (Brad Pitt) salvava Sharon Tate dagli eventi tragicamente reali del 1969. Il Cinema salvava la Storia, mentre la “realtà” perdeva i suoi contorni archiviabili. E lo faceva, come in Mainetti, in grande stile. Ma non rischia forse un Cinema dell’artefatto, comunque inteso, di cristallizzare nel sogno ogni anelito all’altrove (all’origine, al bene perduto, alla terra promessa…)? Non rischia – mentre ci educa a guardare con splendore e gentilezza il sorriso dell’oppresso, la radiosità di una donna che combatte, la delusione umanissima di un “cattivo” – di farci ancora spettatori sognanti di un’utopia inesorabilmente “altra”, e quindi, nonostante Termini, mai davvero qui, con noi, dentro o fuori le immagini?
Perché gli oppressi continuano ad essere oppressi, quasi sempre accolti più in immagine che in realtà, o fatti immagine travisabile delle nostre paure del diverso, che come Mei parla una lingua incomprensibile; mentre noi invece moriamo, con il nostro mondo senza padri, in una finzione che, a differenza del film di Mainetti, una possibile salvezza nemmeno sa pensarla, o sognarla.