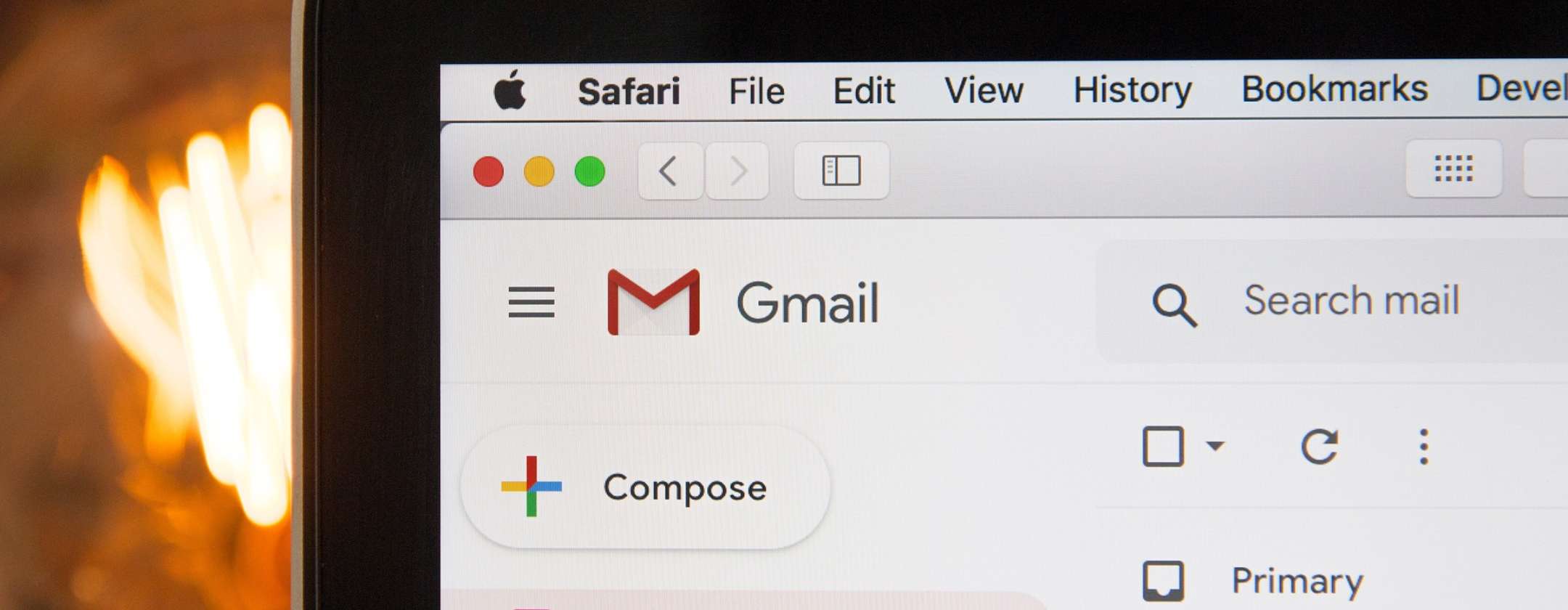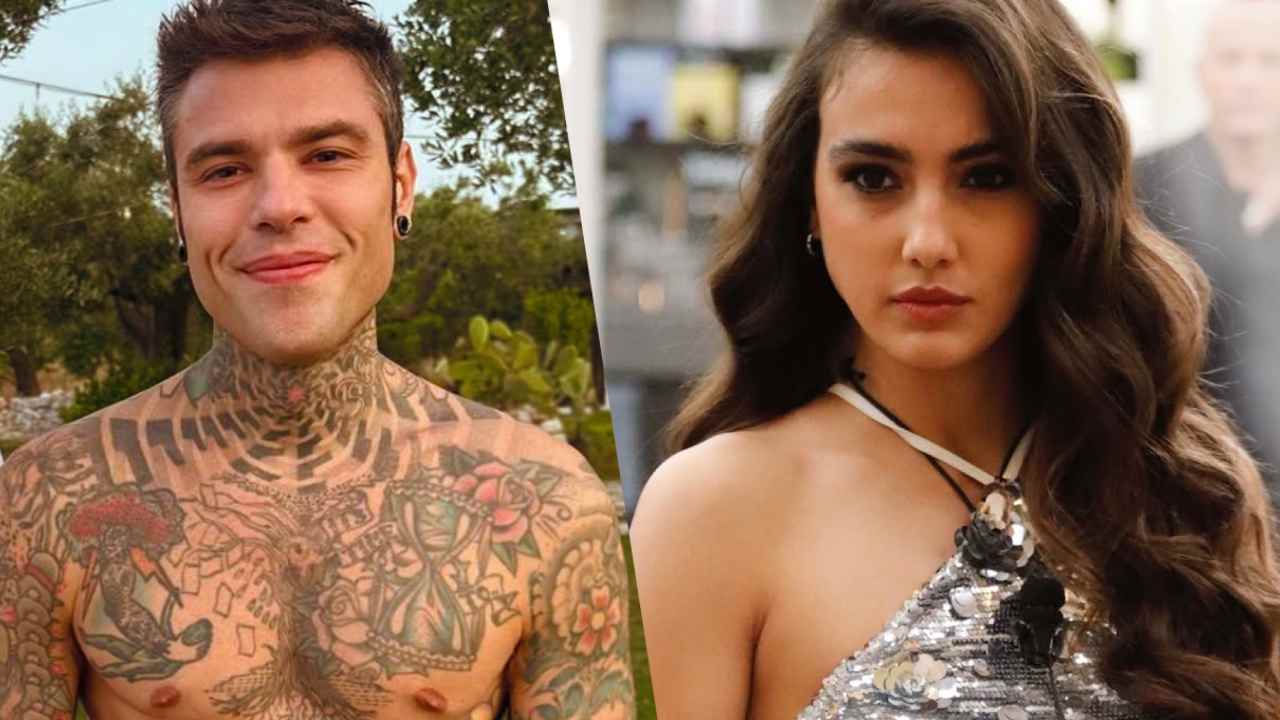La Chiesa è a un bivio tra essere contemporanea e tornare indietro. Ma è politico, non spirituale.
Il bivio è evidente. La Chiesa può accettare di vivere dentro la contemporaneità, cercando di essere più aperta, oppure tornare indietro, verso una rassicurante idea di autorità che però ha smesso da tempo di parlare al mondo. E sarà una scelta, prima che spirituale, profondamente politica. Una decisione su cosa il cattolicesimo intende essere, oggi: perché domani probabilmente non avrà più questa possibilità di scelta. L'articolo La Chiesa è a un bivio tra essere contemporanea e tornare indietro. Ma è politico, non spirituale. proviene da THE VISION.

È morto Papa Francesco. Il primo papa latinoamericano della storia, il primo gesuita a salire al soglio pontificio, e soprattutto il primo pontefice in oltre mezzo secolo a incarnare – almeno nelle intenzioni – una visione meno conservatrice del ruolo della Chiesa nel mondo. Ma il bilancio del suo pontificato, lungo quasi dodici anni, rischia di essere molto più controverso di quanto una parte dell’opinione pubblica vorrà ricordare.
Jorge Mario Bergoglio aveva scelto il nome di Francesco, un santo evocativo, fondamentale per il cattolicesimo italiano ma proprio per questo scomodo per i precetti che incarnava: rimandava a povertà, dialogo interreligioso, rifiuto del potere e disobbedienza evangelica. Non è un caso che nei secoli trascorsi dalla morte di San Francesco nessun pontefice avesse scelto quel nome. Nonostante nel 2013 l’elezione di Bergoglio sia stata vista dai vaticanisti di mezzo mondo come una scelta moderata, immagine di un conservatorismo di dottrina e progressista solo su alcuni temi sociali, la rottura con i fasti di Benedetto XVI e con i silenzi osceni che la Chiesa aveva conosciuto con Giovanni Paolo II fecero capire che un’altra via era stata presa. Eppure questa rottura, pur suggerita nei gesti, non si è mai pienamente compiuta. Il suo pontificato si chiude oggi come uno dei più ambigui degli ultimi decenni: Francesco ha aperto porte senza mai davvero spalancarle, ha sussurrato messaggi nuovi senza però codificarli nel catechismo cattolico, quasi volesse rendere il suo un pontificato di passaggio e non di effettiva rivoluzione.

Fin dal suo primo viaggio apostolico a Lampedusa, Francesco ha cercato di fondare il proprio magistero su un’idea radicale di accoglienza e giustizia sociale. Celebrare messa su un altare a forma di barca e gettare una corona di fiori in mare in memoria dei migranti morti nel Mediterraneo non fu soltanto un gesto simbolico, ma un atto politico esplicito, una sfida aperta alla retorica sovranista e ai nazionalismi religiosi che proprio sull’identità cristiana hanno costruito buona parte della loro narrazione. La sua lettura della contemporaneità si è poi estesa al campo ambientale: l’enciclica Laudato si’, pubblicata nel 2015, ha portato il cambiamento climatico per la prima volta al centro della dottrina sociale della Chiesa, definendo il degrado ambientale come una responsabilità collettiva e una colpa morale. Per queste sue posizioni, e forse per scarsità di concorrenza, papa Francesco è stato ritenuto, a tratti, una delle figure progressiste più riconoscibili nel panorama globale.
Il decennio del suo pontificato ha coinciso con momenti geopolitici cruciali: l’ascesa di Donald Trump e delle destre sovraniste, la pandemia da Covid-19, le guerre in Ucraina e in Palestina, l’accelerazione delle crisi climatiche, la crescente frammentazione sociale ed economica. Sul piano delle relazioni internazionali, Francesco ha cercato – con alterne fortune – di ritagliarsi il ruolo di mediatore. Storico fu l’intervento tra Cuba e Stati Uniti, che portò al disgelo del 2014, poi smantellato da Trump. Ma l’aspirazione a essere un papa ecumenico si è scontrata con una realtà sempre più frammentata, in cui l’autorità morale del Vaticano ha perso lo smalto della sua influenza tradizionale.

Tra le posizioni più controverse di Francesco c’è stata quella sulla guerra in Ucraina. Ostinatamente neutralista, ha evitato quasi sempre di nominare Putin, preferendo un linguaggio vago sulla pace. Nel marzo 2024 ha parlato di “bandiera bianca”, suscitando dure reazioni da Kiev e lasciando spazio all’accusa di una ambigua equidistanza. Più netta è stata invece la sua voce sul conflitto in Palestina: nel libro La speranza non delude mai, scritto poco prima di morire, ha parlato di Gaza come possibile teatro di genocidio, citando esperti e invitando a indagare con attenzione. Un’affermazione forte, considerando la timidezza degli altri leader occidentali. Forse anche in questo, come in altri gesti, ha pesato il nome che aveva scelto: san Francesco fu l’unico nel periodo del fondamentalismo cattolico delle crociate a dialogare in Terra Santa con i musulmani del sultano al-Malik al-Kamil.
Ma è in particolare sui temi interni alla Chiesa che le riforme annunciate si sono spesso arenate. Il sinodo sull’Amazzonia, che doveva rappresentare una svolta sull’ordinazione dei viri probati (uomini sposati di comprovata fede) è stato congelato. Le aperture verso le persone LGBTQ+ sono state forse il simbolo più evidente dell’ambiguità riformatrice di Francesco. La celebre frase “Chi sono io per giudicare?”, pronunciata nel 2013 durante il volo di ritorno dal Brasile – estrapolata dal contesto specifico in cui si parlava della possibile omosessualità di Monsignor Battista Ricca – venne accolta come simbolo di un’apertura mai arrivata davvero ma che segnava una rivoluzione lessicale dentro una Chiesa abituata a condanne e silenzi. A quelle parole seguirono anni di dichiarazioni altalenanti: dai moniti contro la cosiddetta ideologia gender, additata come una delle principali minacce alla famiglia cristiana, all’invito rivolto ai genitori di bambini omosessuali a portarli da uno psicologo. Fino alla frase più offensiva, riportata da fonti vaticane nel maggio 2024, secondo cui nei seminari “c’è già troppa frociaggine”.

Le benedizioni delle coppie omosessuali, ammesse nel 2023 ma prontamente ridimensionate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, si sono rivelate concessioni più simboliche che reali, emblema di una resistenza molto rigida all’interno della Curia e di una volontà del pontefice forse non così solida su questo genere di aperture. Tuttavia, in un confronto con i suoi due predecessori, resta difficile ignorare il cambio di passo. Giovanni Paolo II e Benedetto XVI non si fecero scrupolo a presentare l’omosessualità come intrinsecamente disordinata e, nel pieno dell’epidemia da HIV-AIDS, cavalcarono il concetto di peste gay, con responsabilità umanitarie importanti soprattutto in Africa in cui la loro crociata contro i contraccettivi permise il dilagare del virus.
Anche sul fronte femminile il pontificato di Francesco ha mostrato aperture significative ma mai strutturali. È stato il primo a nominare donne in ruoli di potere all’interno della Curia romana, da Raffaella Petrini, segretaria governatrice dello Stato Vaticano, a suor Simona Brambilla, prima donna alla guida di un dicastero. Ha concesso ai laici e alle donne il diritto di voto nei Sinodi e istituito due commissioni per studiare l’accesso femminile al diaconato. Ma questi modesti tentativi hanno portato a un nulla di fatto e l’ordinazione sacerdotale femminile è sempre rimasta fuori discussione. Anche la sua lotta contro la pedofilia clericale è stata più coraggiosa dei suoi predecessori – ci voleva davvero molto poco – ma le indagini sono state delegate alle singole conferenze episcopali nazionali, con risultati ovviamente disomogenei. In Italia, per esempio, la richiesta di una commissione indipendente è rimasta inevasa. Il papa ha espresso parole durissime contro chi ha coperto gli abusi, ma non ha mai imposto un netto cambio di passo.

Attribuire l’incompiutezza delle riforme di Francesco soltanto alla sua mancanza di audacia sarebbe però una lettura parziale. Il suo pontificato si è mosso controcorrente in un contesto ecclesiale e politico fortemente ostile. La sua scelta di opporsi apertamente alle derive delle destre radicali – in un’epoca in cui altri pontefici avrebbero potuto trarne consenso – lo ha esposto a una reazione feroce, interna ed esterna. Le critiche non sono mancate nemmeno dai vertici della Chiesa: la presenza ingombrante di Benedetto XVI, rimasto in vita per gran parte del pontificato di Francesco e mai completamente silente, ha rappresentato una costante ombra. Le sue riserve, spesso manifestate attraverso scritti e interviste, hanno contribuito a rafforzare le posizioni dei settori più conservatori, che non hanno mai riconosciuto pienamente la legittimità di Bergoglio. In alcuni ambienti, si è perfino ventilata l’idea che la sua elezione fosse frutto di un colpo di mano, una “deviazione” rispetto alla Chiesa autentica. Le magliette con lo slogan “Il mio papa è Benedetto”, promosse dalla Lega di Salvini, sono state solo l’espressione più folcloristica di una teoria del complotto ben radicata. La sua figura è rimasta, per molti, quella di un estraneo: un papa visto come anomalia, più che come guida. È in questo clima di isolamento e sospetto, accentuato da una furiosa reazione della curia conservatrice, che si è consumata la parabola di Francesco. Ed è questo il panorama che dobbiamo tenere presente per comprendere quale sia la posta in gioco oggi, alla vigilia di un nuovo conclave.
Le destre religiose, saldamente intrecciate con i poteri politici reazionari, non hanno mai smesso di attendere il loro momento. Sognano un pontefice che riporti ordine nella dottrina, che archivi ogni ambiguità e cancelli il lessico della misericordia e dell’ascolto. Un papa forte nelle posture, rigido nelle certezze, impermeabile al dubbio. Un pontificato della restaurazione, che riattivi l’obbedienza come valore fondante e metta a tacere ogni voce dissonante. Il modello evocato non è solo quello dei pontificati autoritari del Novecento – Pio XII, Giovanni Paolo II – ma anche quello immaginario e distopico della fiction: un Young Pope in piena regola, rassicurante nella forma, intransigente verso donne, crisi climatica, persone LGBTQ+ e migranti. Tutto ciò che la Chiesa è stata prima di Francesco e che molti, leader dell’ultradestra in primis, sperano torni ad essere.

Francesco si è trovato ad affrontare tempi veloci, ma la sua formazione è quella di un gesuita, un ordine attento, politico, paziente. Nella loro storia i gesuiti sono stati perseguitati perché, abili e lungimiranti, miravano a manovrare le decisioni dei sovrani educandoli durante la loro infanzia, in progetti che richiedevano decenni di lavoro e dedizione. In quest’ottica si comprende meglio il rinnovamento del collegio cardinalizio effettuato da Francesco. A oggi, quasi l’80% dei cardinali è di nomina bergogliana, con posizioni vicine alla sua visione. Molti vengono da periferie geografiche ed ecclesiali: Africa, Asia, America Latina. Ma la forza delle correnti conservatrici resta imponente e il trasformismo dietro le porte della Cappella Sistina ha agito numerose volte. E se l’obiettivo di Francesco era plasmare un conclave capace di proseguire il suo cammino, nulla garantisce che ciò accada.
Eppure, il pontificato di Francesco potrebbe non essere una parentesi. Potrebbe diventare l’inizio di una transizione ancora possibile: quella di una Chiesa capace di uscire dal suo isolamento, di leggere il presente con lucidità, e di assumere una postura meno difensiva e più giusta. Se questa visione avrà la forza di imporsi, il passaggio di Bergoglio non apparirà come un’eccezione, ma come l’inizio di una trasformazione necessaria.

Perché non basta parlare di misericordia: bisogna esercitarla. Non è sufficiente denunciare la guerra: bisogna saperla nominare, assumerne la complessità, prendere posizione. Non si può evocare l’accoglienza senza praticarla. La differenza, ora, la farà il coraggio: di scegliere se continuare sulla strada tracciata – incerta, timida, ma aperta – o voltare le spalle al tempo e rientrare nella confortante rigidità del dogma, sfruttando l’appoggio delle destre, vivere un momento di aureo declino in compagnia di chi crede che il “prossimo tuo” sia chi è etnicamente più simile a te.
Il bivio è evidente. La Chiesa può accettare di vivere dentro la contemporaneità, oppure tornare indietro, verso una rassicurante idea di autorità che però ha smesso da tempo di parlare al mondo. E sarà una scelta, prima che spirituale, profondamente politica. Una decisione su cosa il cattolicesimo intende essere, oggi: perché domani probabilmente non avrà più questa possibilità di scelta.
L'articolo La Chiesa è a un bivio tra essere contemporanea e tornare indietro. Ma è politico, non spirituale. proviene da THE VISION.