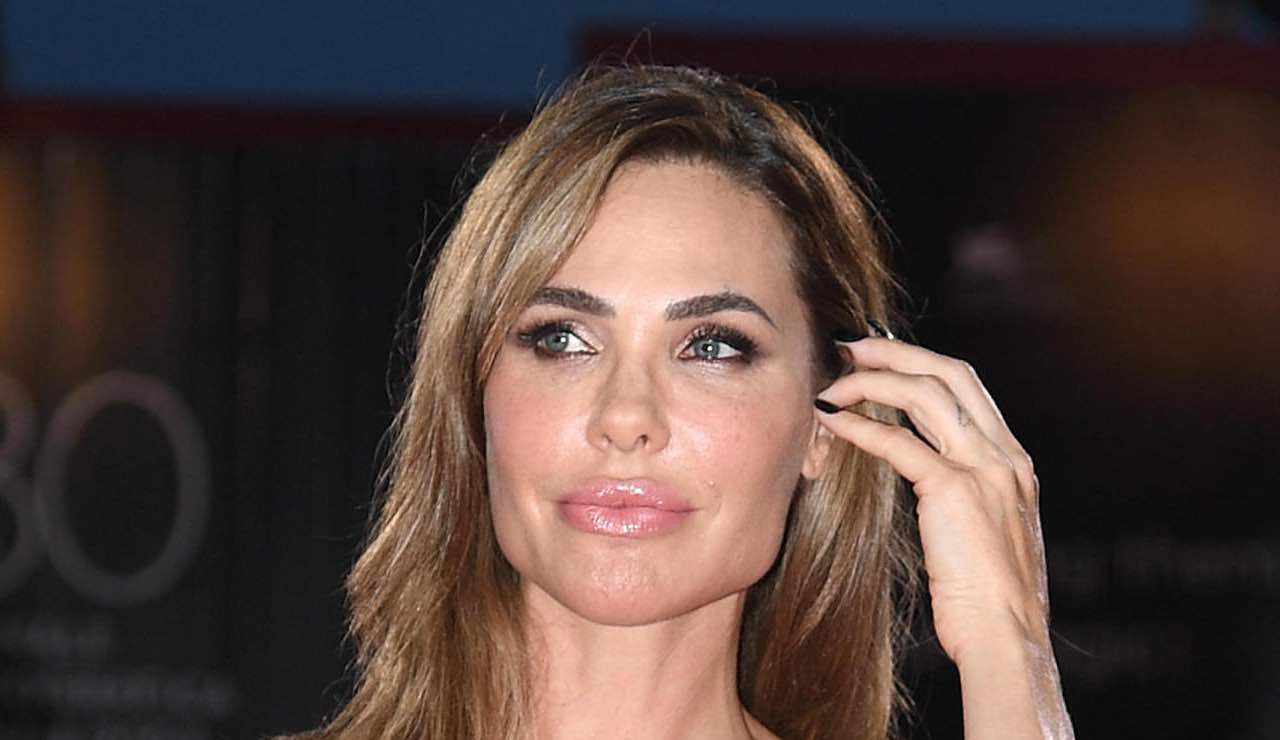IL NIBBIO di Alessandro Tonda (2025) o l’uomo sotto l’immagine
Il nibbio (2025) di Alessandro Tonda si apre con un’ampia inquadratura panoramica, al cui centro campeggia, visto trasversalmente dall’alto, un C-130 Hercules che plana stagliandosi sul chiarore del deserto iraqueno. […]

Il nibbio (2025) di Alessandro Tonda si apre con un’ampia inquadratura panoramica, al cui centro campeggia, visto trasversalmente dall’alto, un C-130 Hercules che plana stagliandosi sul chiarore del deserto iraqueno. Stacco. Nella stiva dell’aereo, una semi-soggettiva ravvicinata allinea il nostro sguardo a quello di Nicola Calipari (Claudio Santamaria), che attende di atterrare a Baghdad per concludere la missione di salvataggio della giornalista del Manifesto, Giuliana Sgrena, rapita un mese prima dalla resistenza sunnita durante un reportagepresso la Moschea di al-Mustafa. È il 4 marzo 2005. Lo spettatore sa benissimo come si sarebbe conclusa la vicenda, e comprende il significato profetico del turbamento che quelle inquadrature chiaroscurate esplicitano nel tremore delle mani del loro protagonista, nella sua sottile e tragica tensione, su un aereo che è sospeso al di sopra della guerra. Lo sa, chi guarda il film, perché probabilmente ha vissuto in prima persona, come spettatore, i momenti del sequestro della donna, gli appelli video, le manifestazioni, le preghiere che segnavano, soprattutto visivamente, l’urgenza di un dialogo a distanza con l’altro. Sa, lo spettatore, che Calipari, funzionario del Sismi, intelligente attore che operava all’ombra della superficie del dialogo, – sotto le generali critiche alla guerra, al terrore, ai colonialismi di ieri e di domani, ad un Occidente che uccide, occidit, di fronte a un Oriente che muore, tanto diverso quanto incomprensibile -; sa appunto, lo spettatore, che Calipari, “il nibbio”, cauto, realistico, essenziale, sarebbe stato ucciso. E sa che l’esercito americano, per errori o scelte rimaste ignote e impunite, gli avrebbe fatto un agguato poco prima che lui raggiungesse, con la Sgrena, l’aeroporto per riportarla a casa; e che il soldato Mario Lozano, mai condannato, avrebbe mitragliato la vettura del salvataggio, ferendo i suoi passeggeri (con loro anche Andrea Carpani) e assassinando lui, che a protezione della Sgrena avrebbe sacrificato la vita, facendole scudo. Sa, o si aspetta di sapere, che un film biografico come Il nibbio avrebbe potuto (e certo dovuto) essere un film “politico”. “Politico” – Nastro d’Argento della legalità 2025 – in quanto demandato a quell’onore della memoria e del sacrificio di cui è sempre importante e bello parlare, nell’orizzonte di una “polis” sempre meno avvezza a pensare in spirito di comunità, o nello spirito del sacrificio di sé (qualunque sacrificio si intenda), perché sempre troppo avulsa in una inquietante e isterica bulimia di rappresentazioni cui non è educata, e che ne affollano, e affossano, l’integrità di senso. Calipari, di cui tutti hanno onorato gentilezza, rigore e coraggio, a simbolo di un’Italia che, nella fatica dell’ordinario al coperto delle immagini confusive della realtà, lavora e si fa servizio all’uomo: Calipari Ksatriya. Lo sa, Tonda, e precisa quindi, in quei primi minuti iniziali, la condizione soffocante di un’attesa che si sarebbe risolta in un martirio, preparando una sorta di atto conclusivo a cui si sarebbe giunti dopo la lunga analessi dei ventotto giorni precedenti, su cui si concentra il film, all’ombra di quell’attesa. Il nibbio sceglie di sostare lì, su quella sospensione “sopra la guerra”, perché quella condizione diventi il centro, umanissimo, e quindi in fondo rispecchiabile, del suo lavoro.
Per questo il film non scende mai, davvero, nel territorio problematico delle immagini e nel suo gioco di specchi a distanza, tralasciando di esplorare (criticamente o meno) quell’indagine sul loro ruolo (culturalmente, socialmente e ontologicamente centrale) su cui invece molto cinema “a tema bellico” si era inarcato problematicamente, peraltro proprio negli anni dell’evento raccontato, e per interrogare un modo di stare nel conflitto che lo duplicasse “digitalmente”, deviandolo, raccontandolo, tradendolo. E preferisce, il film, accentrare un’adesione narrativa immediata, che non si eserciti al di fuori del suo unico punto focale, lo stesso che importava, in quel momento densissimo, a Calipari stesso: salvare la Sgrena, reclusa in una stanza da qualche parte, e, come l’Iraq sentito dai suoi rapitori, senza parole per parlare al mondo. Poco, quindi, che ancori Il nibbio alla riflessione mediale di un film post-moderno come Redacted (2007), con cui Brian De Palma aveva fatto del conflitto in Iraq il territorio simbolico di una riflessione sul significato del nostro sguardo mediato sull’altro, appunto, e della straziante morale invisibile in esso raccolta. Ma anche poco, nonostante la citazione diretta, che lo allinei al “nuovo realismo” con cui Kathryn Bigelow in Zero Dark Thirty (2012), faceva affiorare i brucianti rischi inumani di “esserci”; e la contraddizione dell’essere attori e testimoni (non solo, come noi, oculari e lontani) della disgregazione del mondo e dell’uomo. Il nibbio non vuole, nella ricerca di un racconto più diretto, ma anche più lontano (narrativamente e cronologicamente insieme), e di una vicinanza più terrena ai suoi uomini (un po’ Bellocchio), penetrare (per dissolverlo, liberarlo, comprenderlo, accettarlo, disinnescarlo) in quel labirinto di immagini replicanti che è lo spazio della guerra quotidianamente rappresentata; ma a cui comunque, in qualche modo, esattamente come Calipari, sceglie di prendere parte. Perché piuttosto decide, come il suo protagonista, di muoversi a prescindere e al di sotto di ogni rappresentazione, della rete di accordi e disaccordi politici, delle sensibilità e delle colpe, per andare diritto al punto, trascurando la cornice. Per questo nemmeno si sofferma, Il nibbio, dietro le quinte dei servizi segreti, non ne mostra ingranaggi, meccaniche politiche più o meno esplicite, scelte complesse, mati, complotti, non detti, sfumature, maschere, delicatezze. Non scende cioè, se non per cenni, nella struttura dell’invisibile che soggiace al visibile, come faceva altrimenti Il divo (2008), di Paolo Sorrentino, che invece mostrava le ombre nascoste dei teatranti della corte, il retroterra fosco di ogni scenario performato mediaticamente. E non si sofferma nemmeno sulla causa sunnita, sulle ragioni politiche delle proteste in Italia, sul ruolo della donna, sottomessa, avrebbe suggerito la stessa Sgrena, prima di tutto dai monoteismi (Dio odia le donne, Saggiatore, 2016), sui non-luoghi di una nazione distrutta, sul senso di una guerra inesausta. Non lo fa, appunto, se non per tratti, che sono cenni e allusioni. E non lo fa perché la questione, appunto, tutta ben chiara nel suo momento iniziale, era molto più semplice, e cinematograficamente, cioè “politicamente”, più comoda, e meno pericolosa.
Forse allora è proprio per questo che, a differenza del suo protagonista, il film di Tonda evita di rischiare davvero se stesso per negoziare con il mondo (le nostre guerre, le nostre ideologie, le nostre strettezze, le nostre mediocrità…). Non scende a patti, come fa Calipari, con le ambiguità strutturali del nostro tempo, per operarvi salvificamente. E pur con la bella interpretazione di Santamaria, l’immagine del Calipari-uomo finisce per risultare troppo poco sfaccettata, ancora cioè troppo “in alto” (su una superficie non penetrata, su un aereo che si staglia sopra il deserto della guerra). Noi, che sappiamo come sarebbe andata a finire da subito, non siamo chiamati a scendere dentro l’umano che, per ciascuno di noi, è la premessa di ogni azione regale. Guarderemo quello che ci saremmo aspettati di vedere, perché sapevamo anche quello che avremmo potuto guardare. I desideri di quell’uomo che siamo portati a onorare ci saranno allora ignoti come le sue contraddizioni, le sue posizioni politiche, le sue fragilità: sfumate, suggerite, sospirate, ma volutamente non osservate davvero. Persino il discorso, “eroicamente” nevralgico, sul movente possibile dell’orgoglio del “salvatore” si spegne precocemente e non ci lascia “scendere” dentro quell’umanità che ci potrebbe riguardare da vicino; proprio perché Calipari, con la sua famiglia, per come ci è presentato, potremmo anche essere noi.
Potrebbe essere, anche quella, una scelta: la nobiltà del distacco fino al sacrifico, a prescindere da ogni dettaglio particolare, e votandosi alla causa dell’umano. Ma quanto sarebbe spiccato di più, quel valore, e quel distacco, se portato nell’ambiguità immaginale di una contemporaneità che è anche, se non soprattutto, un’ambiguità delle immagini (della propria, del mondo)? Quanto l’immagine di “un eroe di cui abbiamo bisogno” (per citare un altro personaggio “sotterraneo” del nostro tempo), colto nelle ombre vive di una umanità che tutti ci riguarda, avrebbe potuto farsi occasione per meditare le contraddizioni di un mondo di mezzo, il nostro, spesso completamente privo di modelli, oppure, il che è uguale, modellato da immagini un po’ stereotipiche, e quindi in fondo poco “imitabili”, perché non abbastanza radicate sul terreno dell’esperienza delle nostre più profonde, e spesso assai visibili, contraddizioni?