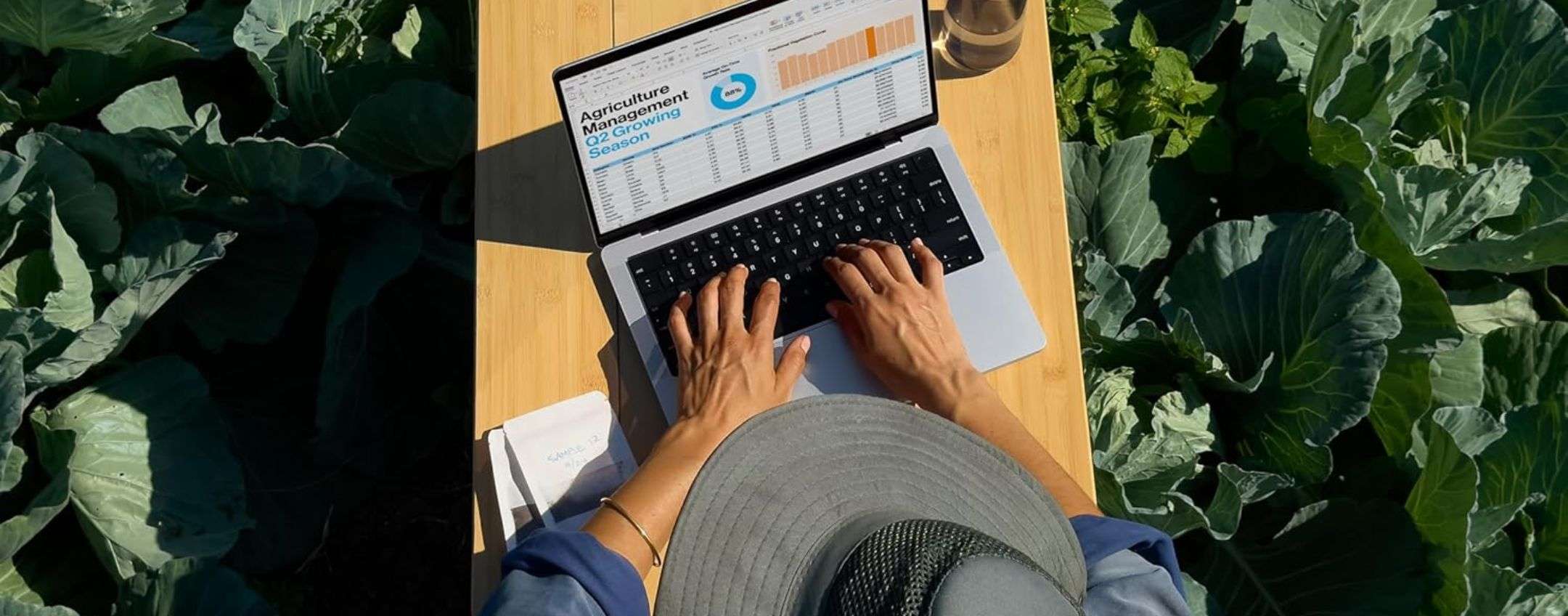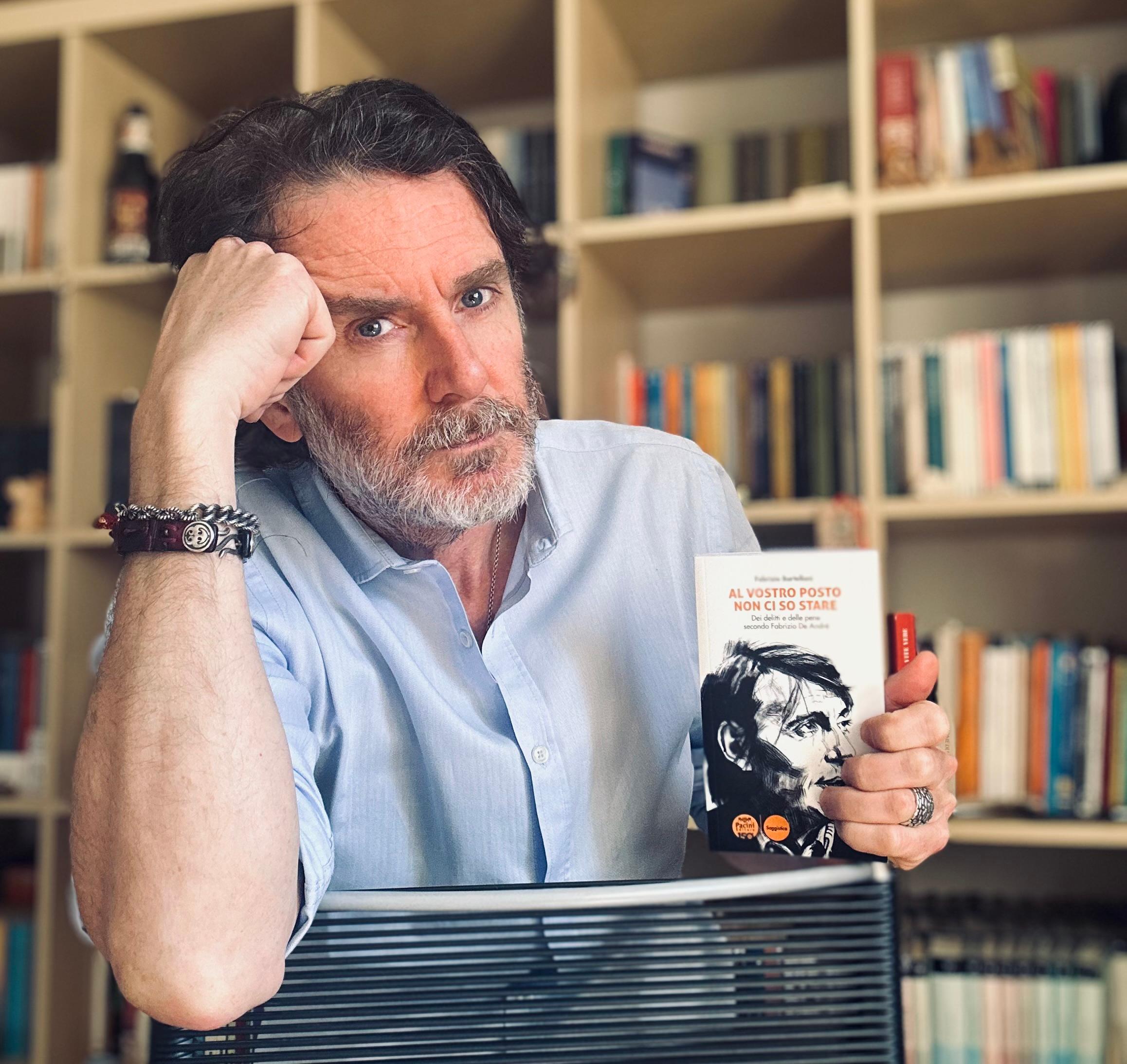I social influenzano le nostre scelte politiche, vanno regolamentati contro il pericolo dittature
Provare a sventare le costanti minacce antidemocratiche delle destre occidentali significa anche agire sul binomio tecnologia-politica, sondando il nesso tra i due piani, e accertando se e quanto le nostre inclinazioni e scelte siano effettivamente soggette a una manipolazione su base tecnologica, così da impedire l'eventualità in cui strumenti ormai indispensabili alla nostra vita possano diventare armi a servizio di governi autoritari. L'articolo I social influenzano le nostre scelte politiche, vanno regolamentati contro il pericolo dittature proviene da THE VISION.

All’inizio di gennaio, dopo la prima conferenza stampa annuale di Giorgia Meloni, internet è stato invaso da meme che la ritraevano accanto a Elon Musk, alludendo a una ship tra i due. Uno dei principali temi su cui Meloni era stata incalzata dai giornalisti in quell’occasione riguardava, infatti, la fumosa trattativa con Musk per un contratto di fornitura con SpaceX, l’azienda spaziale fondata dal miliardario sudamericano per la colonizzazione di Marte, che prometteva di procurare i suoi avanzati mezzi di telecomunicazione anche all’Italia. La discussione dell’accordo – venduto all’opinione pubblica anche come ipotetica moneta di scambio per affrettare le trattative sulla liberazione della giornalista Cecilia Sala, quando in realtà rappresentava un chiaro tentativo di rafforzare i rapporti con il governo statunitense di Trump tramite il suo più prezioso alleato –, secondo molti utenti avrebbe infatti smascherato una sospetta intesa di coppia, tra presunti gesti di ammiccamento, larghi sorrisi e dichiarazioni di stima reciproca. Durante la conferenza, a supportare queste supposizioni da fanfiction, Meloni aveva confermato l’amicizia con Musk, chiedendosi quale fosse il problema dei suoi detrattori – la ricchezza del CEO di Tesla o il suo non essere di sinistra? – e affermando che, a suo modo di vedere, l’uomo più ricco del mondo, fondatore di aziende dal capitale multimilionario e impegnate in settori fortemente implicati a livello politico, oltre che proprietario di un media noto e influente come X, l’ex Twitter, comunque non stesse affatto rappresentando “un pericolo per la democrazia”.

La smentita definitiva alla dichiarazione di Meloni è arrivata appena qualche giorno dopo, anche se il tanto discusso saluto romano non era certo necessario per intuire quanto le credenze e l’operato di Musk fossero un pericolo per le istituzioni democratiche, e da ben prima dell’inizio del secondo mandato Trump. Al di là delle loro reali o supposte affinità elettive, però, il momento storico che stiamo attraversando ha ironicamente creato un contesto che conferisce grande pertinenza alla ship tra Musk e Meloni, andando molto oltre il suo intento satirico, dal momento che essa rappresenta la perfetta metafora di una nuova forza profondamente plasmante per il nostro presente, ovvero quella che deriva dall’unione tra il potere tecnologico e politico – soprattutto se animato da istanze di estrema destra, quindi sovraniste, reazionarie e populiste.
Dal momento in cui le tecnologie digitali, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di smartphone e social network, sono diventate una costante della nostra esperienza, è infatti bastato poco tempo per passare da un iniziale atteggiamento di tecno-ottimismo, a una maggiore diffidenza nei confronti dei loro effetti sui nostri comportamenti, inclinazioni, scelte. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok vengono regolarmente presi di mira ormai da tempo per i loro effetti dannosi sulla nostra salute mentale, ma di recente sono diventati oggetto di discussione anche per quanto riguarda la salute della nostra stessa coscienza politica – da cui dipendono, ovviamente, anche le possibilità di conservazione delle istituzioni democratiche. La sterzata a destra che è venuta a delinearsi di recente in tutto l’Occidente, quindi, impone una domanda ulteriore rispetto alle attuali evidenze scientifiche di cui disponiamo sul nostro rapporto con le nuove tecnologie, ovvero quelle che se ne occupano dal punto di vista psicologico e clinico. Arrivati a questo punto, dovremmo infatti chiederci se la nocività di alcuni di questi strumenti possa avere un riverbero anche sul piano sociale, e soprattutto su quello politico, proprio perché oggi come mai gli interessi dei grandi tecnocrati sembrano convergere sempre più con quelli dei governi di estrema destra, rischiando di minare alla base i principi della democrazia.

Gli studi di cui disponiamo sulla nostra relazione con la tecnologia sono infatti essenzialmente quelli che riguardano la salute del singolo. I dati, da questo punto di vista, tendono a sottolineare un incremento generalizzato di sintomi ansiosi, depressivi, paranoici, oltre che di una maggiore propensione all’irritabilità nelle persone che fanno un utilizzo indiscriminato di smartphone e social. Il benessere psicologico di ognuno di noi sembra risentire sensibilmente di una simbiosi con il digitale che ormai diamo per scontata, nonostante questo rapporto ci abbia ormai mostrato chiaramente le conseguenze deleterie che ha sulla nostra autostima, sui rapporti con gli altri, sulle aspettative sempre più sfiduciate che nutriamo nei confronti del futuro. Ognuno dei sentimenti negativi correlati all’abuso tecnologico pare infatti avere un preciso effetto sul nostro sentire e sui nostri comportamenti: basti pensare che, come è stato dimostrato di recente da una ricerca condotta in una delle divisioni del Massachusetts General Hospital, il nervosismo che accumuliamo sui social – quando ci sentiamo frustrati perché paragoniamo la nostra vita a quella di qualcuno che ci sembra più brillante e realizzato, o leggiamo un’opinione che confligge con i nostri valori tanto da peggiorarci l’umore – ha un impatto sulle nostre abilità sociali, sulla capacità di dedicarci ad attività anche semplici o piacevoli, e sull’inclinazione all’aggressività e alla violenza. Per questo viene da chiedersi se (e in che modo) l’esposizione a un ambiente che catalizza i nostri sentimenti negativi, e che appare sempre più pericoloso – perché disseminato di truffe e fake news – e polarizzato – a causa di policy sempre più lasche che favoriscono estremismi ed hate speech – possa agire sulla nostra psiche coadiuvando atteggiamenti intolleranti, un generale irrigidimento ideologico, o una visione reazionaria della società.
Si tratterebbe, in sostanza, di valutare la controparte sociopolitica di un quadro clinico su larga scala già piuttosto chiaro – e drammatico. Una delle riflessioni più influenti in questo campo è probabilmente quella di Chris Bail, sociologo statunitense e docente in alcune delle università più prestigiose del mondo, che ha parlato di internet e politica nel suo Breaking the social media Prism, pubblicato nel 2021. Secondo Bail, molti dei meccanismi caratteristici delle piattaforme digitali – la creazione delle cosiddette eco chambers, la spinta data dall’algoritmo a opinioni estreme o sensazionalistiche, la riduzione dei tempi di fruizione e la semplificazione dei concetti espressi nei contenuti online – tenderebbero a promuovere una “falsa polarizzazione”, che appartiene più alla rete che alla realtà, rendendo invisibili le persone politicamente moderate e costruendo così un “bias di negatività”, che fa sembrare le opinioni di chi ci circonda più pericolose e antidemocratiche di come in realtà sono. In questo senso, i social assomiglierebbero a un prisma deformante più che a uno specchio, dato che essi ci porterebbero a fraintendere la realtà politica e le reali convinzioni degli altri utenti.

La posizione esposta da Bail – e supportata da molte rilevazioni empiriche – va certo tenuta in considerazione: è probabilmente vero che internet tende a crearci attorno una sorta di bolla di negatività, facendo da cassa di risonanza ad alcuni sentimenti spiacevoli – come possono essere, sul piano politico, lo sconforto per le sparate apparentemente insostenibili di alcune figure istituzionali, che gli algoritmi rendono ormai quotidianamente virali; o il timore per una notizia già di per sé preoccupante per le sorti del mondo, che viene ulteriormente ingigantita da titoli clickbait. L’engagement, d’altra parte, capitalizza emozioni forti, e non è inesatto dire che quelle negative spesso riescano a lavorare in noi e a muoverci tanto quanto quelle positive, portandoci addirittura, in alcuni casi, ad anteporre l’istinto alla razionalità, con tutte le conseguenze che ne derivano. Allo stato delle cose, però, il punto non è più soltanto cercare di mantenerci razionali, auto-rassicurandoci su quanto la realtà offline possa essere diversa e sperabilmente più moderata rispetto a ciò che viviamo in rete. Si tratta di capire che conseguenze abbia sulla nostra emotività la permanenza in questi spazi virtuali tanto ostili: quanto peggiori il nostro umore, se ci renda più aggressivi, come influisca sulla nostra esperienza del mondo. E occorre, soprattutto, capire se questa negatività, una volta uscita dal mondo online, possa essere sfruttata da certa politica, come è sempre stato fatto nella storia da parte delle destre con la paura, la rabbia e l’insoddisfazione dell’elettorato.
Per questo, provare a sventare le costanti minacce antidemocratiche delle destre occidentali significa anche agire sul binomio tecnologia-politica, sondando il nesso tra i due piani, e accertando se e quanto le nostre inclinazioni e scelte siano effettivamente soggette a una manipolazione su base tecnologica, così da impedire l’eventualità in cui strumenti ormai indispensabili alla nostra vita possano diventare armi a servizio di governi autoritari. Bisogna quindi comprendere quali siano le vere conseguenze della dialettica nei social media e dei meccanismi interni alle varie piattaforme di cui facciamo continuo uso, e occorre farlo su basi scientifiche, raccogliendo dati attendibili, per valutare la necessità di normative legate alla limitazione delle tecnologie digitali – soluzione che, tra l’altro, appare anche nel testo di Bail. Non si tratta di una demonizzazione degli strumenti in sé, ma di una domanda da porsi necessariamente prima di assistere a un ulteriore peggioramento dell’attuale situazione politica, anche se va a mettere in discussione un aspetto della nostra esperienza di cui forse non sapremmo più fare a meno.

Se vogliamo che il nostro rapporto con la tecnologia ci faccia principalmente del bene, infatti, occorre impegnarci a regolare i contenuti online in modo che essi rappresentino uno specchio il più possibile fedele della realtà, e non accettare che offuschino il nostro giudizio come nel prisma descritto da Bail, soprattutto quando ciò che vi si riflette ha a che fare con le nostre opinioni politiche. L’opportunità di valutare il mondo che ci circonda in modo obiettivo e non manipolabile dovrebbe infatti rimanere un diritto insindacabile, su cui non possiamo cedere, in particolare in un momento storico in cui le innovazioni tecnologiche sembrerebbero aver acquisito il potere di annebbiare il nostro sguardo se usate in modo scorretto. Riconoscere quanto le tecnologie digitali siano diventate uno dei nostri principali strumenti politici, infatti, è il primo passo per comprendere quali effetti abbia questa evoluzione sulla nostra propensione ideologica e di conseguenza sulle nostre scelte elettorali. Ancor di più, è un modo per imparare ad accorgerci delle lenti distorcenti che determinate parti politiche potrebbero tentare di applicare, con mezzi sempre più sofisticati, al nostro occhio sulla realtà, influendo su decisioni, come il voto, che dovrebbero invece rimanere libere e autonome – tanto dalla propaganda quanto dall’algoritmo.
L'articolo I social influenzano le nostre scelte politiche, vanno regolamentati contro il pericolo dittature proviene da THE VISION.