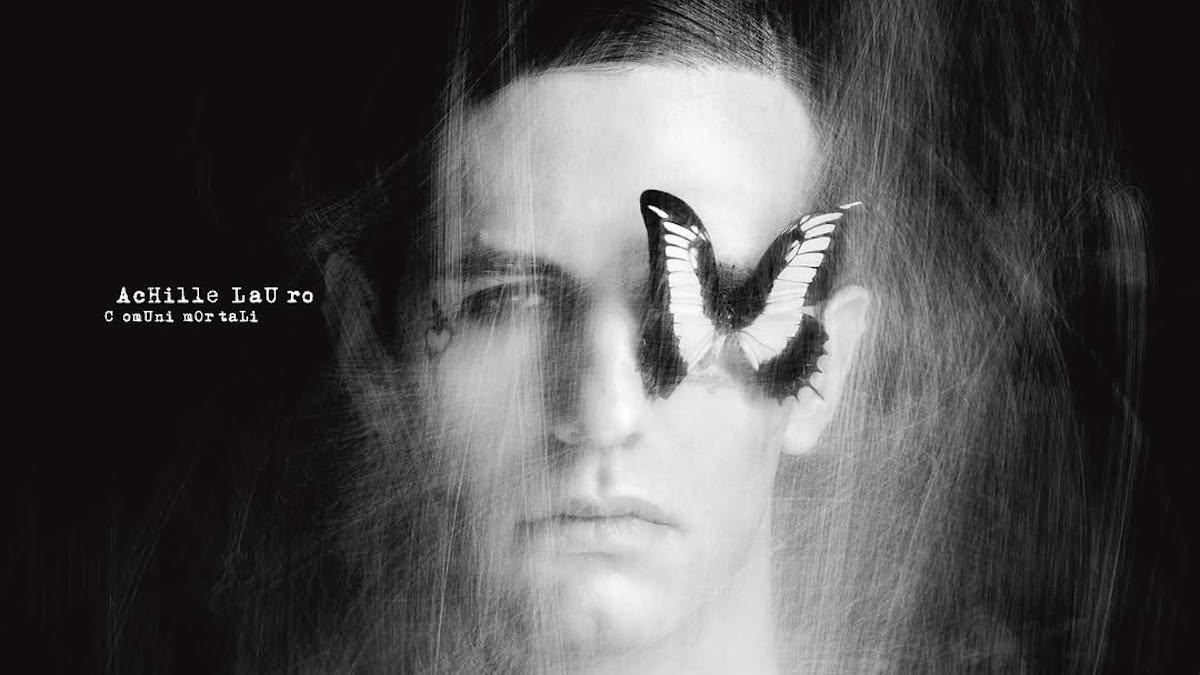Caro Preterossi, ecco come siamo sprofondati da Pasolini a Serra
Apro l’ombrello per ripararmi dalle accuse di cinismo che non mancheranno di piovermi addosso Alberto Savinio Come siamo finiti da Gramsci a Serra, si chiedeva il direttore di questa rivista, […]

Apro l’ombrello per ripararmi dalle accuse di cinismo che non mancheranno di piovermi addosso
Alberto Savinio
Come siamo finiti da Gramsci a Serra, si chiedeva il direttore di questa rivista, Geminello Preterossi, nel raduno “Tutti a casa” di Roma il 29 marzo scorso. Diceva Alberto Savinio che esistono le persone intelligenti, e poi ci sono gli intellettuali. Gli intelligenti hanno la peculiare caratteristica di non essere prevedibili, mentre gli intellettuali, in parte incolpevolmente facendone un mestiere, devono per statuto compiacere il pubblico. Esattamente come i politici o gli uomini d’affari. L’intelligenza, se lasciata al suo naturale corso, si sente sempre a disagio rispetto alla realtà data, e non può far a meno di guardare al rovescio della medaglia. E questo in ogni circostanza, perché ogni cosa proietta un’ombra, tutto ha un risvolto problematico. L’anima critica punta dritta al crinale dove, fatalmente, troverà una contraddizione, un lato oscuro, un non detto più o meno inconfessabile. È per questo che chi agisce sul piano culturale fa sì politica, fa sì parte del mercato, ma in via indiretta: perché obbedisce, o dovrebbe obbedire, innanzitutto alla propria coscienza, e solo poi alla convenienza. Oggi invece l’intellettuale medio è l’animale più stupido: non comprende il mondo reale, perché troppo occupato a servire la ragion economica o politica. È un venduto in quanto vende, e nel vendere si svende. È un pusillanime, un addetto al marketing, e la sua funzione è giustamente caduta in discredito. Parafrasando il Longanesi perculatore di Benedetto Croce: non capisce niente, e neanche più con grande autorità. È un miserabile.
La miseria degli intellettuali nasce con l’apparizione stessa della figura del moderno intellettuale critico. Se vogliamo individuarne la simbolica data di nascita, potremmo assumere a spartiacque il famoso “J’accuse” di Émile Zola, l’appello sul caso Dreyfus pubblicato sul quotidiano L’Aurore nel 1898. Il legame con la pubblicistica d’occasione rimanda al precedente periodo di semina lungo tutto l’Ottocento e buona parte del Settecento, specialmente in Francia con gli illuministi (Voltaire, Rousseau), gli enciclopedisti (Diderot, D’Alembert ecc) e, ancor più, con i libellisti (Constant) e i primi giornalisti (Desmoulins, Marat, Hébert). Ma in tutti questi casi, si trattava di menti che producevano grazie all’antico modello del mecenatismo o per ricchezza propria (non di rado d’origine nobiliare). Oppure esclusivamente per fini di agitazione politica. È a cavallo fra Otto e Novecento che l’intellettuale è costretto a fare i conti con un mercato delle idee e delle arti. Per il semplice motivo che il capitalismo ne aveva creato uno, come fa per ogni attività umana. In Inghilterra e negli Stati Uniti, terre di puro spirito capitalistico, ci erano già arrivati, naturalmente. Ma in virtù di questa anima commerciale, non avevano visto sorgere l’idealtipo dell’intellettuale politicamente impegnato, il cui afflato civile ne promuove l’opera così da sostentarlo economicamente (tanto è vero che chi aveva cercato fin lì di vivere solo dei propri libri o, poniamo, dei propri dipinti, se non era accademico o al soldo di qualcuno, faceva vita grama: pensiamo a un Nietzsche, a un Baudelaire, a un Van Gogh, a tutti gli squattrinati scrittori e pittori della Parigi bohémien).
L’intellettuale come lo intendiamo oggi, punto di riferimento colto che parla a una piazza di incolti, doveva guadagnarsi il favore e i portafogli di un target diffuso di acquirenti. Così decade già da subito la sua presunta purezza. Come aveva ben visto Nietzsche, era stato Richard Wagner ad anticipare in grande stile questa spinta alla prostituzione. Wagner però si rivolgeva alla fascia dell’alta borghesia e aristocrazia dell’epoca (la “canaglia oziosa d’Europa”). Con Zola, si inaugura il tempo del discorso all’opinione pubblica. Intendiamoci: intellettuali puri non ce n’erano stati mai neanche prima. A parte qualche eccezione, i filosofi, letterati e artisti nei secoli addietro, quando non avevano rendite proprie avevano sempre lavorato su committenza o alla corte di qualche sovrano, ecclesiastico o facoltoso finanziatore. Comunque al servizio di un qualche potere di turno, quando non essi stessi al potere (per dire: Bacone, il grande ideologo inglese della modernità scientifica, faceva anche il politico). Complice l’analfabetismo, costituivano una componente dell’élite, ed erano perciò necessariamente elitari. Ma per usare un linguaggio marxiano, il valore d’uso del loro genio non era soggetto al valore di scambio di un mercato massificato. Bastava trovare un munifico mecenate a palazzo ed era fatta, non dovevano sottoporsi al giudizio della plebe. Nonostante il lento avanzare dell’editoria scritta, la cultura come auto-educazione dello spirito era un fatto di pochi per pochi (e così, sostanzialmente, è rimasto).
Con l’avvento della società di massa, si introduce uno strutturale elemento di ambiguità: l’intellettuale può anche in buona fede predicare alti ideali, può pure sostenere tesi eversive e magari incitare alla rivoluzione violenta, ma contemporaneamente, volente o nolente, deve sottostare al dominio dell’utile economico. Insomma, deve guadagnarsi il pane. Ecco allora confondersi sempre più con il giornalista (Prezzolini, Papini, Gramsci, Gobetti), con il pubblicitario di sé stesso (D’Annunzio, Marinetti, Malaparte), o alla peggio, tenere la cattedra universitaria o qualche lavoro comune come bene-rifugio (tutti gli altri: Gentile, Pareto, Mosca, Salvemini, Spirito, Ungaretti, Montale, Croce no perché non si laureò ed era ricco di famiglia). Ora, fino a quando il famoso valore di scambio non soppiantò l’intrinseco valore di originalità e studio, l’intellettuale engagé mantenne un ruolo di guida che conobbe il suo massimo fulgore nel momento di picco delle passioni utopiche, nei due dopoguerra e nei successivi anni ’50 e ’60 fino ai ’70. I Camus, i Sartre, i Marcuse, per certi versi anche il più appartato Heidegger, e da noi Pavese, Moravia, Calvino, Pasolini rappresentavano personalità circonfuse di un alone di venerabilità anche qualora osteggiate, censurate e coinvolte in dispute di un’asprezza oggi inimmaginabile. Ma se anche qui vogliamo estrarre un evento iconico per datare la morte dell’intellettuale moderno, potremmo scegliere proprio quella, cruenta, di Pier Paolo Pasolini: fu lui, infatti, a diagnosticare il nuovo e definitivo tipo di servilismo coatto dell’intellettuale, integrato e ridotto a ingranaggio del sistema economico. E fu lui a impersonare al più alto livello l’amara autocoscienza di voler contrastare il sistema operandoci da dentro. Non per caso, nell’ultima fase della vita la sua firma comparve sulla prima pagina del Corriere della Sera, voce ufficiale dell’establishment borghese (anche se, da vero “corsaro”, aveva già copiosamente scritto contro i “fascisti rossi” nel Tempo settimanale, giornale moderato). Pasolini, coltissimo e dallo stile di vita, ai tempi, scandalosamente minoritario, voleva parlare ai semplici, al popolo, a coloro che non erano ammorbati dalle sofisticherie della categoria cui apparteneva. A nostro avviso, tuttavia, non ci riuscì.
Non ci riuscì perché l’ulteriore stadio dell’economizzazione integrale del mondo – quel consumismo che tanto bene analizzò e denunciò – aveva aperto le porte alla “società dello spettacolo” (Guy Debord). E allorché l’idea-merce si fa immagine-merce e i concetti vengono assorbiti nel flusso visivo (show must go on), l’Intellettuale Collettivo diventa la Pubblicità, anima nera del commercio. Anche questo Pasolini lo aveva capito e riconosciuto: di qui la scelta, ancora una volta controcorrente, di virare verso un’estetica dell’abiezione e dell’abisso, con Salò e le 120 giornate di Sodoma. I veri colpevoli del cosiddetto “tradimento dei chierici”, vale a dire dell’intelligenza, furono, e sono ancor oggi, coloro che a differenza di PPP (o di Carmelo Bene, che gli era affine per molti aspetti), preferiscono trovare un accomodamento e non far più neanche finta di ribellarsi. Sono i neo-cortigiani senza nemmeno l’alibi della grandezza: appiattiti sulla facile ripetizione di clichés, si adagiano sulla difesa dell’ordine costituito, considerando la “società aperta”, la sedicente “democrazia liberale”, l’esito senza ritorno, la fine della Storia, il modello insuperabile di consorzio umano. Sono addetti al commentificio da social, gente magari tecnicamente brava nel proprio (scrittura, teatro, musica ecc.) ma di mente straordinariamente ritardata non appena tocchi l’argomento “politica”. Non c’è niente da fare: proprio non gli riesce, a questi ingenui o profittatori (o tutt’e due le cose insieme) di scorgere l’ovvio, e cioè che la democrazia è un’oligarchia, il libero mercato non è libero, il lavoro neo-schiavistico ci ruba il tempo, siamo consumati dai consumi, e il tutto è una gran bella truffa di cui loro vanno fieri con una sicumera da fanatici.
Intolleranti a tutto ciò che non rientra negli schemi, questi progressisti da retroguardia hanno abdicato al compito demistificatorio che pure costituiva l’essenza dell’intellettualità post-moderna (Lyotard, Foucault, Deleuze, Derrida). Ovvero la critica per la critica, il decostruzionismo che nega e non costruisce, quell’approccio liquefatore che alla fine, contrapponendo il nulla al Nulla, si è auto-liquidato. E in Italia siamo giunti così, per lo meno a sinistra, ai Michele Serra e agli Antonio Scurati, ai Roberto Saviano e ai Roberto Benigni (d’altronde a destra, con rispetto parlando, a parte forse Marcello Veneziani, Francesco Borgonovo e non più etichettabili à droite un Cardini o un Tarchi, a fare opinione è rimasto Vannacci…), i quali colmano il penoso vuoto di onestà intellettuale con la scorciatoia del moralismo infantile, miserevolmente intenti a dividere l’umanità in buoni e cattivi, Bene contro Male, Occidente contro resto del mondo. La difficoltà del Politico e la complessità del reale non fanno più parte del loro orizzonte, perché non sanno più essere né radicali né ironici. Non sono capaci di andare con lo sguardo alle radici dei conflitti, sociali o geopolitici, e al tempo stesso non sanno guardarsi allo specchio riconoscendo i propri limiti, oggettivi e soggettivi. La miseria degli intellettuali d’oggi è, prima di tutto, banalità di giudizio, acquiescenza ai tabù, appiattimento sull’eterno presente. È rivoltarsi come maiali nel porcile dei talkshow di prima serata. In una parola: mediocrità.
Eppure, intellettuali che almeno ci provano, a dimostrarsi intelligenti à la Savinio, ci sono. Resistono nelle retrovie, nelle trincee, spesso nelle catacombe. E perciò sovente indulgono al peccato mortale di settarismo, malattia infantile del radicalismo. Sanno essere radicali, ma purtroppo non autoironici. E quindi cadono nello stesso errore, anzi, nello stesso orrore degli alti papaveri di cui sopra: lo snobismo, sia pur straccione. E quando prevale la logica della conventicola, della nicchia, della fanbase con i seguaci plaudenti e ringhianti, il cretinismo ha già vinto. Come dovrebbe comportarsi un odierno intellettuale che non rinunci a priori a rispettare la propria intelligenza? Siamo abbastanza presuntuosi per rispondere: dovrebbe essere elitario. Sissignori: elitario, nel senso elevato, esigente e migliore del termine. Niente a che fare con la proverbiale puzza sotto il naso. Se difatti è suo dovere fare ciò che gli è possibile per diffondere il contravveleno a questa vita apparente che conduciamo in un’addomesticata angoscia, allora deve, con parole e senza omissioni, colpire dritto al cuore dell’unico vero pensiero unico: la forma mentale utilitaristica, calcolante, avara, avida, ristretta, narcisa, superficiale, pigra, piccoloborghese, comicamente seriosa, vile e carogna che ha colonizzato il senso comune comprimendone la vitalità inconscia. Se non può non sentire stretta la camicia di forza da opinionista in servizio permanente effettivo, la sua vocazione resta pur sempre far venire alla luce ciò che tutti vedono ma pochi ammettono. E pertanto deve abbattere le barriere del politicamente consentito, contribuendo a immaginare un’altra possibilità esistenziale. Per erodere l’egemonia deve dis-integrare e dis-educare, essere in-utile e contro-intuitivo, e soprattutto mettersi risolutamente in posizione anti-liberale – anziché a 90 gradi o a contare bigliettoni con serie sul vecchio Mussolini, brand che tira sempre, tra gli antifascisti a babbo morto come fra i cripto-nostalgici. Il nostro sabotatore umanista deve riempire di pensiero – vivo e vitale, reale e realistico – quella libertà senza pensiero che fa da paravento alla pseudo-élite di kual kultura. Programma vasto, d’accordo. Ma fattibile – tanto è vero che, per esempio qui, lo facciamo già. E supremamente elitario. Cosa c’è infatti di più elitario di una coscienza che cerchi di essere non solo corrosiva, ma anche ricostruttiva, aperta all’imponderabile e all’inedito? Non facciamo gli ipocriti: è dall’età della pietra che le minoranze creative mandano avanti la Giostra. La creatività non è democratica. È l’intelligenza, piuttosto, a dover esserlo. Oggi più che mai.