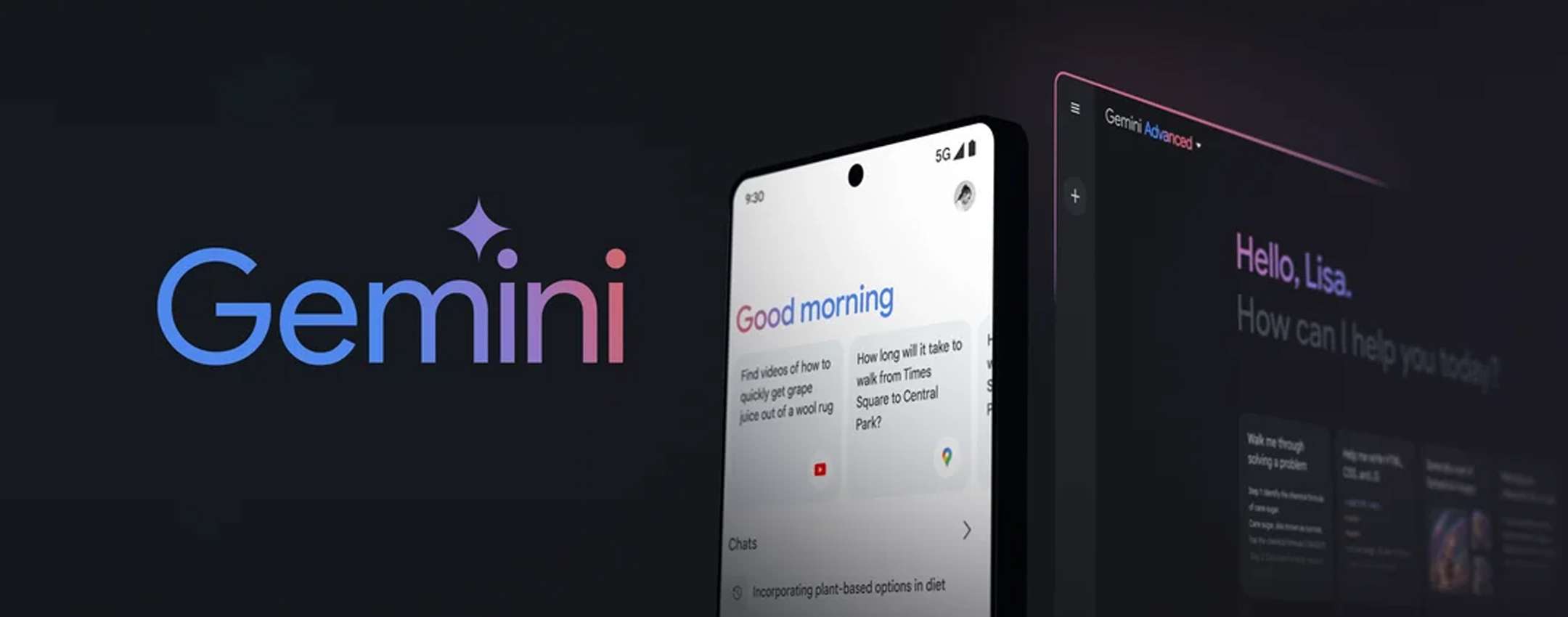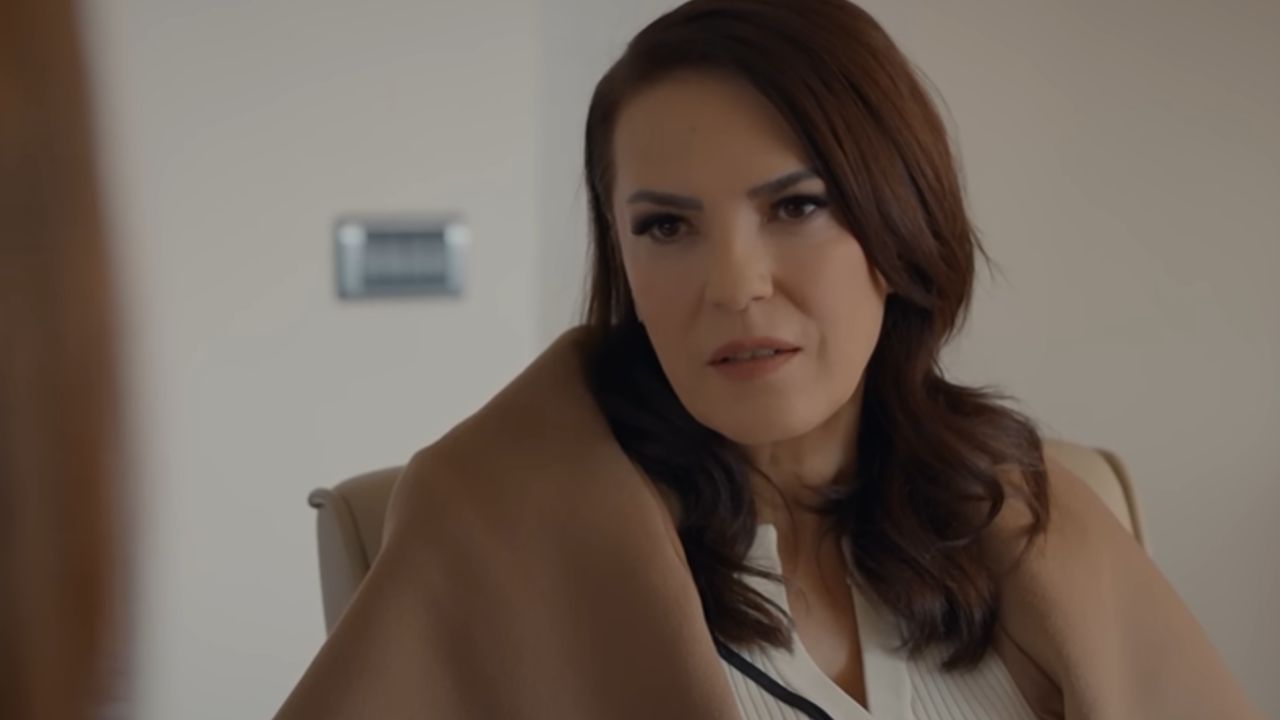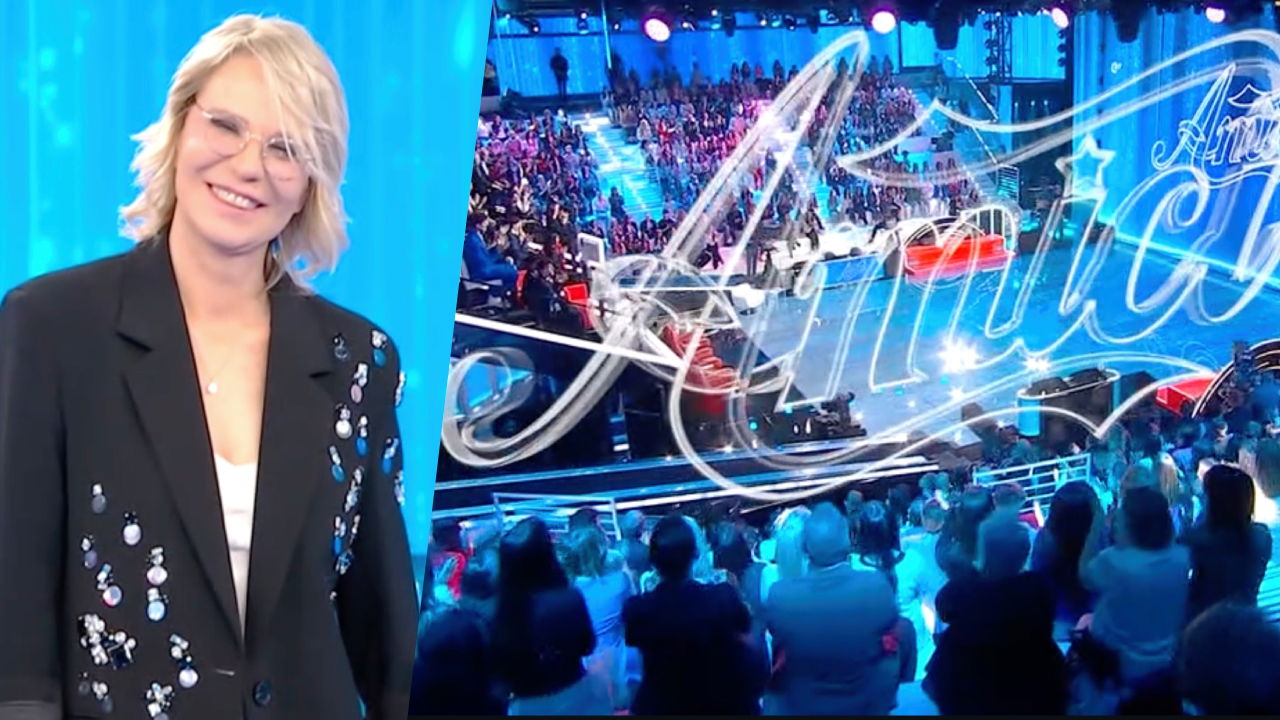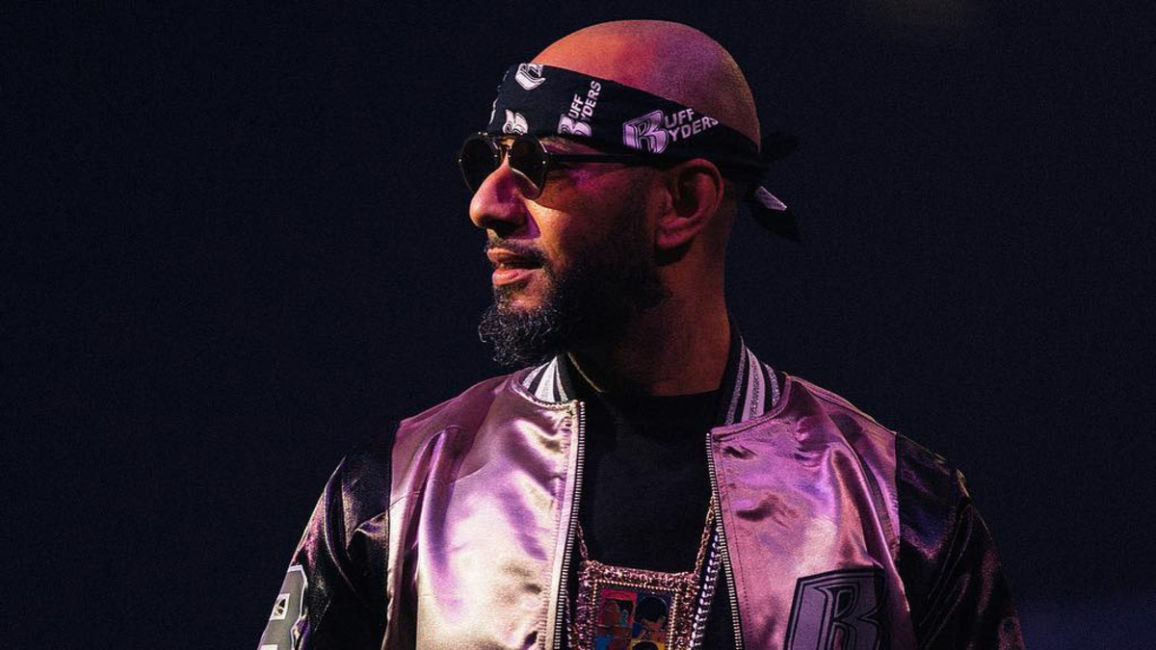Dopo la “disunità del mondo”: Colombo su guerra e disordine internazionale
Nell’epoca della de-globalizzazione, come qualcuno ha definito il rapido riflusso dell’ordine liberale internazionale nel corso dell’ultima decade, non è facile fornire una bussola nel mercato delle idee futurologiche: da un […]

Nell’epoca della de-globalizzazione, come qualcuno ha definito il rapido riflusso dell’ordine liberale internazionale nel corso dell’ultima decade, non è facile fornire una bussola nel mercato delle idee futurologiche: da un lato i critici “apocalittici” del (dis)ordine mondiale, con la loro ampia varietà di teorie cospirative prêt-à-porter; dall’altro gli “integrati”, con le loro (inde)fesse certezze sulla bontà dell’ordine mondiale post-bipolare, apologeti progressisti di istanze storicamente conservative come la centralità dell’Occidente, del sistema di libero mercato, e del cosmopolitan liberalism che ha contraddistinto il trionfalistico ottimismo euro-americano degli anni ‘90.
Il volume di Alessandro Colombo (Il suicidio della pace, Milano: Raffaello Cortina Editore, 2025) si pone il compito meno ambizioso, ma non meno facile, di gettare invece uno sguardo retrospettivo sulla patogenesi dell’ordine internazionale liberale, dall’apogeo dell’unipolarismo di fine XX secolo al suo “tramonto” nella seconda decade del XXI secolo. Certo la categoria di “tramonto”, da Spengler in avanti, è stata evocata più o meno pretestuosamente numerose volte nella letteratura filosofica novecentesca, e spesso con riferimento alla perdita di centralità dell’Occidente (qualsiasi cosa si intenda con questo termine). Ma si tratta di una malìa romantica a cui l’autore non indulge, optando invece per un tentativo storico ed internazionalistico di scomposizione e riordino dal periodo compreso tra il 1989 e il 2024 attraverso “cinque diverse fasi”,[1] critiche e cumulative, che hanno scandito la parabola discendente dell’ordine liberale internazionale: dapprima “il trionfo illusorio dell’Occidente liberale” (1989-2000), poi l’involuzione del Nuovo Ordine Mondiale (2001-2008); quindi il “tornante”, con l’erosione delle basi politiche, economiche e istituzionali esistenti (2008-2013), seguito dal ritorno della competizione tra grandi potenze (2013-2020) e, infine, dal crollo dell’ordine internazionale mondiale (2020-2024).
Un ordine internazionale sorto, in realtà, da premesse storiche più lontane, cioè dalla “balcanizzazione del mondo” che si cristallizzò con la carta ONU dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare attraverso la tutela dell’integrità territoriale di qualsiasi Stato dalla minaccia o l’uso della forza, e dal sostegno protagonistico di tale sistema da parte degli USA, ovvero dalla potenza “al vertice del sistema” creato nel 1945 a San Francisco.[2] E in questa genealogia si celano già, in nuce, i motivi antitetici di fondo che hanno attraversato l’ordine internazionale fino agli inizi del XXI secolo: la tensione tra l’“uguaglianza formale degli Stati” sancita dal diritto, da un lato, e l’implicita “stratificazione” degli stessi attorno ad un nucleo di “democrazie liberali”, dall’altro, basato su criteri di discriminazione eminentemente politici.[3]
Una “stratificazione” che, se vogliamo, è all’origine del contestato (dis)ordine mondiale contemporaneo segnato da nuove asimmetrie demografiche ed economiche, sconvolto dai più recenti fenomeni di “scomposizione regionale” del mondo[4] e “ri-statualizzazione delle relazioni internazionali”.[5] Gli Stati Uniti, “custodi” della costituzione globale, hanno gradualmente cessato di fungere da Egemone, cioè da “Grande Definitore della comunità internazionale”, da giudice capace di compilare e aggiornare “vere e proprie liste di proscrizione della pace comune”, suddividendo gli Stati in quasi-States, failed States, rougue States, ecc.[6]
Anzi, nel corrente “smottamento della piramide di potere” globale[7] gli Stati Uniti diventano parte integrante dell’entropia internazionale, con nuove promesse di infrazioni di regole, imposizioni di dazi verso alleati tradizionali, e repentini valzer diplomatici. Cionondimeno, Colombo registra la persistenza di una pigrizia cognitiva di fondo, che vizia le prospettive analitiche e politiche occidentali, e che è foriera di una nuova bi-polarizzazione del mondo secondo “rappresentazioni inconciliabili” tra loro: da un lato, quella di contrapposizione tra democrazie ed autocrazie, che suggerisce l’astoricità e decadenza del mondo non-occidentale come blocco non-democratico; dall’altro, quella di una contrapposizione “fra un’egemonia occidentale in declino e la marea montante dei paesi non occidentali in ascesa”,[8] che insiste – per contro – sul limite storico di sostenibilità dell’ordine internazionale liberale. Dalla “stanchezza di Atlante” al “Titanic”, nella letteratura internazionalistica sono state numerose le metafore impiegate per raffigurare questa duplicità di rappresentazioni contraddittorie.
E, in realtà, la contraddittorietà dei fenomeni caratterizza più aspetti dell’ordine post-bipolare, che l’autore lucidamente rileva: il periodo di massima espansione della globalizzazione ha coinciso con la moltiplicazione dei confini, con l’aumento di circa il 50% delle frontiere in Europa tra il 1990 e il 2000;[9] la fine della politica delle grandi potenze – più proclamata che praticata – ha paradossalmente acuito i problemi di sicurezza degli Stati democratici, con l’adozione di “misure sempre più anticipate di dissuasione o prevenzione”;[10] o, ancora, il nuovo “mondo senza confini” non ha impedito, ma ha anzi incoraggiato, un diritto allo sconfinamento, con un nucleo di Stati liberali sempre più “rinchiusi” verso l’esterno, e una serie di Stati periferici “privati in partenza dello schermo politico e giuridico della statualità”,[11] passibili cioè di misure coercitive da parte di attori con ‘giusto titolo’ all’uso della forza.
Ed è forse proprio qui, attorno al problema della guerra, che il sismografo dell’analista internazionale registra le scosse più importanti per la tenuta dell’ordine post-liberale. All’interno della governamentalità liberale la guerra è stata concepita come un elemento estraneo alla pax mercatoria, un fattore turbativo dell’autogoverno del mercato, che richiedeva alla politica e al diritto un ruolo soltanto ancillare. Si innescò così – come rilevato anche da Alfredo D’Attorre nel suo Metamorfosi della globalizzazione (Laterza, 2023) – un duplice processo di “spoliticizzazione dell’economia” da un lato, e di “moralizzazione del diritto”[12] dall’altro, a cui si aggiunse anche – come traspare dalle pagine di Colombo – una trasformazione “impolitica” della guerra:[13] il fenomeno bellico cessò di essere inteso come relazione bilaterale tra pari,[14] per divenire “operazione chirurgica”, ovvero azione unilaterale di un agente su un paziente, priva della tradizionale relazione simmetrica duellanti.[15]
Il presupposto della guerra liberale, infatti, era proprio “il confinamento spaziale e temporale della violenza”,[16] che ha permesso di giustificare la continuità della violenza soltanto ai margini dell’Heartland liberale-occidentale, nelle sue periferie africane, centro-americane o mediorientali. Con l’aggressione russa all’Ucraina, invece, la guerra ha perso quel “contrassegno per eccellenza della perifericità”[17] che la caratterizzava fintantoché vigeva l’ordine liberale. E non è un caso che la guerra ritorna ad avere una centralità nella vita occidentale proprio in un momento storico segnato dalla “trasformazione irreversibile dei rapporti tra Occidente e Mondo”.[18]
Con il declino dell’ordine liberale occidentale anche la guerra perde il carattere di misura asimmetrica extra-europea e si trasforma – o ritorna ad essere – l’azione bilaterale tra attori statuali, con tutti i relativi costi materiali, morali e reputazionali più classici che avevano caratterizzato gli scontri militari più convenzionali. Il fenomeno bellico torna ad essere vera guerra, cioè non più una forma di conflittualità short of war (cioè sotto la soglia proclamata, appunto, della guerra). E in questo ‘ritorno al futuro’ si celano le incognite metamorfosi della guerra e del diritto internazionale del XXI secolo, che disorienta tanto gli studiosi quanto gli osservatori profani della politica globale.
Metamorfosi che non può essere più spiegata, in modo autoreferenziale, con la crisi dell’ordine liberale sotto la pressione di forze soltanto esogene (il revisionismo russo o cinese, le fake news anti-occidentali), ma che è causata anche – e forse ancora prima – da “problemi endogeni”[19] più strutturali al sistema internazionale post-bipolare. Una dissoluzione di ordine che muoverebbe dalle premesse insostenibili in ambito economico-sociale e politico-militare poste negli anni ‘90, all’insegna di quell’escatologia euro-atlantica che trovò espressione in un “trionfalismo anacronistico, culturalmente narcisistico e politicamente arrogante”,[20] di cui il volume di Colombo offre una storia e una critica.
Un libro che a partire dal suo sottotitolo “Perché l’ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024)”, in realtà, può forse suggerire una chiave di lettura dell’attuale momento storico più ampia di quanto non suggerisca il titolo stesso. Perché in fondo la pace, così come la guerra – come insegnava Robert Gilpin con perdurante attualità – sono sempre una funzione del mutamento nella politica internazionale.
[1] A. Colombo (2025). Il suicidio della pace. Perché l’ordine internazionale liberale ha fallito (1989-2024), Milano: Raffaello Cortina Editore, p. XIV.
[2] Ivi, p. 9.
[3] Ivi, p. 92.
[4] Ivi, p. 199.
[5] Ivi, p. 217.
[6] Ivi, p. 136.
[7] Ivi, p. 189.
[8] Ivi, p. 253.
[9] Ivi, p. 113.
[10] Ivi, p. 94.
[11] Ivi, p. 97.
[12] Ivi, p. 82.
[13] Ivi, p. 120.
[14] Ivi, p. 82.
[15] Ivi, p. 115.
[16] Ivi, p. 112.
[17] Ivi, p. XI.
[18] Ivi, p. XIII.
[19] Ivi, p. 186.
[20] Ivi, p. XIII.