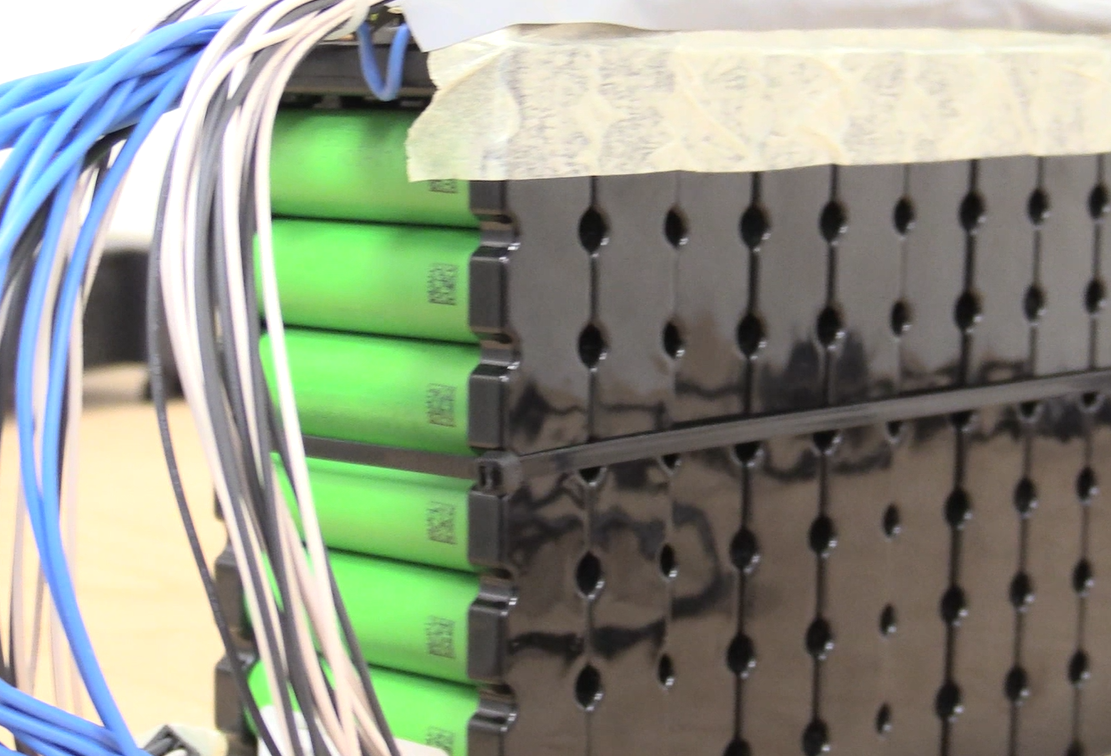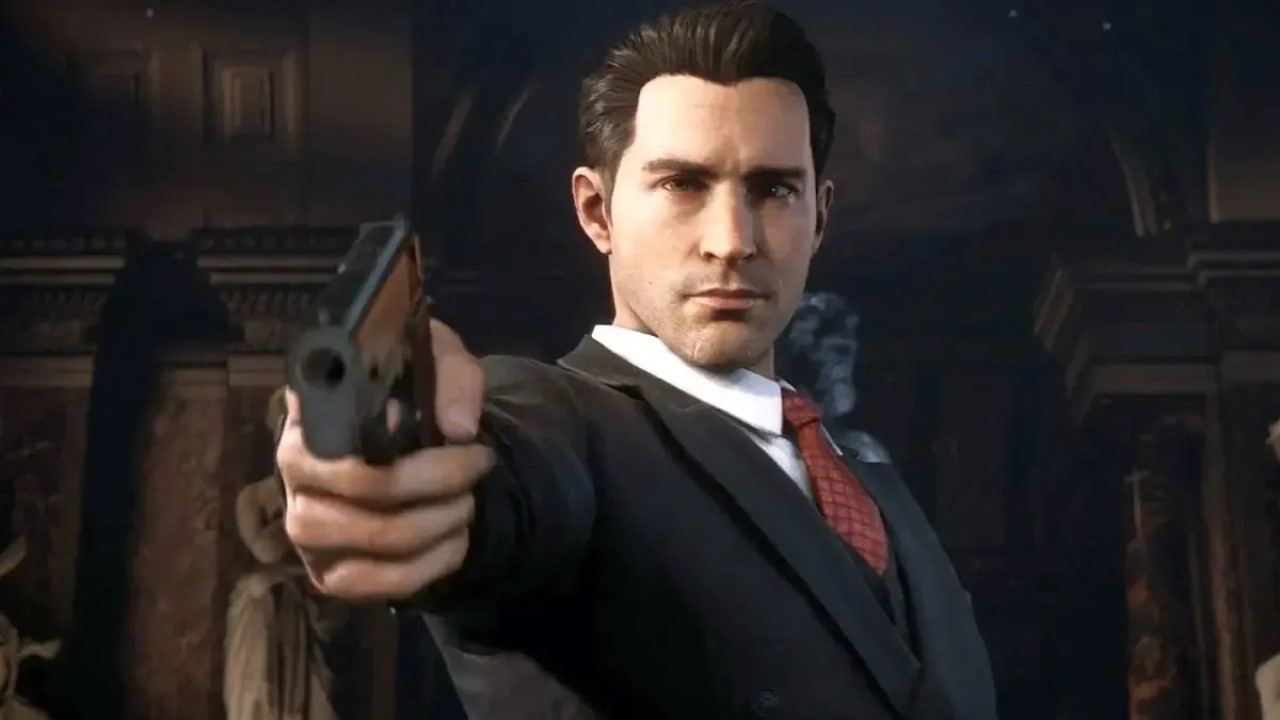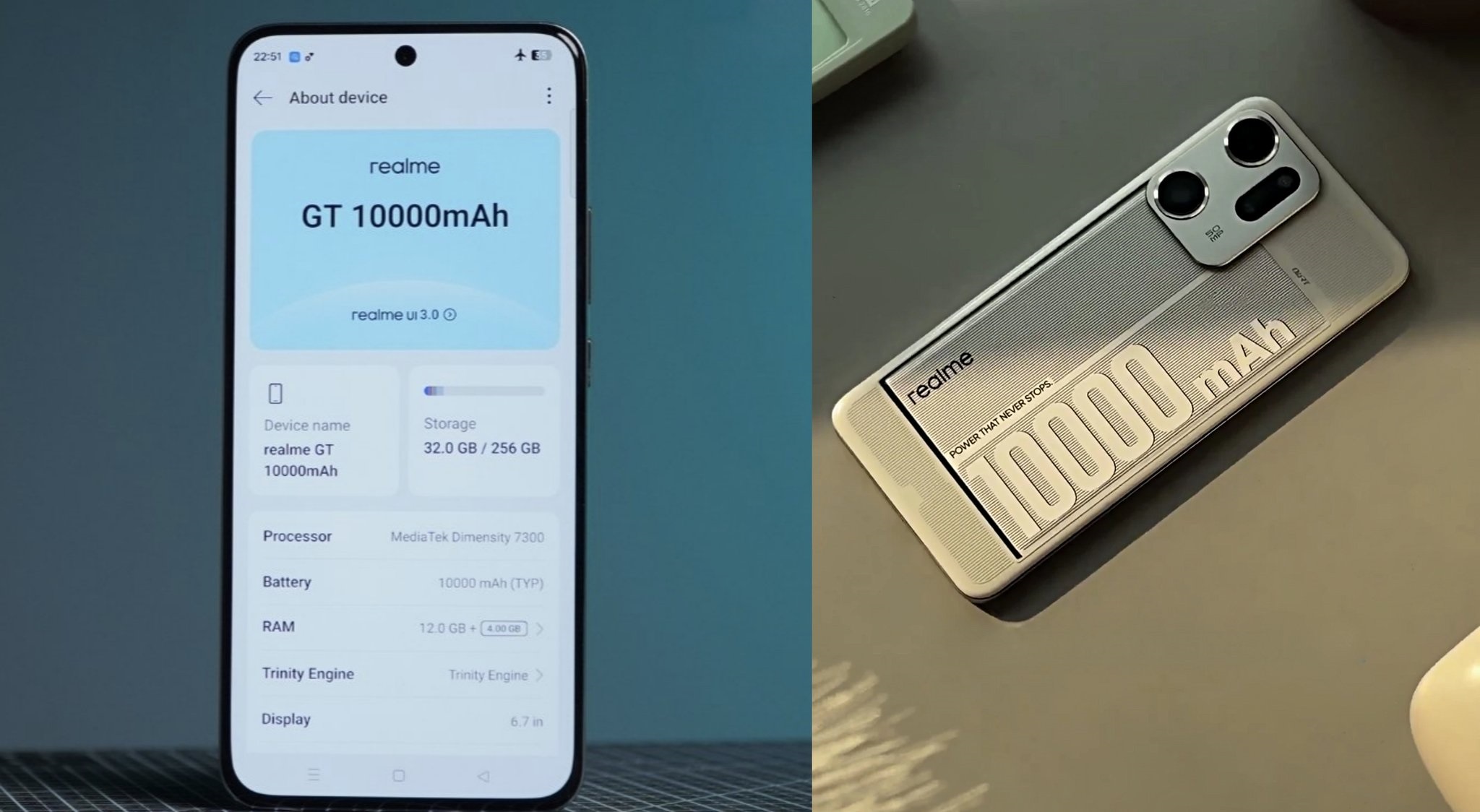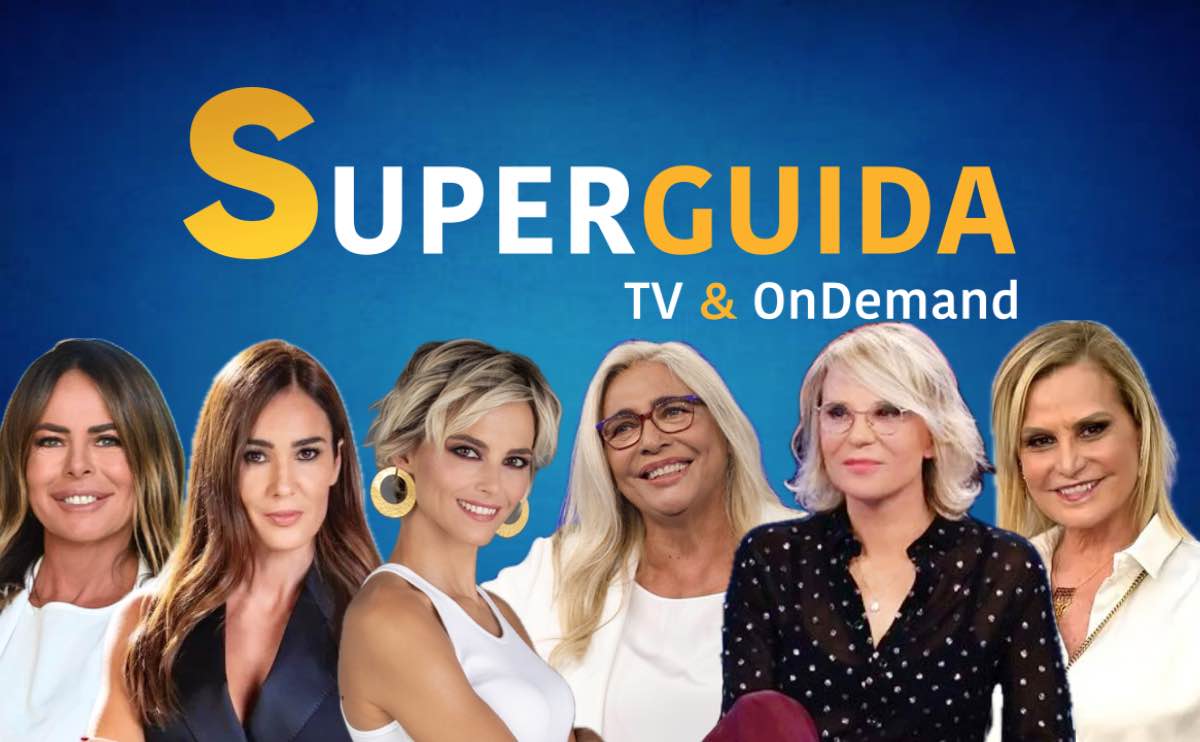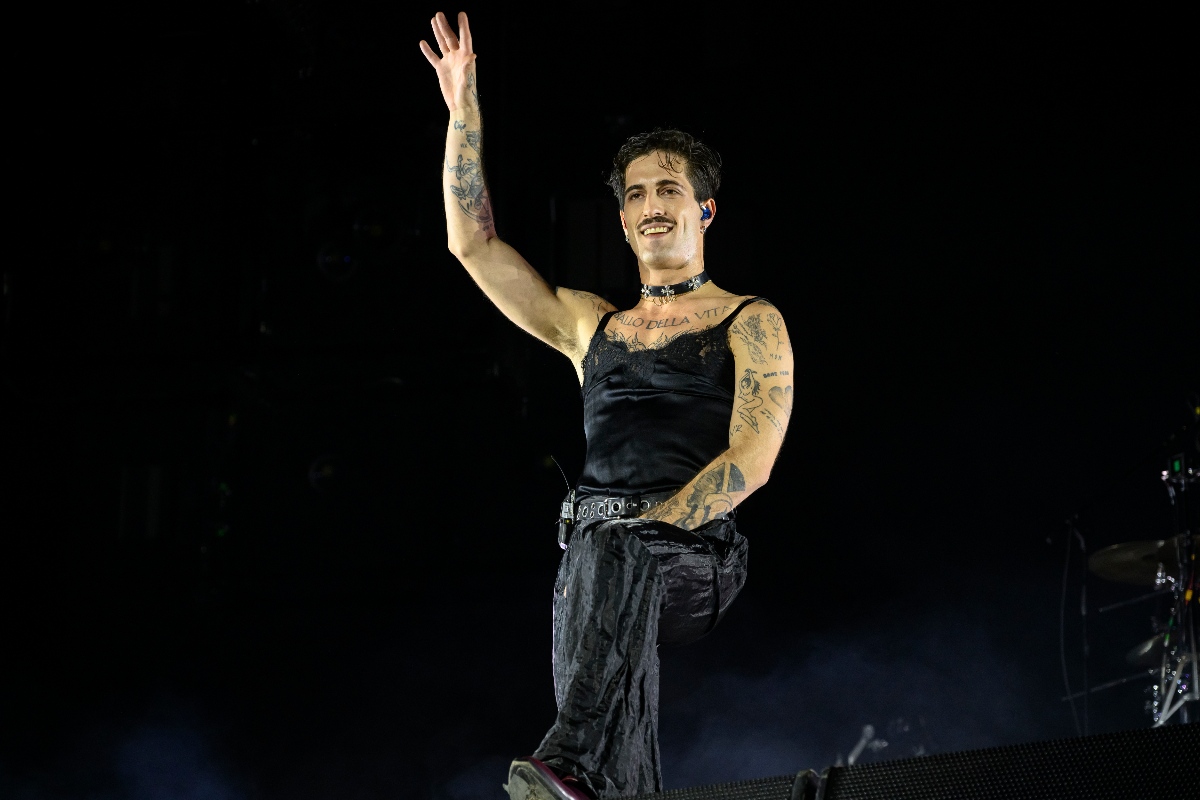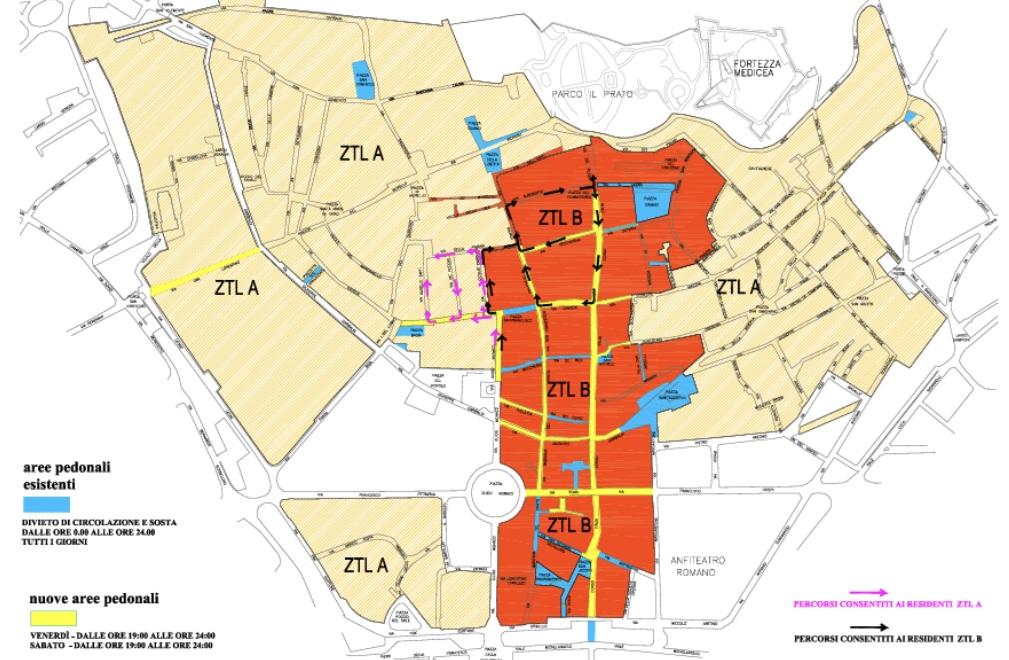Bobby Sands: memorie dall’Irlanda del Nord
Il 5 maggio 1981 moriva, dopo sessantasei giorni di sciopero della fame, Bobby Sands. The Irish Press riportava le sue ultime parole, indirizzate al padre John Magee, prelato inviato direttamente […]

Il 5 maggio 1981 moriva, dopo sessantasei giorni di sciopero della fame, Bobby Sands. The Irish Press riportava le sue ultime parole, indirizzate al padre John Magee, prelato inviato direttamente dal papa nel tentativo di dissuadere Sands dallo sciopero: “Non penso ci rivedremo, così, arrivederci! Spero però di vederti ancora”[1].
La lotta di Sands riguardava il riconoscimento dello status di prigioniero politico per sé e i suoi compagni dell’IRA, rinchiusi nel carcere di Long Kesh a Belfast.
Si calcola che nel famoso periodo dei Troubles, in Irlanda del Nord, nel cuore del civilissimo Occidente, siano morte all’incirca tremilacinquecento persone.
Sarebbe troppo complesso andare ad indagare le motivazioni della lotta armata e stabilire se questa sia stata una sorta di movimento risorgimentale, una lotta nazionalista di un intero popolo o di una frangia estremista, al limite del terrorismo, o ancora, più semplicemente, il moto spontaneo di un popolo che desiderava solo autodeterminarsi, definendo da sé le proprie istituzioni politiche. Sarebbe ancora più complesso, forse, stabilire in che misura si sia trattata di una guerra civile tra la parte indipendentista e cattolica e quella protestante e lealista. La figura di Sands, però, mostra in filigrana i valori profondi in cui credevano gli irlandesi in rivolta.
Bobby si trovò a vivere nella Belfast del dopoguerra ed a constatare nella propria quotidianità le angherie e i soprusi subiti dalla comunità cattolica. Decise presto di non accettare lo stato delle cose e di arruolarsi nell’IRA: ‹‹Avevo visto troppe case distrutte, padri e figli arrestati, amici assassinati. Troppi gas, sparatorie e sangue, la maggior parte del quale della nostra stessa gente. A 18 anni e mezzo mi unii all’IRA››.
Sebbene non avesse sparato alcun colpo, venne presto incarcerato. Dal 1976, infatti, i militanti dell’IRA erano stati declassati dal governo britannico a semplici criminali, seguendo la strategia politica della criminalizzazione del movimento indipendentista irlandese. Il suo scopo era la piena delegittimazione degli oppositori politici, smentendo l’esistenza stessa di una questione politica in Irlanda. La strategia della criminalizzazione implicava di fatto quella della repressione violenta: una volta ridotti a semplici terroristi, i membri dell’IRA non costituivano un vero e proprio gruppo politico che avanzava delle istanze in attesa di riconoscimento, bensì appena un branco armato e arrabbiato, dinanzi al quale l’unica difesa possibile era costituita dalla soppressione violenta.
La lotta di Bobby Sands e degli altri hunger strikers che scioperarono in seguito getta, al riguardo, una prospettiva del tutto diversa: la richiesta del riconoscimento dell’intrinseca politicità della propria lotta apre, di fatto, la possibilità di una trattativa, di una lotta alternativa a quella armata. Infatti, nel momento stesso in cui le proprie istanze vengono riconosciute come politiche, ci si propone come possibili partner con cui intavolare un dialogo. Il sacrificio avvenuto nei blocchi H di Long Kesh non rappresentava soltanto la determinazione e la fedeltà dei militanti dell’IRA alla propria causa, ma costituiva anche un disperato tentativo di costruire una via politica alternativa. Lo sciopero della fame dei detenuti si proponeva, allo stesso tempo, di amplificare e far conoscere la situazione nordirlandese in tutto il mondo e, dunque, di operare una sorta di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sia nazionale che internazionale.
Era doveroso anche far conoscere le disumani condizioni di prigionia dei detenuti di Long Kesh. Sands le ha documentate su pezzi di carta igienica, su mezzi di fortuna, in quanto gli erano negati i più elementari diritti. Le vessazioni e le torture subite dai militanti dell’IRA in quel periodo restano tuttora una vergogna della politica britannica. È del 2021 una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che condanna la polizia nordirlandese per aver torturato e agito illegalmente contro quattordici detenuti dell’IRA[2]. Il processo è ancora in atto e riguarda soltanto un’infima parte di tutti i casi sospetti di violenza.
Amnesty International si interessò sin da subito a questo fenomeno, cercando di promuovere inchieste sulla condizione dei detenuti in Irlanda del Nord. Dall’agosto del 1971, quando fu introdotto l’internamento senza processo, ci fu un’impennata di arresti: già il 9 agosto, giorno dell’introduzione ufficiale della misura, nelle sei contee dell’Ulster furono arrestate 342 persone[3]. Su pressione di Amnesty International, il governo inglese fu costretto ad aprire un’inchiesta: qualche mese più tardi, così, rese pubblico il Compton Report. Si trattava di un documento che cercava di negare l’esistenza di torture psicologiche e fisiche nelle carceri nordirlandesi. Nel rapporto si legge che gli estenuanti sforzi fisici cui erano sottoposti i detenuti ‹‹avevano lo scopo di contrastare il freddo››; mentre i lunghi periodi passati in piedi contro il muro erano ‹‹una misura di sicurezza contro la violenza fisica, sia per gli internati che per gli agenti di polizia››[4]. Tuttavia, l’aspetto più contorto del resoconto consisteva in un parziale riconoscimento delle efferatezze compiute ai danni dei militanti dell’IRA, che, però, secondo il rapporto, non avrebbero costituito una vera e propria tortura in quanto non avrebbero implicato il coinvolgimento emotivo di chi le aveva inflitte[5].
Il report fu ovviamente criticato da cima a fondo e il governo inglese corse ai ripari promettendo una nuova inchiesta. Intanto, nel 1973 venne approvato l’Emergency Provision Act, il quale legalizzava il fermo di polizia fino a 72 ore e introduceva le Diplock Courts, ossia, piccoli tribunali speciali, formati da un solo giudice e privi di giuria. Si trattava del modo in cui il governo inglese cercava di mascherare gli internamenti senza processo, un vero e proprio scandalo nel civilizzato Occidente, patria dello Stato di diritto. Si assicurava, così, ai detenuti quantomeno un processo farsa.
Nel gennaio 1975 venne diffuso il responso della nuova inchiesta, il Gardiner Report, il quale non si limitava a sminuire le gravi vessazioni subite dai detenuti, ma esprimeva forti perplessità nei confronti dello status di prigioniero politico, raccomandandone la cancellazione[6]. Ed è esattamente quello che accadde qualche mese dopo: il 1976 segnò una data molto importante nella storia del conflitto, poiché sancì una presa di posizione netta nei confronti dei rivoltosi da parte del governo britannico. Fu questa misura che diede luogo a diverse forme di protesta; innanzitutto, ci fu la cosiddetta blanket protest: i detenuti irlandesi scelsero volontariamente di non indossare la divisa dei detenuti comuni, coprendosi con la sola coperta. Si trattava di un piccolo atto di disobbedienza, di un tentativo di resistere alla riduzione allo status di criminale.
La testimonianza di Sands, che iniziò presto la forma di protesta più drammatica, quella della fame, offre un fulgido spaccato sull’alto valore umano e comunitario di quella lotta. Il suo diario, ricostituito dai tanti foglietti svolazzanti della propria cella, narra episodi di una dignità umana pari ad alcuni brani di Viktor Frankl sull’inesausta ricerca di senso dell’essere umano anche nei luoghi più funesti e angosciosi.
Desta commozione e stupore il racconto delle lezioni di gaelico che i detenuti si impartivano a vicenda durante il pranzo o la cena, quando i secondini erano impegnati a mangiare e i prigionieri potevano gridare a squarciagola dalla propria angusta cella: ‹‹“Lezioni di gaelico”, dissi di nuovo. Suonava piuttosto strano e lo era veramente. Significava infatti stare contro la porta della cella ad ascoltare un tuo compagno, l’insegnante con quanta voce aveva in gola, una volta che i secondini se n’erano andati via per il pranzo o per la cena››[7]. Ciò accadeva al termine di giornate in cui erano spesso torturati, umiliati, abbandonati al freddo delle proprie celle. Le lezioni di gaelico rappresentavano l’introiezione di un altrove di senso nel luogo stesso dell’insensato, una sospensione spaziale e temporale in cui rifugiarsi per rifuggire il terrore della lotta.
Non si trovano in quelle pagine piani di vendetta, ma la consapevolezza fredda e lucida dell’esistenza di una questione spietatamente politica. Scrive infatti Sands:
‹‹Sono un prigioniero politico. Sono un prigioniero politico, perché sono l’effetto di una guerra perenne che il popolo irlandese oppresso combatte contro un regime straniero, schiacciante, non voluto, che rifiuta di andarsene dalla nostra terra. Io difendo il diritto divino della nazione irlandese all’indipendenza sovrana, e credo in essa, così come credo nel diritto di ogni uomo e donna irlandese a difendere questo diritto con la rivoluzione armata. Questa è la ragione per cui sono carcerato, denudato, torturato››[8].
Le pagine di Sands non danno sfogo all’odio, anzi si rammaricano del fatto che sia proprio questo ‹‹il frutto che la Gran Bretagna ha seminato››. Egli scrive: ‹‹Penso all’unica interruzione nella monotonia: i quaranta minuti che passo alla messa ogni domenica – “porgi l’altra guancia”, “ama il prossimo tuo” – e mi chiedo perché con il passare dei mesi sia cresciuta quell’amarezza dentro di me. Un odio così intenso che mi fa paura. Lo vedo anche nelle facce dei miei compagni alla messa; vedo l’odio nei loro occhi. Un giorno questi giovani diventeranno padri e questo odio sarà trasmesso inevitabilmente ai loro figli››[9].
Si percepisce nelle parole di Sands un profondo rammarico che riguarda anche il misconoscimento profondo della bellezza delle istanze per cui lui e i suoi compagni stanno lottando: ‹‹La parola del poeta canta dolce come un uccello, / Un racconto, una romantica prosa. / Di stelle lassù e amore gentile / E vento fragrante che spira. / Ma mai una riga scrivono / Della bellezza di ferite lacerate. / Non chiedetevi perché quelle penne s’arrestano / Poeti più non ci sono››[10].
Poeti più non ci sono – poiché nemmeno l’arte è più in grado di veicolare un valore superiore, di cantare un sogno per cui valga la pena “lacerarsi di ferite”.
Lo stesso Bobby Sands resta una ferita profonda nella storia recentissima dell’Irlanda del Nord: testimone di un periodo storico che attende ancora un adeguato riconoscimento e una profonda elaborazione collettiva.
Alle nostre orecchie, invece, risuonano tristemente attuali le tematiche dell’emergenza continua, della sospensione di normali diritti civili e sociali in nome di un’incombente emergenza, della criminalizzazione del dissenso e della sordità delle istituzioni governative alle istanze avanzate da una cospicua parte delle popolazioni.
[1] Articolo disponibile all’indirizzo: https://posc284.posc.sites.carleton.edu/wp-content/uploads/2023/05/Irish-Press-1931-1995-Tuesday-May-05-1981.pdf
[2] Articolo disponibile all’indirizzo: https://www.amnesty.it/in-irlanda-del-nord-linchiesta-sulle-torture-degli-anni-settanta-andra-avanti/
[3] Cfr, S. Calamati, 1971-1981. Dall’internamento agli scioperi della fame: cronologia dal carcere, in B. Sands, Un giorno della mia vita, trad. it. di S. Calamati, Feltrinelli, Milano 2023.
[4] Ivi, p. 119.
[5] Ibid.
[6] Ivi, p. 134.
[7] B. Sands, Un giorno della mia vita, trad. it. di S. Calamati, Feltrinelli, Milano 2023, p. 25.
[8] Ivi, p. 93.
[9] B. Sands, Scritti dal carcere. Poesie e prose, a cura di R. Michelucci e E. Terrinoni, Edizioni Paginauno, Vedano al Lambro 2020, p. 55
[10] Ivi, p. 93.