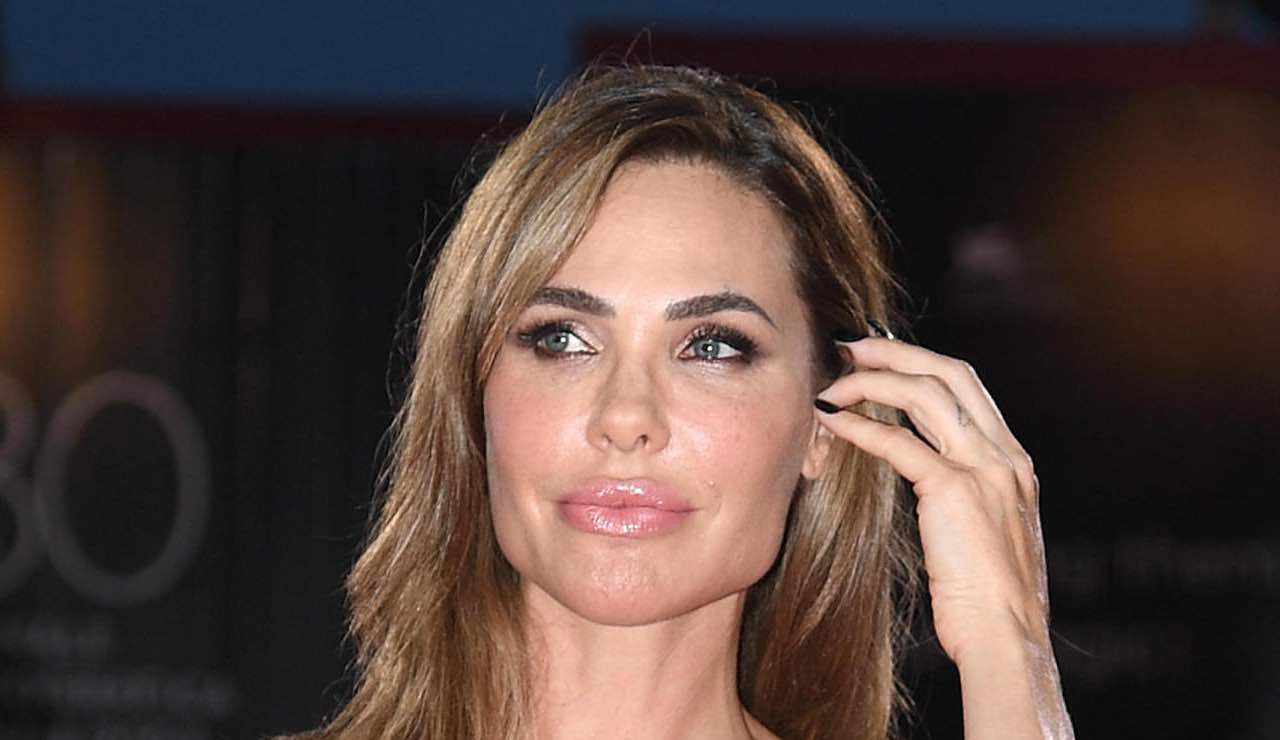Adolescence confonde e non offre soluzioni
Cosa ci lascia la visione di Adolescence, la serie di cui tutti parlano? Ne usciamo fortificati per affrontare le sfide dei nostri tempi, per sostenere le giovani generazioni ed entrare […]

Cosa ci lascia la visione di Adolescence, la serie di cui tutti parlano?
Ne usciamo fortificati per affrontare le sfide dei nostri tempi, per sostenere le giovani generazioni ed entrare in comunicazione con loro, oppure ancora più lontani da loro e rassegnati?
La serie tv campione di visualizzazioni ha dei meriti: la recitazione è eccellente, la regia ti catapulta letteralmente dentro la scena e certamente porta grande attenzione al fenomeno del disagio giovanile e alla violenza come una delle sue declinazioni. Ma quali strumenti propone allo spettatore? Quale percorso lo accompagna a compiere?
Il cinema di denuncia sociale, il cinema impegnato dovrebbe essere per definizione educativo. Dovrebbe offrire una via possibile, un’opportunità di cambiamento e questo Adolescence non lo fa. Non lo fa perché non ci fa capire, non ci consente di empatizzare con l’accusato. Non ci fa realmente avvicinare alla sua sofferenza, non ce ne fa comprendere le origini. Siamo dentro la scena – è vero – ma nella scena non traspare umanità. Il ragazzino raccontato dagli sceneggiatori non è credibile, non è coerente nella tragedia che vive e lo si intuisce bene nella puntata dedicata al colloquio con la psicologa inviata dal tribunale. Durante l’incontro, infatti, Jamie dimostra un’abilità di lettura emotiva e una maturità comunicativa tale da permettergli di mettere sotto scacco la psicologa che lo sta valutando. Ciò è difficilmente compatibile dal punto di vista psicologico con il tipo di crimine di cui è accusato un ragazzino di quell’età. Gli sceneggiatori ce lo fanno apparire come un alieno, lontano e irraggiungibile, al livello di un serial killer da romanzo giallo.
L’atto efferato di cui è accusato è infatti anche necessariamente figlio di un’incapacità relazionale, dell’impossibilità di raggiungere l’altro e di sentirlo, derivante da una difficoltosa se non pressoché inesistente intelligenza emotiva. Emblematico a questo proposito è il caso dell’omicidio di una ragazza di quattordici anni da parte di tre coetanei, avvenuto in Sicilia nel 2008: dopo essere stati scoperti e aver ammesso le loro colpe, si sono alquanto stupiti di essere stati arrestati, poiché credevano sinceramente che non ci sarebbero state conseguenze alla loro azione. Questo caso mostra chiaramente la componente di dissociazione emotiva e cognitiva legata, nella maggior parte dei casi, a queste gesta, che chi lavora nel settore penale minorile conosce bene e che la serie Adolescence non è affatto in grado di inquadrare. Positivi i rimandi agli effetti deleteri dei social, alla crisi dell’istituzione scolastica (seppur estremizzata), alla crescente incapacità di sopportare le frustrazioni. Ma non sufficienti, poiché il protagonista, se non per un attimo durante la telefonata ai genitori dell’ultima putata, non è realistico nel suo profilo psicologico e dunque ci confonde e ci impaurisce; così come confonde e impaurisce il titolo della serie che collega implicitamente un caso estremo di violenza all’età dell’adolescenza in generale.
Molto più efficace e suggestiva è invece la narrazione della figura del padre, o dei padri, e delle loro sfide, così come l’incontro tra l’agente di polizia e il proprio figlio nella scuola dove si stanno svolgendo le indagini. Le parole del papà sono dense di significato, quando – nell’ultima puntata – riesce finalmente a dire “non riuscivo a guardarlo”. È proprio questa, infatti, la chiave, il punto di partenza per sostenere i giovani oggi. In una società sempre più fragile, colma di insidie e priva di punti di riferimento, i genitori si sentono abbandonati dalle istituzioni nel loro compito educativo e la paura li porta a volgere lo sguardo altrove, a non porre i limiti necessari per la loro evoluzione. I figli, sicuramente amati, coccolati e ricchi di opportunità, non si sentono però visti, non si sentono riconosciuti e dunque non trovano la forza e la dignità necessarie per crescere e incontrare l’altro.