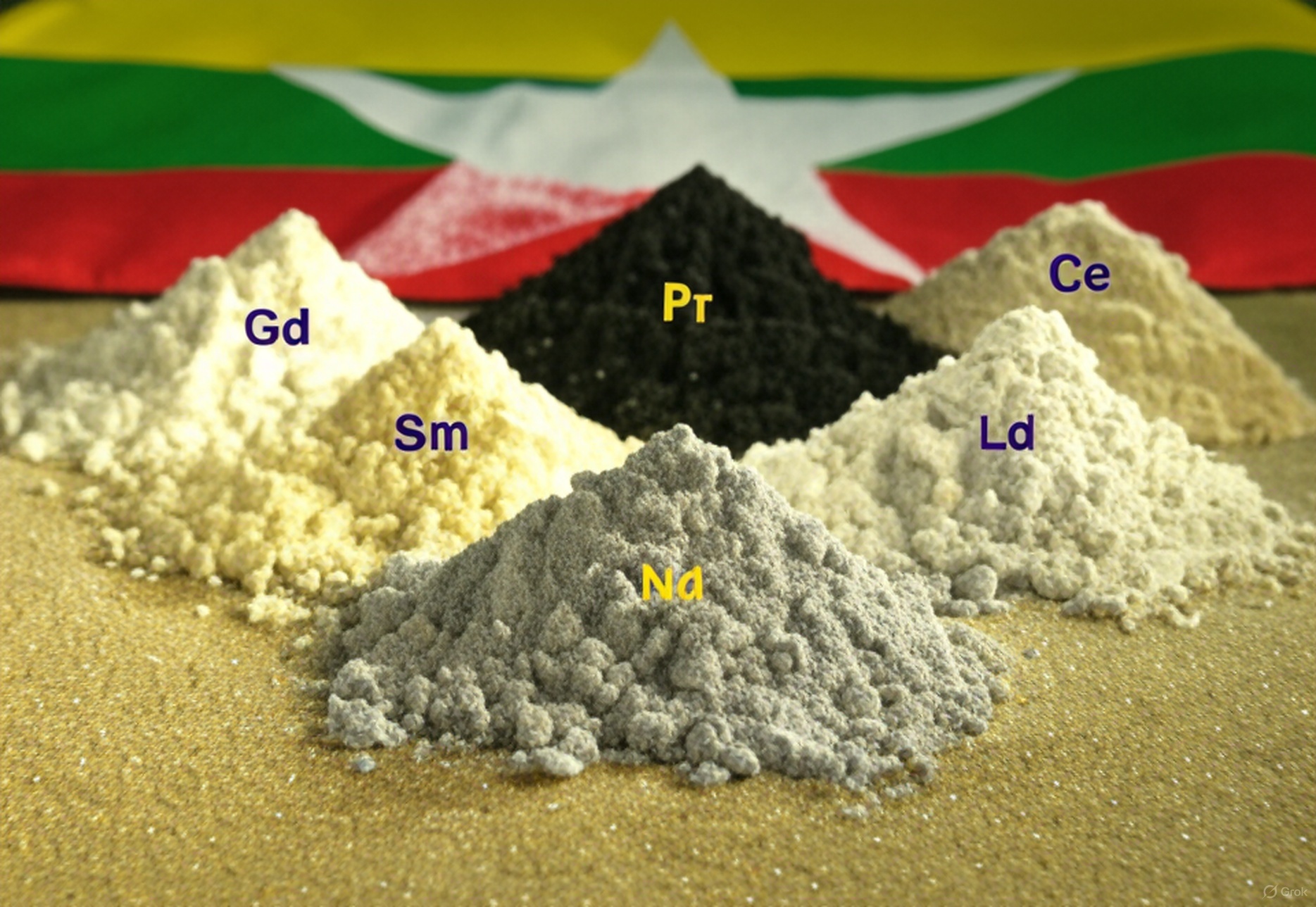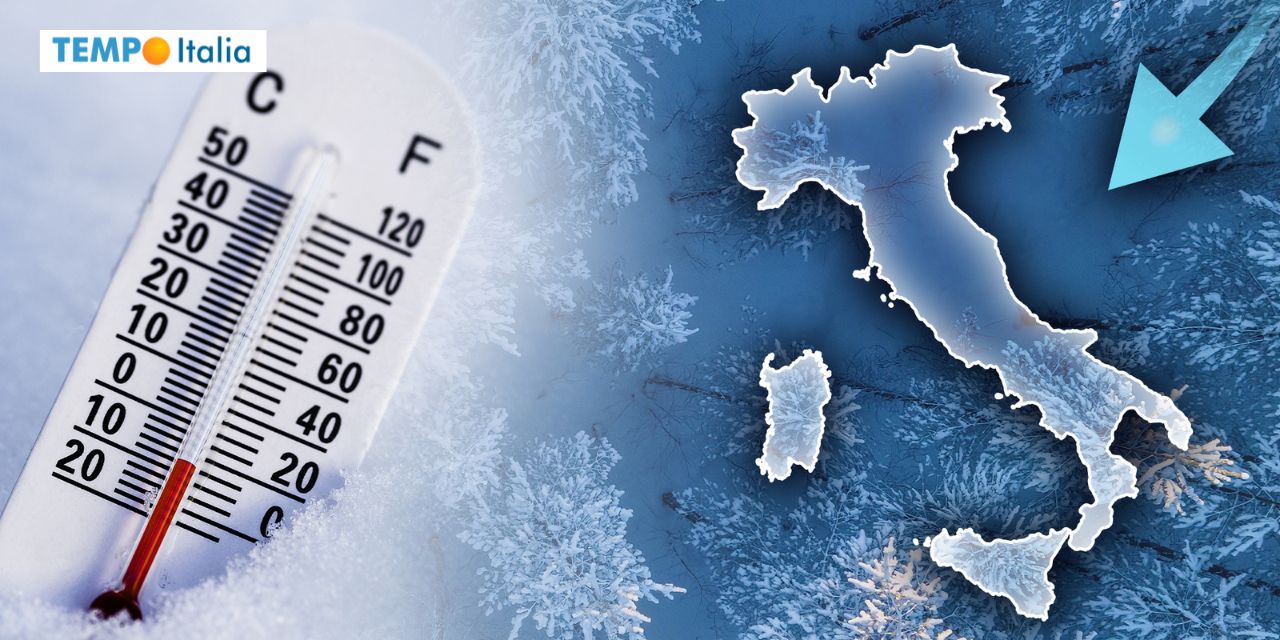Su Oppenheimer di Christopher Nolan
Il film Oppenheimer racconta alcuni momenti nella vita dello scienziato a capo del progetto Manhattan, che portò all’invenzione della bomba atomica. L’ho visto in uno dei primi giorni di uscita, […]

Il film Oppenheimer racconta alcuni momenti nella vita dello scienziato a capo del progetto Manhattan, che portò all’invenzione della bomba atomica. L’ho visto in uno dei primi giorni di uscita, a luglio del 2023, in una sala strapiena. Durante la proiezione, messo alla prova dalla sovrabbondanza di dialoghi montati a ritmo implacabile, distoglievo talvolta lo sguardo dallo schermo per rivolgerlo accanto a me e dietro. Il resto del pubblico, composto quasi esclusivamente di persone fra i sedici e i venticinque anni, era estremamente attento e coinvolto, a occhi spalancati. Si sarebbe detto che tra quegli sguardi e il film s’intrattenesse una corrispondenza nascosta. Cos’era che li catturava? La forza inerziale dell’evento Barbenheimer[1]? Il lusso audiovisivo? La concitazione forzata degli stacchi di montaggio? O era il tema della minaccia atomica, di cui forse comprendevano d’istinto la gravità e l’urgenza?
Nei mesi precedenti l’uscita, la massiccia campagna pubblicitaria del film aveva diffuso soprattutto anticipazioni su come si sarebbe ricostruito il test Trinity, quello in cui per la prima volta gli scienziati del progetto Manhattan osservarono nella pratica gli effetti dell’esplosione nucleare. La stampa enfatizzava il virtuosismo del regista Nolan il quale, ostinandosi a non usare effetti visivi digitali, costringeva i suoi collaboratori a trovare soluzioni per la messa in scena del test con l’uso di practical effects. Finì per circolare la voce, ritenuta attendibile da molti fan e in seguito definita dallo stesso Nolan “lusinghiera e terrificante”, che il regista avesse fatto detonare una piccola atomica sul set.
Ovviamente non era vero e anzi l’esplosione che abbiamo poi visto nel film era piuttosto deludente: grossa e spettacolare, ma niente a che vedere per forma e scala con il referente reale; in effetti anche su altri piani del discorso filmico la bomba rimaneva un elemento opaco, scotomizzato, paradossalmente inesplorato pur essendo l’oggetto principale di azioni, attenzioni e dialoghi dei personaggi. La bomba c’era, esplodeva, ma qualcosa (un buco nero?) impediva alla sua luce di raggiungere le facoltà di elaborazione dello spettatore, e così impediva alla stessa esistenza della bomba di porsi come la questione storica, morale, politica che in effetti rappresenta. Come mai?
Bisogna rilevare che il film è programmaticamente, puntigliosamente innestato sul punto di vista del suo protagonista, lo scienziato. Nolan lo rivendica nelle interviste: “I started to get very excited about […] telling the actual reality of the story, really trying to be there, to give people the experience of what it would have been like to be Oppenheimer in those moments”[2]. Questa è una caratteristica riconducibile allo spirito del tempo, e in particolare alla natura dello spettacolo nel nostro tempo: lo spettatore si deve immedesimare. La narrazione, sulla scia di videogiochi e realtà virtuale, si approssima alla simulazione: protetto e accudito nel suo ruolo di osservatore, il pubblico viene calato in una situazione e le sue emozioni adeguatamente stimolate. Esperienza, dunque, non interpretazione di un testo. Regna sovrana la cosiddetta (e tanto citata negli ultimi anni) “sospensione dell’incredulità”. Ogni tentativo di straniamento rischia di passare per mancanza di efficacia e di professionalità, incapacità di coinvolgere. Di un film si valutano i valori produttivi, si giudica l’apporto dei vari reparti tecnici e si dice se è fatto bene, se funziona (non si discute di come funziona). Tutto ciò, applicato alla biografia di uno degli uomini che hanno reso possibili i massacri di Hiroshima e Nagasaki, provoca dei cortocircuiti.
Il rischio dell’escalation nucleare, questione collettiva per eccellenza, e che anzi riguarda l’umanità nella sua interezza, viene esplorata in una dimensione perlopiù emotiva e di responsabilità individuale (nello stesso modo in cui la propaganda liberista ha trattato per anni il degrado ambientale del pianeta o la diffusione endemica della depressione). Ne risulta uno spostamento determinante: la questione non è “che ne facciamo della bomba?”, ma “che ne facciamo di quest’uomo?”. Sarà stato un marito fedele? Sarà stato un comunista? Sarà stato vanitoso? Sarà stato manipolato? Si sarà pentito?
Cillian Murphy nel ruolo di Oppenheimer mostra i segni del dissidio interiore in grandangoli via via più estremi, che lo isolano dal contesto, lo fanno quasi affacciare dallo schermo a mostrarci gli occhi sempre più strabuzzati, che fissano il vuoto con angoscia. La focalizzazione interna si spinge fino a farci entrare nella testa di Oppenheimer, mostrandoci le sue visioni ricorrenti: fasci di energia, particelle, tempeste subatomiche (ed è interessante che sul piano dell’inorganico la messa in scena si dimostri ben più felice e inventiva di quando ha a che fare con l’umano).
Noi che guardiamo siamo dunque Oppenheimer, uomo difettoso ma integro, essenzialmente buono, manipolato dall’esercito, vessato dalla politica, incastrato nella Storia per eccesso di buona fede. Il veterano Einstein, che nel film non è un personaggio ma un incorporeo riflesso d’idealismo malinconico sorpassato dai tempi, è il solo che prende sul serio i tormenti del padre della bomba: per il resto, quando Oppenheimer inciampa in una questione morale o tecnica che imporrebbe un ripensamento, c’è sempre qualcuno nelle vicinanze che lo esorta a essere “pragmatico”, che gli ricorda il pericolo nazista, che si congratula per le vite che la sua bomba ha salvato. Fino all’incontro col grande consolatore, il presidente Truman. In una scena piuttosto brutale, Oppenheimer gli confida che sente di avere le mani sporche di sangue: Truman, sprezzante, gli porge simbolicamente il proprio fazzoletto e prende per sé la responsabilità delle bombe sul Giappone, lasciando allo scienziato un’irrilevanza desolante che, però, è anche una qualche forma d’innocenza. Si direbbe che il film ci autorizzi a considerare gli scrupoli di Oppenheimer come inessenziali alla marcia della Storia: un lusso nobile che non cambia nulla, utile tutt’al più a testimoniare della bontà d’animo sua, e dunque nostra. Insomma: “Grazie, Occidente!”, per aver innervato i tuoi necessari massacri con la giusta dose di senso di colpa che si deve alla tua bontà.
Oppenheimer era nei cinema in un momento intermedio fra il febbraio del 2022 e l’ottobre del 2023. A vederlo oggi, e cedendo a una punta di crudeltà interpretativa, il film sembra l’effetto di un impulso di autoassoluzione. Un film sotterraneamente connesso a una società in cui si può ammettere di essere vittime, complici; ma mai responsabili o colpevoli. Un film adeguato a un’epoca in cui i massacri o addirittura la fine del mondo si scatenano con l’autopilota, per protocollo, quasi a dispetto della coscienza.
[1] it.wikipedia.org/wiki/Barbenheimer
[2] Rebecca Keegan, “‘This Can’t Be Safe. It’s Got to Have Bite’: Christopher Nolan and Cast Unleash Oppenheimer“, The Hollywood Reporter, 14 luglio 2023.