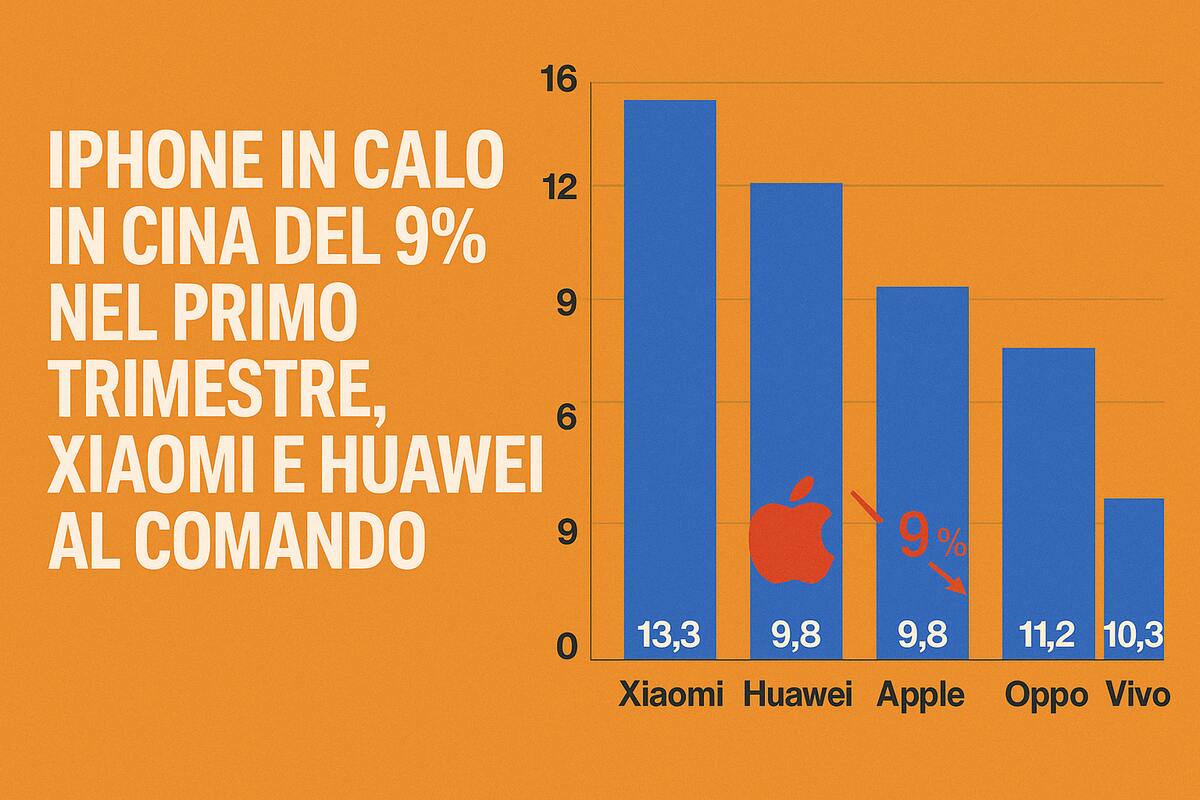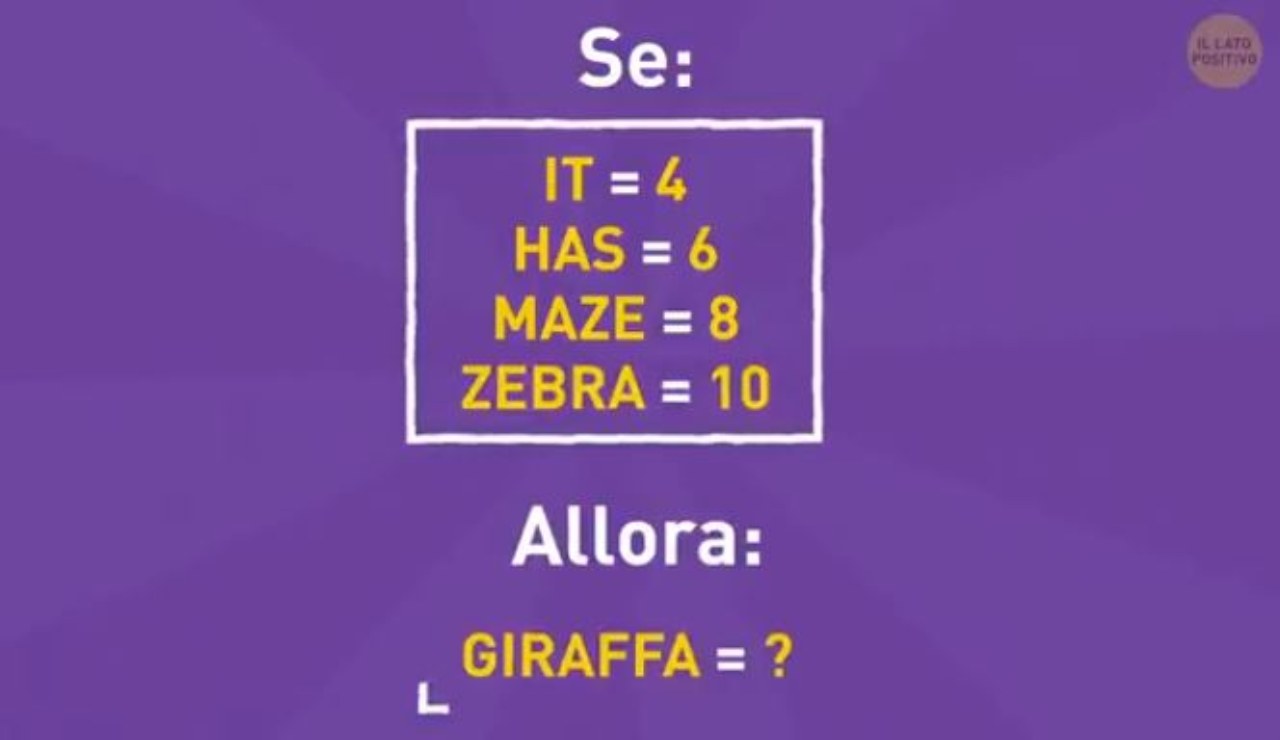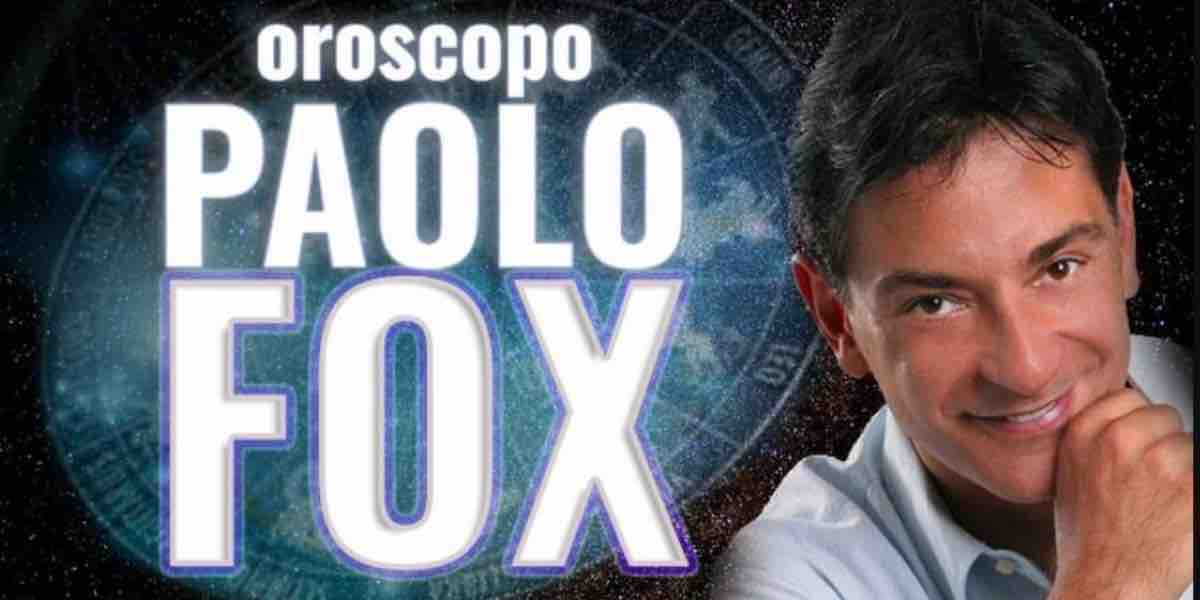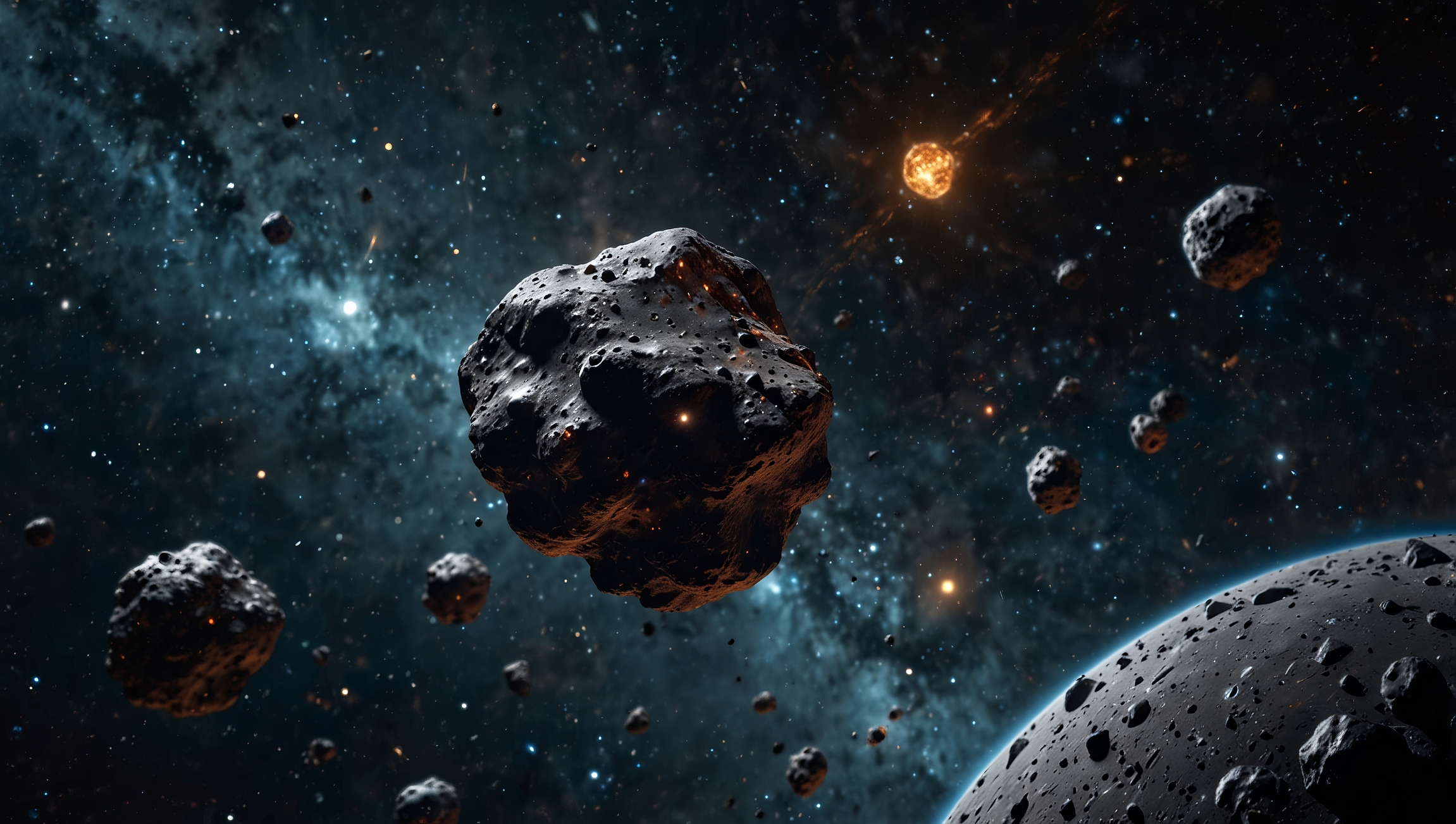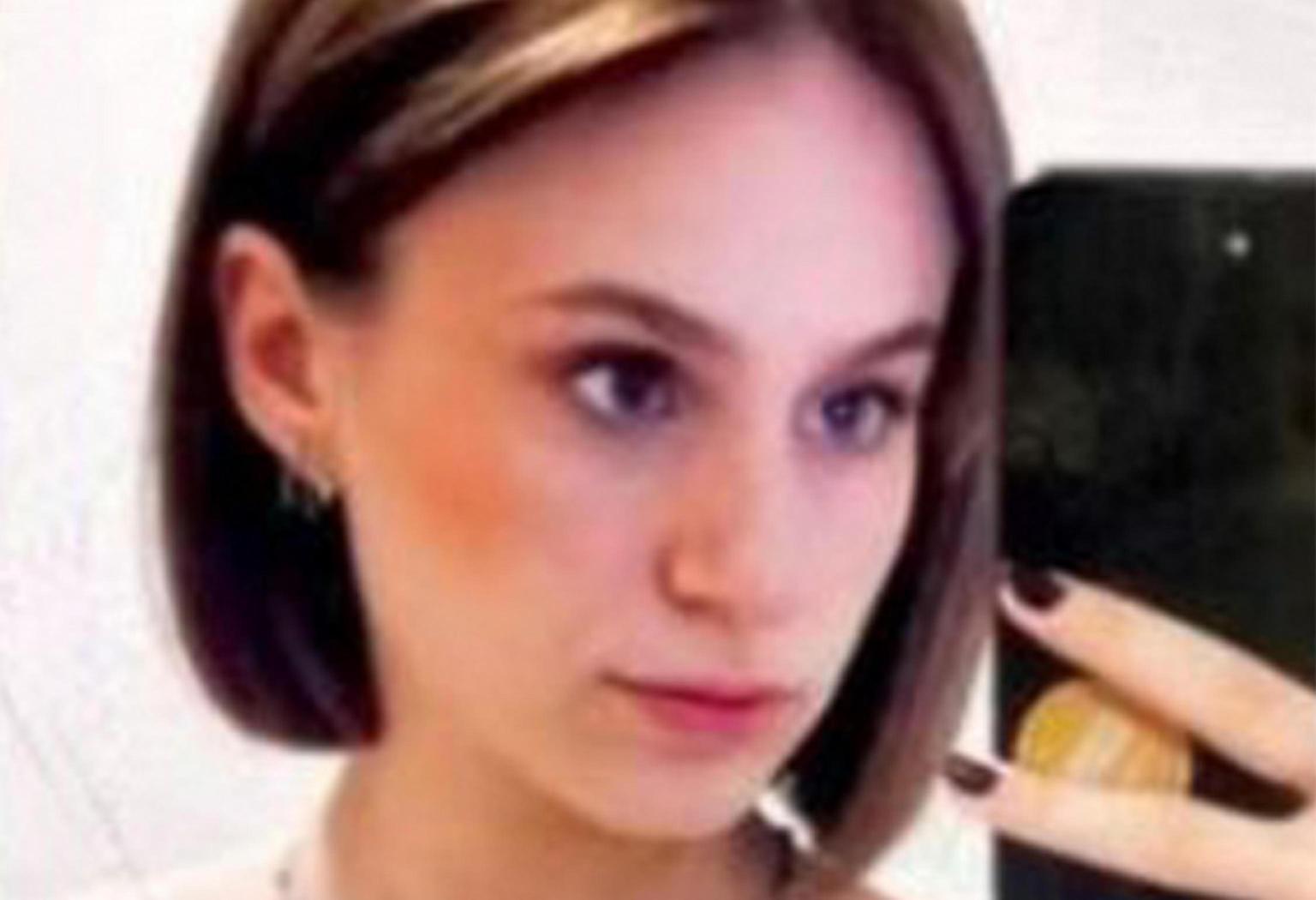Potenze di pace: una geopolitica nonviolenta
È possibile immaginare una geopolitica e quindi un sistema internazionale che sia basato sulla nonviolenza invece che sulla violenza? Questa è stata una delle domande cui ho cercato di rispondere […]

È possibile immaginare una geopolitica e quindi un sistema internazionale che sia basato sulla nonviolenza invece che sulla violenza?
Questa è stata una delle domande cui ho cercato di rispondere sabato 8 marzo durante il mio intervento alla Scuola di Pace organizzata dalla Caritas di Fano, evento intitolato ‘Italia potenza di pace: per una geopolitica non violenta’. Qui di seguito ne riporto una prima parte; mentre, una seconda parte sarà riportata in un articolo successivo.
Potere e violenza
Le cose intorno a noi, gli eventi, accadono e si sviluppano molto velocemente. A livello (geo)politico stanno avvenendo molti cambiamenti importanti e per questo è necessario porsi queste domande e discuterne attivamente insieme per non essere in balia di questi sommovimenti, rischiando di farcene sommergere, ma piuttosto per poterli indirizzare verso un’organizzazione e una struttura di mondo più umana e non più distruttiva.
La domanda ad incipit di questo pezzo è composta da termini che normalmente non metteremmo insieme: “potenza” con “pace”, “geopolitica” con “nonviolenza”, ma anche “potenza” con “nonviolenza” e “geopolitica” con “pace”. E infatti, l’obiettivo è proprio quello di essere provocatorie, nel senso che mirano a stimolare la nostra riflessione su tematiche che riguardano la nostra vita quotidiana. Questo perché, anche se spesso la percepiamo come qualcosa di lontano, che riguarda solo le élite politiche lontane da noi, la geopolitica e, quindi, le scelte politiche che vengono fatte a quei livelli, in realtà, ci riguardano molto da vicino.
Nelle relazioni internazionali, sia nella disciplina accademica sia nelle relazioni concrete tra gli Stati, quando si parla di ‘potere’, ci si riferisce in genere all’abilità e alla capacità di uno Stato X di convincere un altro Stato – lo Stato Y – a fare qualcosa che quest’ultimo non avrebbe fatto e che, soprattutto, è a vantaggio dello Stato X (e.g., Nye, 1990). Inoltre, in base al potere che uno Stato possiede e riesce ad esercitare, nelle relazioni internazionali, gli Stati vengono suddivisi in diverse categorie, che vengono a loro volta ordinate in una sorta di classifica, che stabilisce quali sono gli Stati ‘più potenti’ – e dunque ‘più importanti’ e ‘più influenti’ – e quali quelli ‘meno potenti’. Se ci pensiamo, questo principio vale anche a livello individuale, però per il momento teniamolo semplicemente a mente e rimaniamo a livello, come dire, istituzionale e del sistema internazionale.
Dunque, data questa definizione di ‘potere’, nella realtà, come si misura il potere di uno Stato e quindi come si stabilisce a livello internazionale il grado di potenza per ogni Stato e perciò la categoria di Stato cui esso appartiene?
Potremmo dire che fino a tutto il periodo della Guerra Fredda, sostanzialmente ci si focalizzava solo su quello che in gergo tecnico viene chiamato ‘hard power’, cioè il potere militare. Poi, ad un certo punto, si è aggiunto anche il potere economico di un Paese (e.g., Mearsheimer, 2001). Tuttavia, l’elemento militare, quindi l’esercito, le armi, l’intelligence e tutto l’apparato di difesa di uno Stato, è sempre stato chiave per determinare il grado di potenza di uno Stato nell’ambito internazionale (e.g., Schelling, 1966). Tant’è vero che, anche se le sanzioni economiche fanno parte del cosiddetto ‘hard power’ e vengono molto usate soprattutto dalla fine della Guerra Fredda per evitare lo scontro armato, tuttavia la forza militare di uno Stato è considerata determinante ed è ciò che stabilisce il grado di potenza, la categoria, entro cui uno Stato viene classificato (e.g., Baldwin, 1999; Alden and Aran, 2017, p. 5).
Qualcuno può giustamente dire: ma esiste anche il cosiddetto ‘soft power’. Sì, verissimo, esiste anche il soft power, che consiste principalmente nella diplomazia (e.g., Nye, 1990), un’arte che oggigiorno è fortemente in crisi. Il soft power consiste anche nel divulgare, nel proiettare la propria cultura, le proprie tradizioni, ma anche i propri valori all’esterno dei propri confini (ibid.). In questo senso, il cinema è un esempio chiave ed è il mezzo nel quale Stati come l’India, la Cina o la Corea del Sud, tra altri, stanno investendo molto. Eppure, nel sistema in cui viviamo – che, vorrei sottolineare, non ci è calato dall’alto, ma è un sistema che abbiamo creato attraverso le diverse dinamiche relazionali che abbiamo posto in atto e che continuiamo a praticare – gli strumenti di questo cosiddetto soft power non sono gli elementi attraverso cui gli Stati vengono classificati nei diversi gradi di potenza.
Se il grado di potenza di uno Stato viene prevalentemente assegnato in base alla loro potenza militare, il sistema dentro cui ci troviamo o, meglio, il sistema che abbiamo costruito nell’arco delle epoche storiche, è un sistema basato sulla forza, sul dominio dell’altro e sull’altro e, quindi, sulla violenza. (Come sappiamo molto bene ormai, la violenza non è solo fisica; questa è solo una delle forme che la violenza assume. Su questo, per esempio, Johan Galtung (1969, 2012) ha scritto tantissimo, diventando famoso essenzialmente per avere fatto la distinzione nel 1969 tra ‘violenza diretta’ (e.g., fisica) e ‘violenza strutturale’ (e.g., psicologica; ‘violenza di sistema’) e tra ‘pace positiva’ (e.g., cooperazione) e ‘pace negativa’ (e.g., assenza di guerra)). Difatti, facendo velocemente alcuni esempi, i discorsi sul conflitto tra Russia e Ucraina, quelli tra Israele e Hamas/Palestinesi, ma pensiamo anche a quello molto meno menzionato tra Armenia ed Azerbaijan o a quello tra le due Coree, e anche i discorsi sulla loro potenziale risoluzione si giocano all’interno di dinamiche di forza, di gradi più o meno estremizzati di braccia di ferro.
Cioè, chi tra le parti coinvolte riesce a mostrare meglio i denti, per così dire, e ad imporsi di più ha la meglio, vince e ottiene quello che vuole. E di nuovo, se prendiamo gli esempi appena riportati, tutte le parti coinvolte presentano lo stesso approccio: è una questione di forza. In tutti questi casi, si parla sempre di supporto armato; di come migliorare la difesa armata del proprio Stato; di come migliorare la propria sicurezza sempre da un punto di vista militare; di come arrivare più avvantaggiati e quindi più forti dell’altra parte ad un potenziale tavolo negoziale. Su questo, si guardi anche all’attuale progetto ReArm Europe dell’Unione Europea: segue la stessa linea logica.
Ora, non sto dicendo che l’aspetto difensivo non sia qualcosa cui gli Stati non debbano pensare. Piuttosto, ciò su cui vorrei riflettessimo è la totale assenza della possibilità di dialogo o, nel migliore dei casi, la subordinazione del dialogo all’uso della forza. In altre parole, o non si dialoga per nulla – vedi tutti i vari ‘con Putin non si dialoga’, ‘con Zelenskiy non si dialoga’, ‘con Hamas non si dialoga’, ‘con Netanyahu non si dialoga’ del caso. Oppure, se viene concessa la possibilità di dialogare con l’altra parte, la si concede solo quando ci si ritiene abbastanza forti dal punto di vista militare da poter imporre le proprie condizioni. Se questo però non si verifica allora non ci si parla, si interrompono i rapporti e si cerca di usare solo ed esclusivamente la forza militare. Da qui si capisce anche come negli ultimi anni sia venuta fuori in tutta la sua chiarezza e ignominia la formula concettuale secondo cui la pace possa essere costruita e mantenuta con le armi e quindi con la guerra.
Cioè, viene detto che la pace, che indica una distensione dei rapporti, una armonia dei rapporti tra diverse entità (e.g., Galtung, 2012; Treccani, no date) – siano essi individui o gruppi o popoli – può essere raggiunta attraverso le armi e la guerra, che sono per definizione ciò che rompono, distruggono i rapporti. Dunque, non viene detto che la pace si raggiunge e si mantiene con ciò che costruisce i rapporti, cioè con ciò che distende e armonizza le relazioni, quale sarebbe il dialogo – che dal greco significa letteralmente ‘farsi attraversare dalla parola’ (Generatività Sociale, 2022) – ma si dice che la pace si costruisce, si raggiunge e si mantiene attraverso ciò che la distrugge: la guerra.
L’inesistenza del dialogo o la sua subordinazione alla forza militare è perfettamente in linea con il sistema internazionale che abbiamo costruito e secondo cui il potere di uno Stato si misura sostanzialmente su quanto male questo Stato può fare agli altri. Quindi l’accostamento del termine ‘potenza’ (‘potere’) con il termine ‘nonviolenza’, secondo questa modalità di vedere le cose, rappresenta un ossimoro. Eppure, facendo uno studio leggermente più approfondito delle parole ‘potere’ e ‘potenza’, ci si renderebbe conto che il loro significato è più ampio e articolato rispetto a quello che noi diamo loro oggi.
Potere e potenza: significati da rivedere
A questo punto, mi faccio aiutare da un libro di Lorenzo Biagi (2024) che si intitola “Servizio contro potere. La novità di Gesù”. Come si evince benissimo dal titolo, il contenuto di questo libro è indirizzato principalmente alla Chiesa Cattolica e alla comunità cristiana più in generale. Tuttavia, è sicuramente utile anche per un discorso più laico sul ‘potere’. Chi non è religioso o chi non crede, può semplicemente prenderlo come un’altra prospettiva sul modo di impostare le relazioni con gli altri. D’altra parte, come scrissi in un altro articolo alcuni mesi fa (Grillo and L’Indispensabile, 2024), il nostro modo di vedere e quindi il nostro comportamento dipendono dalle nostre cornici cognitive. Queste, dando dei significati specifici alle entità che ci circondano e mettendole in relazione tra di loro a seconda del significato attribuito ad ogni entità, ci aiutano a dare un senso all’ambiente circostante e a gestirlo (ibid.; Sclavi, 2003). Tuttavia, queste cornici cognitive non sono uniche, nel senso che, potenzialmente, ne esistono di infinite, in quanto ogni volta che si attribuisce un significato diverso anche solo ad una delle entità attorno a noi, il significato di tutta la cornice cognitiva cambia e quindi cambia anche il nostro comportamento (ibid.). Perciò, anche se chi legge non è un cristiano, non è praticante o è ateo, può sempre vedere questa linea argomentativa semplicemente come un altro modo di dare significato alle cose attorno a noi e, dunque, come un altro modo di relazionarci con il mondo.
Nell’introduzione di questo libro, l’autore riporta l’etimologia della parola ‘potere’, che originariamente non sembra essere collegata, o comunque esclusivamente collegata, all’esercizio di un comando, all’esercizio del dominio sull’altro (Biagi, 2024, pp. 15–23). Sembra essere collegato invece all’esercizio di responsabilità e di cura verso l’altro, che nulla hanno a che fare con la violenza, con il dominio sugli altri. Anzi, il riferimento alla cura e alla responsabilità riporta proprio alla nonviolenza, ad un modo molto diverso di vedere il rapporto con noi stessi, con gli altri e con tutto ciò che ci circonda. Un modo molto diverso rispetto a ciò cui siamo abituati oggi. Infatti, il significato di cura e responsabilità, oggi, è pressoché sconosciuto, reso vuoto come sono stati resi vuoti i significati di pace, libertà e altri termini simili. E quindi, in quanto resi vuoti, sono anche termini usati molto ambiguamente e contraddittoriamente. Non mi soffermerò su questo punto poiché anch’esso vorrebbe un suo sviluppo a sé stante e qui, non ne ho lo spazio. Ai fini di questo discorso basta tenere presente che alla base del prendersi cura e dell’esercizio di responsabilità stanno le relazioni umane, i legami tra le persone, che invece vengono sostanzialmente visti come un ostacolo alla libertà dell’individuo intesa come libertà assoluta, cioè s-legata. Questa interpretazione dei legami umani l’abbiamo interiorizzata molto bene, direi, sia a livello individuale e quindi interpersonale che a livello internazionale, quindi nei rapporti tra gli Stati.
In parole più semplici e concrete, questa visione delle cose, che non è altro che la realizzazione concreta della logica di forza, di potere inteso come dominio sull’altro di cui ho parlato all’inizio, prevede che lo Stato singolo sia e debba essere libero di fare ciò che vuole senza interfacciarsi con gli altri Stati in quanto s-legato da tutto e tutti o, al massimo, in quanto ritiene di trovarsi in una posizione di superiorità rispetto agli altri, in una relazione di dominio sugli altri, pretendendo che gli altri Stati non lo ostacolino, ma che anzi gli obbediscano. Se questo non accade, cioè se gli altri Stati pongono resistenza o se anch’essi per via della stessa logica pretendono di fare ciò che vogliono senza badare agli altri e alle loro esigenze, allora ecco che la guerra per imporre la propria visione delle cose, intesa come unica visione, diventa un’opzione attuabile di politica estera, cioè di relazione con gli altri Stati, molto probabile (vedi anche Sclavi, 2003, pp. 25–29).
Ma la guerra è veramente la nostra unica opzione? Come si dice dalle mie parti, To Be Continued…
Bibliografia
Alden, C. and Aran, A. (2017) Foreign Policy Analysis. New Approaches. 2nd edn. London and New York: Routledge.
Baldwin, D.A. (1999) ‘The Sanctions Debate and the Logic of Choice’, International Security, 24(3), pp. 80–107.
Biagi, L. (2024) Servizio contro potere. La novità di Gesù. Edizioni Messaggero Padova. Padova: Messaggero di Sant’Antonio Editrice.
Galtung, J. (1969) ‘Violence, Peace, and Peace Research’, International Peace Research Institute, Oslo, 6(3), pp. 167–191.
Galtung, J. (2012) ‘Peace, Positive and Negative’, The Encyclopedia of Peace Psychology [Preprint].
Generatività Sociale (2022) ‘Il dialogo: questo sconosciuto’, Generatività Sociale, 26 April. Available at: http://generativita.it/it/news/il-dialogo-questo-sconosciuto/#:~:text=Condividi%3A,si%20lasciano%20attraversare%20dalla%20parola. (Accessed: 24 March 2025).
Grillo, G. and L’Indispensabile (2024) ‘Violenza o non violenza: una questione di prospettive’, la Fionda, October. Available at: https://www.lafionda.org/2024/10/03/violenza-o-non-violenza-una-questione-di-prospettive/.
Italia potenza di Pace: per una geopolitica nonviolenta [Video] (2025). Fano, Italy (Scuola di Pace Carlo Urbani 2025). Available at: https://www.youtube.com/watch?v=G7YkNDTjV6U&t=5s.
Mearsheimer, J.J. (2001) The Tragedy of Great Power Politics. Norton.
Nye, J. (1990) ‘Soft Power’, Foreign Affairs, 80, pp. 153–171. Available at: https://doi.org/10.2307/1148580.
Schelling, T.C. (1966) Arms and Influence. New Haven and London: Yale University Press.
Sclavi, M. (2003) Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte. Milan: Bruno Mondadori (Sintesi).
Treccani (no date) ‘Pace’, Enciclopedia Treccani. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, S.p.A. Available at: https://www.treccani.it/vocabolario/pace/ (Accessed: 24 March 2025).