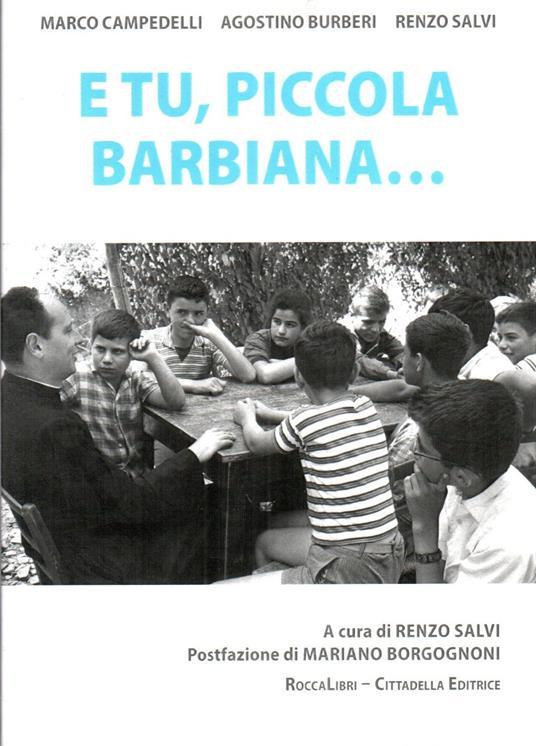Non è colpa nostra se non ci innamoriamo più, ma di una società ossessionata dalla positività
L'articolo Non è colpa nostra se non ci innamoriamo più, ma di una società ossessionata dalla positività proviene da THE VISION.

Nei mesi in cui ho avuto una relazione con quello che poi si è rivelato essere un love bomber dalle mille vite, truffe e relazioni, spendendo centinaia di euro in psicoterapia, c’era un mantra che mi ripetevo ossessivamente in diverse varianti: “Un giorno questo dolore ti sarà utile”, “Non reprimere le emozioni negative, vivile”, “La tristezza è fatta per essere attraversata”. Pur sembrandomi, a posteriori, il bigino di uno scadente manuale di auto-aiuto su come avere successo in cinque mosse, mi rendo conto che a permettermi di cambiare sguardo sulle cose sia stata anche la consapevolezza che il mio dolore, privato e singolare, potesse essere in realtà pubblico e comune, e quindi generativo di esperienze e confronti. Proprio la spinta a relegare ogni emozione negativa ai margini della nostra esistenza, senza accoglierla o provare a darle un senso anche nella sua insensatezza, mi sembra determinare il modo in cui oggi si sia trasformato il nostro approccio all’amore contemporaneo.

Viviamo, infatti, quella che il sociologo sudcoreano Byung-Chul Han ha definito, nel saggio La società senza dolore, una diffusa “algofobia”, cioè una paura generalizzata del dolore che ci anestetizza, riduce lo spazio riservato ai conflitti, alle controversie, ai disaccordi, ci fa togliere di mezzo tutto ciò che può essere negativo. Niente più può avere il potere di ferirci: la vita quotidiana deve diventare perfettamente instagrammabile, come un post sui social, levigata, senza asperità, priva di tensioni, contrasti o ambiguità che possano turbare o far soffrire. “La società palliativa coincide con la società della prestazione. Il dolore viene interpretato come un segno di debolezza, qualcosa da nascondere o da eliminare in nome dell’ottimizzazione”, scrive Han. “Il dolore però è una levatrice del Nuovo, un’ostetrica del completamente Altro. La negatività del dolore interrompe l’Uguale. Nella società palliativa come inferno dell’Uguale non è possibile alcuna lingua del dolore, alcuna poetica del dolore. Essa permette solo la prosa della compiacenza”.
È il risultato di una società ossessionata dalla positività e dall’ottimizzazione, soprattutto di se stessi, in cui per essere appetibili ci viene imposto di cavalcare le good vibes o investire nel pensiero magico, come se il mondo smettesse di andare in fiamme solo perché lo vogliamo abbastanza. Una postura che contrasta con il sentire comune, dominato dall’ansia generata dalle molteplici crisi che ci ritroviamo costretti ad attraversare, e che è funzionale soltanto all’ideologia neoliberista da cui scaturisce, perché l’imperativo della produzione non permette alcuna debolezza. Il dolore, così, è accettato nei limiti delle occasioni in cui può essere capitalizzato o elevarci pubblicamente, in una sua forma edulcorata, quasi glamour, performativa.

D’altronde, anche se siamo abituati a considerarle delle questioni private, le emozioni che proviamo – o che al contrario nascondiamo ed eliminiamo – si inseriscono in un contesto sociale, politico, economico e culturale da cui sono determinate e che a loro volta contribuiscono a definire. Se oggi facciamo così fatica a confrontarci con il dolore è anche perché contribuiamo sempre più a privatizzarlo e a renderlo un problema individuale, ignorando le strutture sistemiche che lo generano. Per esempio, siamo ancora spinti a stare in coppia, ma ci viene chiesto di sentirci autonomi e completi anche da soli – in un’economia però che non favorisce i single; dovremmo avere un o una partner ma non dovremmo desiderarlo; il concetto di coppia sta cambiando ma, anche se concordiamo nel pensare che la monogamia sia superata, ci vergogniamo ad ammettere che potremmo ancora trovarla la forma che più ci somiglia; il sesso occasionale doveva liberarci, invece si è trasformato nell’ennesima performance. Nel ritrovarci ad affrontare le contraddizioni tra desiderio di intimità e logiche di mercato, indipendenza e bisogno di legami, inevitabilmente anche l’amore è stato colonizzato dal timore del dolore.
“Il sesso e l’amore postromantici non cercano l’adrenalina di un rischio che può metterci di fronte all’abisso. Vogliamo un amore senza drammi, senza patemi, senza scivoloni imprevisti. Il mistero, l’inciampo, il disequilibrio ci fanno paura,” scrive Carolina Bandelli, Associate Professor in Media and Creative Industries all’Università di Warwick, in Le postromantiche. “Le emozioni perturbanti cerchiamo di eliminarle, non ci ‘buttiamo a capofitto’ in una situazione, piuttosto esaminiamo, verifichiamo, contrattiamo, stabiliamo metodi efficienti per assicurarci incontri sicuri basati su una comunicazione trasparente”. Ma un amore che non rischi di farci piangere non esiste. Forse solo quando cerchiamo nell’AI un partner perfetto, perché c’è sempre quando ne abbiamo bisogno e ci conferma tutto ciò che abbiamo bisogno di sentire, senza creare tensioni.

In un sondaggio del 2023 condotto da Hinge tra la Gen Z, il 90% degli intervistati ha dichiarato di voler trovare una relazione – ma il 56% ha detto che la paura del rifiuto lo aveva trattenuto dal tentare di iniziare a consolidare un rapporto, e il 57% ha affermato di aver evitato di confessare i propri sentimenti per timore di risultare “poco attraente” per l’altra persona. Secondo diversi studiosi, gli adolescenti e i ventenni di oggi sono particolarmente attenti alla sicurezza, avversi al rischio, inclini alla stabilità, e quindi non dovrebbe sorprendere che siano anche riluttanti a buttarsi in una qualsiasi relazione d’amore. Eppure, oggi sembra essere diventato un atteggiamento trasversale a più generazioni.
Certo, probabilmente non è mai esistito un periodo in cui amare ed essere amati sia stato facile, né vanno sminuite le ragioni che ci spingono a sviluppare una sorta di callosità verso le relazioni romantiche. Diventiamo adulti sempre più tardi, ci mancano il tempo e i soldi, l’ansia di non riuscire ad arrivare a fine mese a causa di salari da fame ci divora giorno dopo giorno, insieme alla paura per le tensioni geopolitiche, la crisi climatica, la possibilità di non essere abbastanza per gli standard collettivi, lo sforzo di apparire sempre al meglio, come non siamo. La polarizzazione delle visioni del mondo tra giovani uomini – più conservatori – e donne – più progressiste –, poi, crea una difficoltà sempre maggiore. I primi si radicalizzano dietro allo smarrimento del non sentirsi capiti e della fatica nell’accettare un nuovo paradigma in cui in diversi ambiti – e non senza ostacoli – le loro coetanee hanno più successo di loro; le seconde sono stufe di doversi barcamenare tra mansplaining, abusi e assaggi della carbonara più buona del mondo.

A ciò va aggiunto che le dating app, che dovevano rappresentare un modo più semplice per incontrare qualcuno, si sono trasformate in un mezzo che richiede pazienza, attenzione, sforzo, costanza, come fosse un lavoro, e che di conseguenza crea sempre più frustrazione ed esaurimento, finendo così per farci applicare strategie di efficienza proprie della cultura capitalista nel campo in cui dovremmo resistervi di più. Abbiamo più scelta ma, invece di essere più liberi, siamo più infelici: rimpiangiamo le opzioni che abbiamo lasciato indietro, perché scegliere significa voltare le spalle alle possibili occasioni future – o alla loro idea, semmai. Nel sistema neoliberista si ribalta infatti il mito dell’amore romantico: là fuori non esiste una sola persona per noi, ma idealmente milioni, ognuna migliore della precedente. In questi amori liquidi non sappiamo instaurare legami duraturi, spaventati dal rimanere intrappolati in rapporti stabili. Davanti a uno scenario simile, i rischi che innamorarsi porta con sé sono l’ultima cosa che ci manca.
Si può crescere diventando adulti completi e maturi anche senza aver mai avuto un rapporto romantico, ma penso sia un peccato non innamorarsi solo per paura del rischio che l’amore possa ferirci. È un atteggiamento che, soprattutto, mi sembra avere a che fare con la nostra vulnerabilità, con il sentirci costantemente sull’orlo di un precipizio, a cui rispondiamo chiudendoci in noi stessi. Non a caso, credo, il campo semantico delle relazioni è oggi affollato di termini derivanti da quello psicologico e terapeutico – narcisismo, red flags, tossico – in un tentativo, anche involontario, di patologizzare ogni esperienza, forse perché così ci appare più semplice capirla, inquadrarla, individuare correlazioni di causa ed effetto, affrontarla. Ciò che non funziona, il più delle volte, non sono però le nostre infanzie disfunzionali come vorrebbero i coach su TikTok, ma l’insieme di contraddizioni sociali e culturali che oggi strutturano le nostre identità, e che ci fa percepire un rifiuto come una negazione di noi stessi, un’approvazione o meno del nostro valore.

Nonostante concepiamo l’amore come un fenomeno irrazionale che ci travolge, infatti, in realtà spesso ha molto a che fare con le modalità con cui la società forma i criteri che utilizziamo per valutare eventuali scelte e temere determinate conseguenze. Siamo naturalmente portati a minimizzare la possibilità di errore, ma è un obiettivo che intralcia il raggiungimento di una relazione duratura, non solo perché non possiamo prevedere o comandare del tutto l’Altro – per fortuna, direi –, ma anche perché ogni rapporto è spesso un rapporto al ribasso con noi stessi essendo sempre un compromesso tra la nostra idealizzazione e la realtà. Un moto che pur chiedendoci di riunciare a qualcosa ci insegna proprio per quello a mettere da parte il nostro sé, per accogliere ed essere accolti.
“La chiamiamo ‘sofferenza’, ma dovremmo chiamarla ‘conoscenza’: è la conoscenza di qualcosa che non ci piace, ma che esiste così. E cioè che gli altri e il mondo non sono minimamente sottoposti al dominio della nostra volontà”, propone Annalisa Ambrosio nel saggio L’amore è cambiato. “Per quanto la nostra immaginazione possa essere forte, da sola non basta per fare la realtà”. È una prospettiva liberatoria, non tanto perché riveste di un’utilità le pene amorose, anche quelle di noi eterni sottoni, ma perché permette di compiere quella trasformazione con cui l’antropologo tedesco Viktor von Weizsäcker descriveva il dolore: “Il divenire carne di una verità”. Nel caso dell’innamoramento la verità a cui ci esponiamo è quella dei nostri sentimenti, dei nostri desideri autentici, di ciò che siamo disposti a concedere o meno in una relazione, ma è anche quella di accorgerci che – con buona pace del nostro ego – nel grande ordine del mondo contiamo meno di quanto crediamo, ed è liberatorio rendersene conto.
L'articolo Non è colpa nostra se non ci innamoriamo più, ma di una società ossessionata dalla positività proviene da THE VISION.