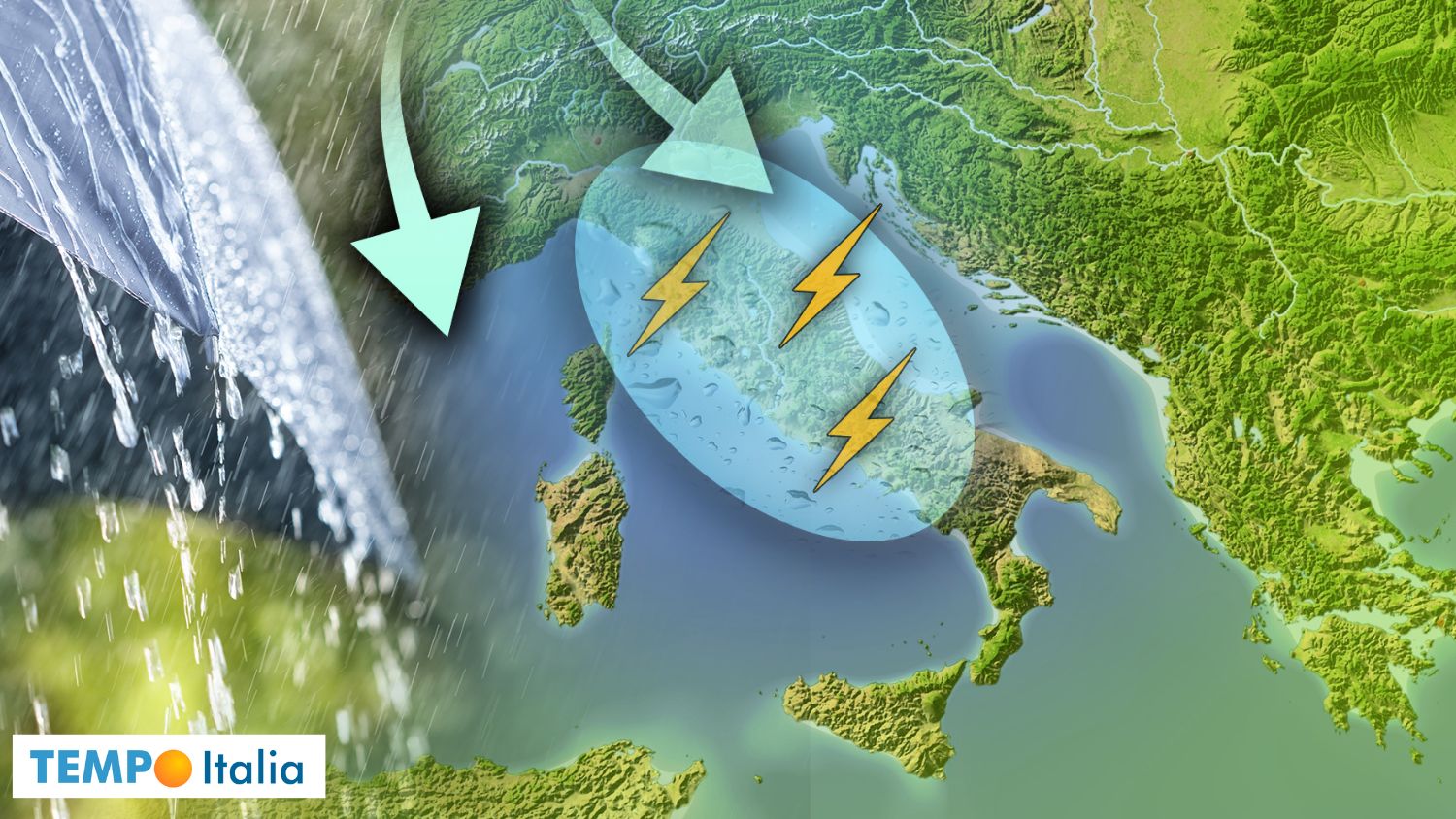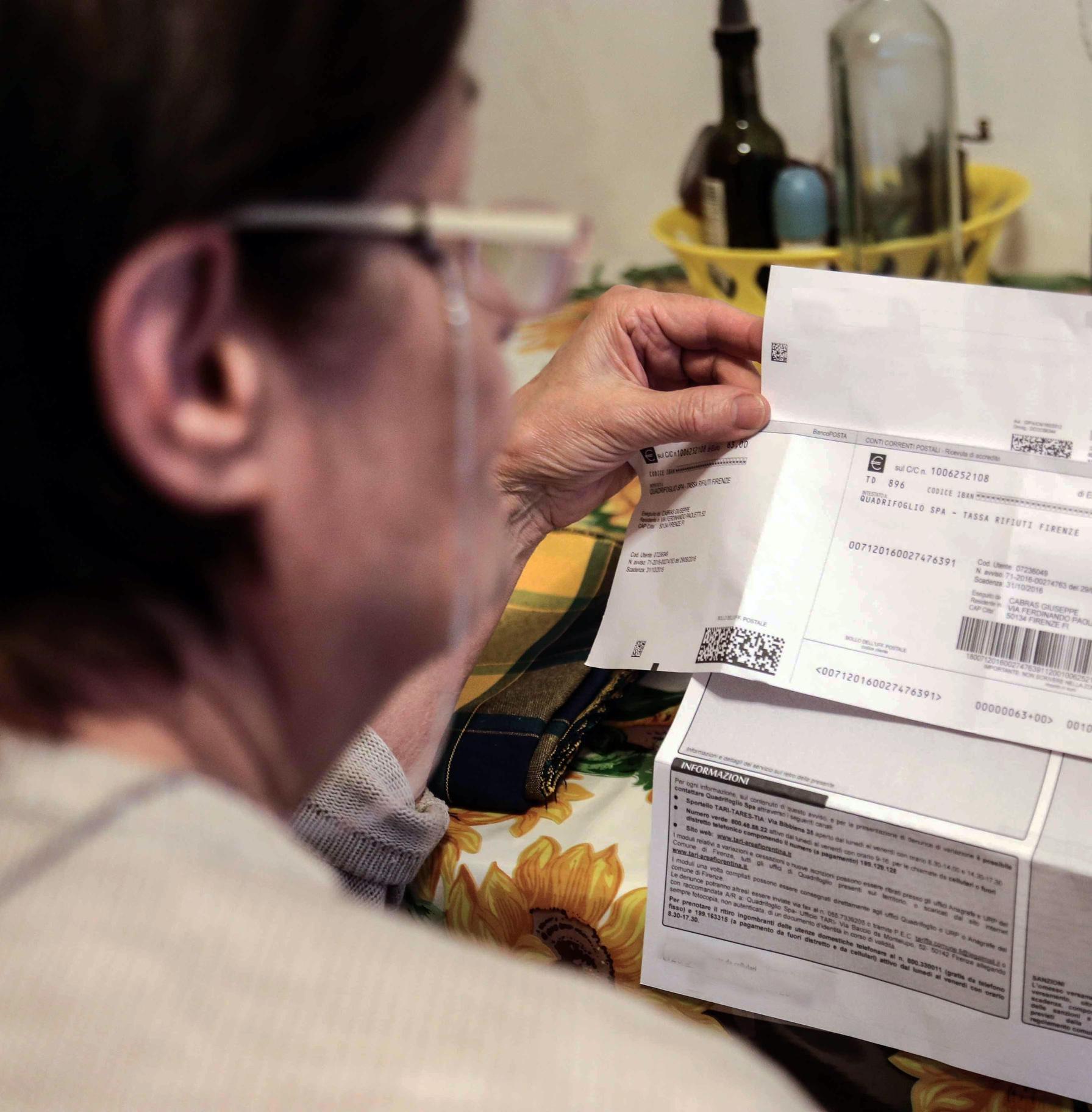Neurodiritti, cosa sono, come tutelarli e perché è bene parlarne. La parola agli esperti
L'avvertimento di Barbara Calderini, Legal Tech: «Le neurotecnologie hanno il potenziale di penetrare direttamente nella mente dell'individuo». L’evoluzione dei diritti si evolve assieme alla tecnologia, ma non mancano le difficoltà come sottolinea il docente di informatica giurIdica Francesco Paolo Micozzi: «Non è mai facile definire con precisione come un impianto normativo possa tutelare senza soffocare il dinamismo dell’innovazione»

Avete mai pensato di dover tutelare il vostro pensiero? O che fosse a rischio di manipolazione? Anche se può sembrare una preoccupazione da fantascienza, accanto all’evoluzione tecnologica delle neuroscienze e dei modelli di simulazione di AI che apportano benefici in caso di patologie neurodegenerative, vi sono concrete e reali minacce di abusi di prossima attuazione. Conoscere i rischi alla propria privacy mentale e prepararsi alla tutela dei propri diritti nella sfera cognitiva legata al pensiero, non è dunque rimandabile.

Il rischio di abuso
Barbara Calderini, Legal Tech e Compliance manager spiega che: «le neurotecnologie, capaci di decodificare i segnali neurali per facilitare la comunicazione o persino potenziare le capacità motorie e cognitive, sono sempre più integrate in un contesto dominato dai big data, in cui la protezione dei dati personali dei cittadini garantita in UE, primis dal GDPR, si trova messa in crisi. Le neuroscienze e le tecnologie digitali si intrecciano per creare nuovi mercati, ma si generano nuove forme di controllo e nuove sfide per la tutela dei diritti fondamentali. Mentre il digitale ha trasformato il nostro rapporto con l’informazione e la comunicazione, le neurotecnologie hanno il potenziale di penetrare direttamente nella sfera più intima dell’individuo: la mente».
In particolare, l’esperta avvisa sulla concreta «eventualità che l’industria neuro tecnologica si sviluppi seguendo logiche di mercato e trascurando i principi fondamentali della tutela dei diritti umani e dell’autodeterminazione individuale». Si ricorda che, la ricerca ha portato alla convergenza multidisciplinare tra Intelligenza Artificiale e nuove neurotecnologie legate alla registrazione o addirittura alterazione/induzione dell’attività neuronale umana e all’avanzamento della scienza del cervello e dell’ingegneria neurale.
La stimolazione corticale profonda ha la capacità di indurre stati mentali diversi e quindi controllare o influenzare una attività cerebrale. Sebbene queste tecnologie possano curare le malattie degenerative neurali, le preoccupazioni sono legate a capacità di sorveglianza, manipolazione subliminale delle preferenze, controllo e raccolta o alterazione di informazioni cerebrali e mentali. Dal punto di vista dell’esercizio dei propri diritti l’esperta avverte come «gli strumenti digitali possano favorire, l’esercizio di poteri arbitrari, sia pubblici che privati, con il serio rischio di comprimere l’autonomia personale e indebolire i principi alla base dello stato di diritto». Quindi il rischio concreto è legato alla capacità di autodeterminazione.
Il contesto di “pericolo” ha dunque stimolato l’esigenza di riconoscere e definire i neurodiritti, sui quali l’esperta chiarisce come esista il «dilemma centrale sulla creazione di nuovi diritti a tutela delle esigenze emergenti, o piuttosto la possibilità che i diritti già esistenti possano essere sufficienti a garantire una protezione efficace»

Cosa sono i neurodiritti
Francesco Paolo Micozzi, avvocato e docente di informatica giuridica chiarisce che «con il neologismo ‘neurodiritti’ si fa, generalmente, riferimento al complesso di diritti, che si assumano essere fondamentali, finalizzati alla protezione dell’essere umano da tutte le conseguenze che possano discendere da un’interazione tra neurotecnologia e mente umana». Il nuovo termine ha una provenienza illustre. L’avvocato Micozzi ricorda infatti come sia stato il « professore di neurobiologia della Columbia University Rafael Yuste ad avanzare lea proposta di raggruppare, sotto il termine ‘neurodiritti’, cinque diversi diritti umani relativi alla sfera neurale: il ‘diritto alla privacy mentale’, in modo che i dati del nostro cervello non possano essere utilizzati senza il nostro consenso; il ‘diritto al libero arbitrio’, in modo che possiamo prendere decisioni senza l’influenza neurotecnologica; il ‘diritto all’identità personale’, in modo che la tecnologia non possa cambiare la nostra personalità; il ‘diritto alla protezione dalla discriminazione basata sui dati del cervello’; e, non da ultimo, il ‘diritto all’accesso equo all’aumento neurale’ (un accesso non equo, infatti, potrebbe portare alla divisione, secondo Yuste, dell’umanità in due specie: aumentata e non aumentata)».
Ma se lo studio sui neurodiritti è, ancora, in una fase embrionale e dovrà essere approfondito, la tutela normativa sembra avere un nodo da sciogliere: secondo l’avvocato, infatti, «la costante evoluzione del settore delle neurotecnologie, alimentata dal susseguirsi ininterrotto di nuove scoperte, rende ancora più difficile definire con precisione come un impianto normativo, o una combinazione, possa tutelare i diritti fondamentali senza soffocare il dinamismo dell’innovazione tecnologica. Norme eccessivamente restrittive rischiano, infatti, di mitigare non solo gli effetti negativi sui diritti fondamentali ma anche di limitare o inibire gli avanzamenti scientifici positivi e d’altra parte» continua l’esperto, «non è che ad ogni nuova innovazione tecnologica debba necessariamente derivare una nuova produzione normativa».
La normativa internazionale sui neurodiritti
A livello internazionale Cile, Spagna hanno già avviato iniziative specifiche come ricorda l’avvocato Micozzi «il primo Paese ad aver introdotto nella propria carta costituzionale delle norme con richiami espliciti in materia di neurodiritti è il Cile con l’articolo 19 mentre il governo spagnolo ha inserito alcune diciture nella carta dei diritti digitali e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sull’intelligenza artificiale in un’era digitale (punti 36 e 247) esprimendo preoccupazione per l’assenza di una normativa concernente i dati neurologici e invitando l’UE ad adoperarsi per tecnologie neurologiche sicure includendo inoltre includere i neurodiritti nella Dichiarazione universale dei diritti umani».

La tutela e il Garante italiano
In Italia il Garante aveva auspicato fin dal 2022 la definizione di uno statuto giuridico ed etico, sui neurodiritti in base a cui coniugare l’innovazione con la dignità della persona e da allora ad oggi vi sono attività di monitoraggio e vigilanza, come spiega l’avvocato Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali presso Autorità Garante dei dati Italiani: «Stiamo monitorando e vigilando in particolare sull’esondazione di neuroscienze e neurotecnologie dall’ambito clinico a quello del mercato, ma molto di quello che sta accadendo non sta accadendo in Italia e, quindi, i nostri poteri sono limitati. In Italia ogni attività di vigilanza è figlia di istanze di parte, di persone che chiedono tutela. A ogni reclamo, segue un’istruttoria necessaria a prescindere dalla rilevanza della questione sottesa al reclamo e se da un lato i reclami saturno pressoché completamente le risorse umane disponibili, dall’altro i reclami non riguardano questo genere di questioni che le persone non percepiscono come sufficientemente importanti da indurle a cercare tutela».
In sintesi, se le persone non sono consce dei loro diritti di privacy nell’ambito dei neurodiritti, non ne chiedono la tutela. Eppure, alcune leggi esistono già. L’avvocato Scorza osserva infatti, «le regole che ci sono consentono di fare comunque molto per provare a orientare industrie e mercati e personalmente non sono convinto che nuovi interventi regolatori, specie se volti a definire nuovi diritti, i cosiddetti “neurodiritti”, siano indispensabili. I dati che affollano il nostro cervello sono semplicemente dati personali super particolari, potrei dire super personali. Forse basterebbe una ‘privacy aumentata’ per governare il fenomeno al quale stiamo assistendo». Ma allora che framework possono essere utili a livello normativo ci si potrebbe chiedere? L’esperto del Garante esprime un approccio tipico della sicurezza «’less is more’, più che in tanti altri casi» e auspica come possibile soluzione «di concordare su dieci principi inderogabili relativi all’impatto di neuroscienza e neurotecnologie sulla società nel corso di un anno, per poi andare presso Autorità e Agenzie cominciando naturalmente da quelle sulla protezione dei dati personali, le risorse, i mezzi, anche tecnologici e i poteri necessari a declinare i dieci principi, in una governance agile e adeguata alle esigenze del ‘day by day’».

La sperimentazione normativa
Rispetto alle tecnologie, le leggi spesso, si trovano ad inseguire e sancire o vietare su qualcosa che è già esistente. In questo senso nell’AI act la Ue ha introdotto lo strumento delle legal sandbox come aree legali di sperimentazione normativa per le nuove tecnologie. Se siano efficaci per la tutela dei neurodiritti è stato chiesto a Oreste Pollicino, professore di regolamentazione dell’Intelligenza artificiale alla Bocconi e fondatore di Pollicino AIdvisory: «le sandbox nei settori sottoposti a regolamentazione costituiscono oggi, un punto di snodo essenziale per chi si interroga su come conciliare il progresso tecnologico con la protezione dei diritti fondamentali. Esse potrebbero infatti diventare il banco di prova per affrontare una delle sfide più complesse che ci attendono: il rapporto tra neurotecnologie e diritti della persona. Siamo, di fronte a una frontiera che richiede attenzione. Il tema, non è solo quello di costruire regole nuove, ma di capire come costruirle. Creare spazi di sperimentazione regolatoria sulle neurotecnologie significherebbe mettere alla prova soluzioni giuridiche capaci di adattarsi, in tempo reale, al passo di innovazioni che incidono direttamente sulla libertà e sulla dignità dell’individuo».
La sperimentazione non è immune da equivoci avvisa il professore: «Sandbox non significa terra di nessuno: non è sinonimo di vuoto normativo, né di libertà assoluta per chi innova. Al contrario, si tratta di individuare aree in cui la sperimentazione tecnologica possa procedere sotto il controllo delle autorità pubbliche e necessità di un effettivo accesso alla giustizia, in un confronto strutturato con chi sviluppa e chi rappresenta gli interessi della società civile» chiarendo infine che « l’obiettivo è affinare strumenti giuridici che non si limitino a inseguire la tecnologia, ma siano in grado di guidarla: nel campo delle neurotecnologie, come in quello dell’intelligenza artificiale, il diritto non può accettare di essere mera conseguenza. Deve restare il perno attorno a cui si costruisce l’innovazione, stabilendo con chiarezza ciò che può essere negoziato e ciò che, invece, non può essere ceduto».
Come tutelarsi
Ma quindi a valle dei rischi e dello stato odierno della legislazione come ci si difende in pratica? È Barbara Calderini a fornire un metodo empirico e che in effetti fa già parte del vissuto di ciascuno «Prendere decisioni consapevoli di protezione e tutela è un principio fondamentale che vale in ogni ambito ed è ancora più cruciale quando si tratta di tecnologie avanzate come le neurotecnologie. Lo strumento del controllo informato sulle proprie scelte deve poter essere esercitato. Sono necessari: una solida alfabetizzazione tecnologica e una crescente consapevolezza digitale, entrambe abilitate anche da una educazione continua».
Ma tutelare la propria privacy e la protezione dei propri dati personali per l’esperta passa anche per misure di sicurezza specifiche: «la sicurezza dei dispositivi è essenziale mediante tecnologie che garantiscano misure di protezione avanzate, come la crittografia dei dati e sistemi di accesso sicuro. Un altro aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale per la sicurezza, è l’aggiornamento dei dispositivi e delle applicazioni. Esaminare attentamente le politiche sulla privacy e i termini di servizio delle soluzioni e degli strumenti utilizzati è una priorità fondamentale» aggiungendo anche suggerimenti specifici al contesto delle neurotecnologie-
«Prima di acquistare o utilizzare un prodotto neurotecnologico, è importante verificare quali protocolli di sicurezza siano adottati e se l’azienda fornisca aggiornamenti regolari per mantenere la protezione efficace nel tempo. In tema di gestione del consenso è essenziale che i meccanismi siano chiari, trasparenti e ben comprensibili, evitando che diventino mere formalità. È in quel momento spiega» l’esperta «che il principio di autodeterminazione diventa fondamentale e le persone devono poter piena libertà e potere decisionale su come, quando e con chi condividere i propri dati. Per garantire una reale autodeterminazione, non basta un meccanismo di consenso statico. È necessario costruire un sistema che permetta agli individui di esercitare un controllo continuo sulle proprie informazioni e sulle decisioni che riguardano la loro privacy mediante trasparenza, consapevolezza attiva e tutela dei diritti».
Sul fronte delle aziende che devono rispettare la compliance, evitare abusi e inserirsi in modo etico in questo contesto di business, l’esperta avvisa che «siamo già testimoni della transizione dall’economia dell’attenzione a quella dell’intenzione: grazie agli assistenti virtuali, le aziende riescono a trasmettere agli inserzionisti le intenzioni d’acquisto, prima ancora che l’individuo ne sia pienamente consapevole. La linea sottile che separa la terapia dalla coercizione e il potenziamento dalla manipolazione diventa infatti sempre più pericolosa e sono presenti criticità sul fronte della trasparenza, della sicurezza dei dati e dell’etica, evidenziate anche dagli esperti Jared Genser, Stephen Damianos e Rafael Yuste nel rapporto del 2024 rapporto ‘Safeguarding Brain Data: Assessing the Privacy Practices of Consumer Neurotechnology Companies’. Oltre all’iniziativa UNESCO di consultazione online per elaborare una raccomandazione sull’etica della neurotecnologia, per definire linee guida per uno sviluppo responsabile di queste tecnologie, a beneficio dell’umanità, si assiste all’urgenza di una risposta internazionale che ponga al centro trasparenza, sicurezza e tutela dell’integrità mentale degli utenti».







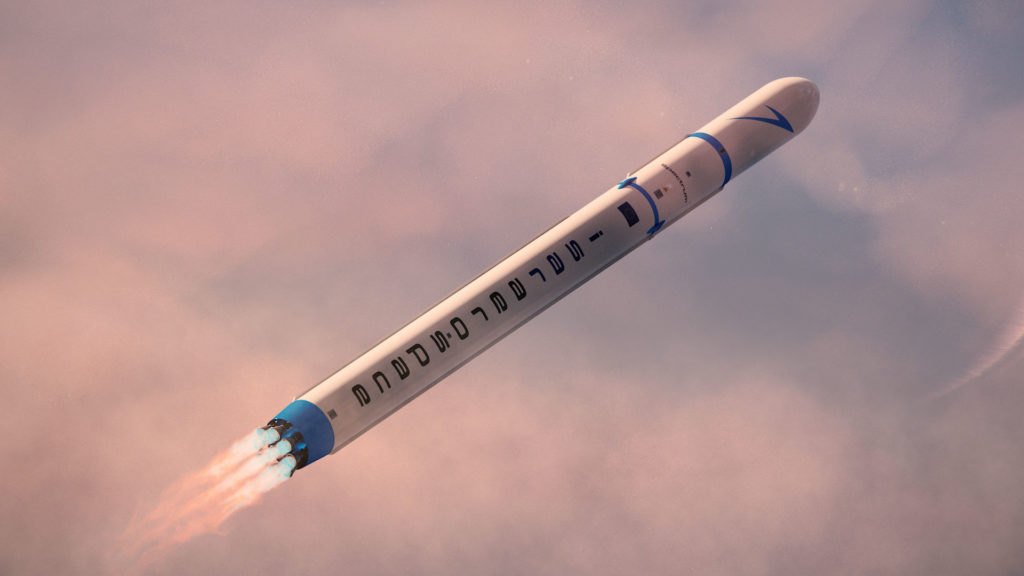
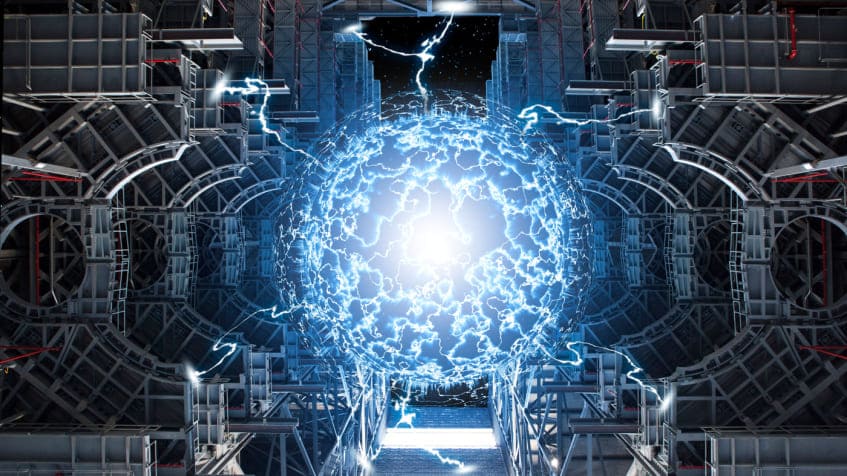


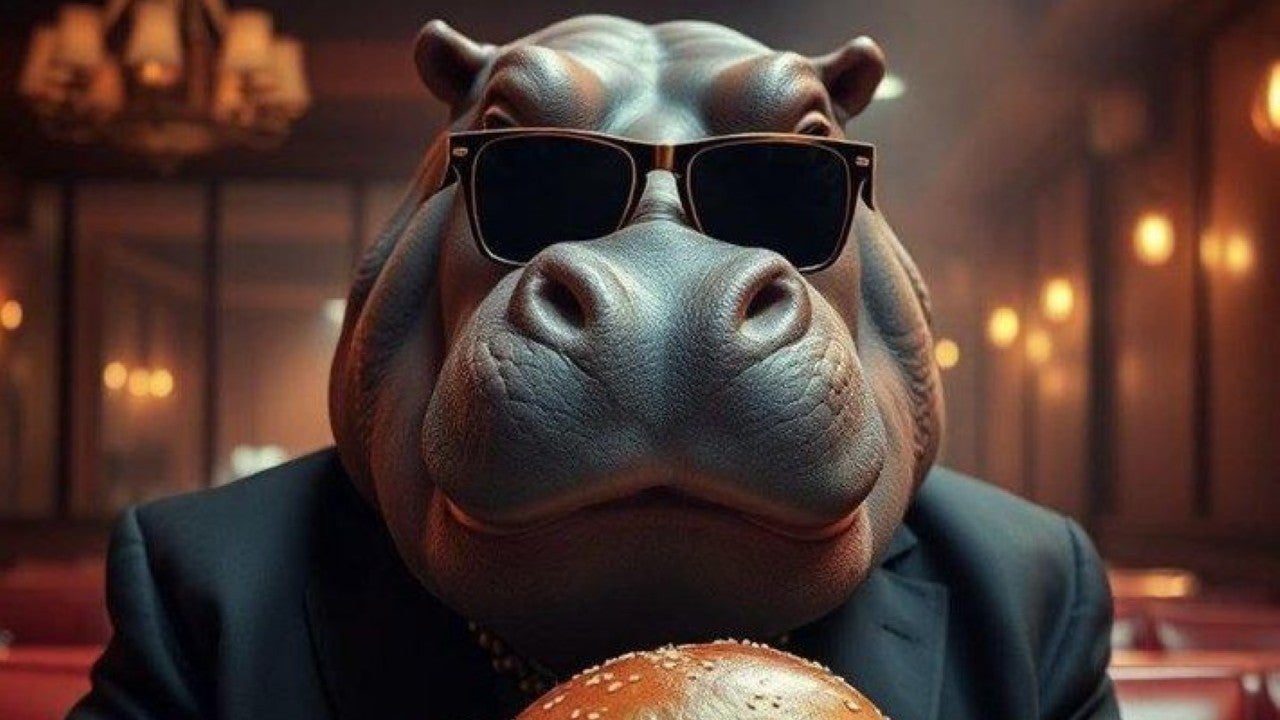


![E’ L’ULTIMO GIORNO di Offerte di Primavera Amazon: Ecco la nostra diretta del 31 Marzo [LIVE]](https://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2025/03/ispazio-40.jpg)