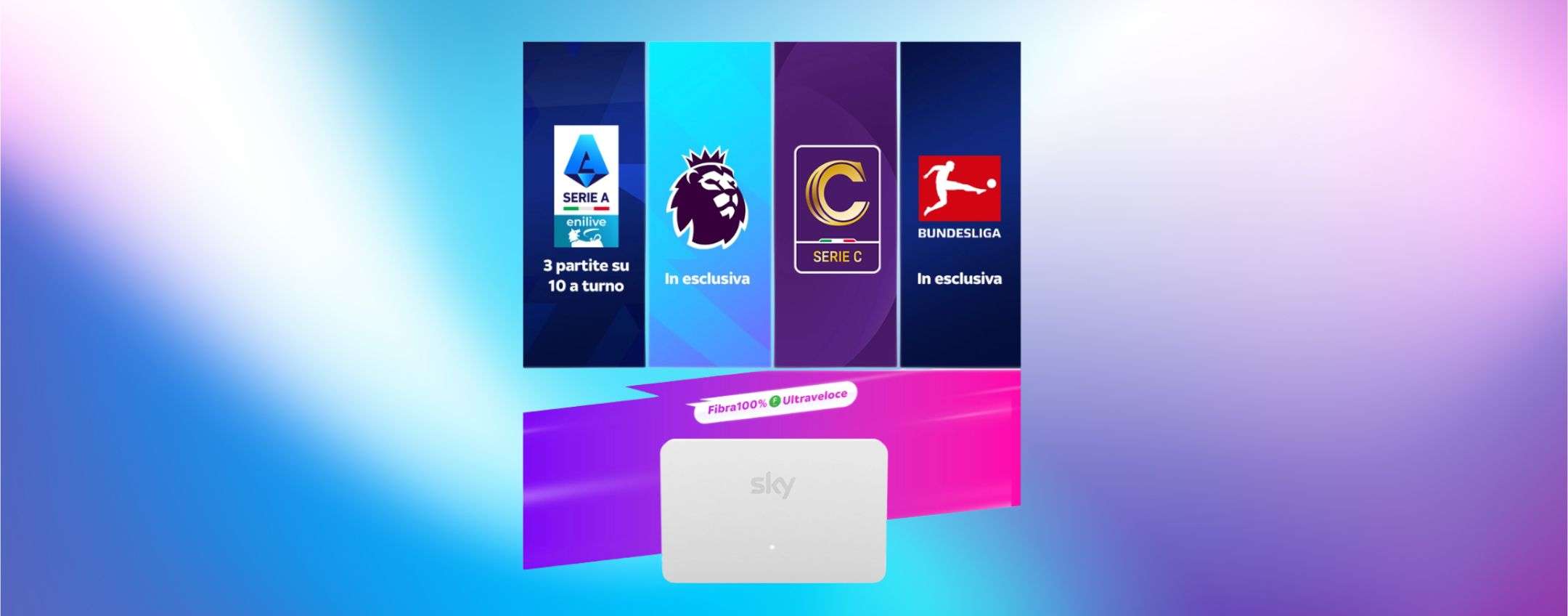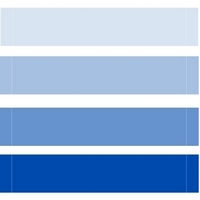Lettera al Manifesto
Questa è la risposta all’articolo uscito il 26 marzo sul Manifesto, a firma di Giuliano Santoro, che il nostro direttore editoriale ha inviato alla direzione del giornale, la quale ha […]

Questa è la risposta all’articolo uscito il 26 marzo sul Manifesto, a firma di Giuliano Santoro, che il nostro direttore editoriale ha inviato alla direzione del giornale, la quale ha deciso di non pubblicarla. Bell’esempio di democrazia e pluralismo, non c’è che dire!
Caro Direttore,
ti chiedo ospitalità per alcune puntualizzazioni sull’articolo No alla follia bellica: il M5S lancia la piazza e le mozioni sul riarmo, firmato da Giuliano Santoro e pubblicato in data 26 marzo.
Si tratta di un articolo malevolo e pieno di pregiudizi, banalizzazioni e semplificazioni. Associare, seppur indirettamente, me e la Fionda (la rivista che dirigo insieme ad Alessandro Somma), a Vannacci e a Casa Pound è profondamente scorretto, perché si tratta di una falsificazione allusiva, che confonde le acque ed evita di confrontarsi seriamente con le analisi e le idee che proponiamo.
Il tema della sovranità è di ben altra portata rispetto al cosiddetto “sovranismo”: ridurre la prima a quest’ultimo è intellettualmente risibile. La sovranità democratica è scolpita nell’articolo 1 della Costituzione italiana: vorrà dire qualcosa? Il concetto di sovranità, senza il quale la storia dello Stato moderno non è neppure concepibile, e che indica l’esistenza politica di una collettività, la sua indipendenza, deve essere innanzitutto conosciuto e compreso: consiglio due brevi e densi volumi, scritti da studiosi autorevolissimi, che possono fungere da antidoto ai luogocomunismi imperanti: Sovranità di Carlo Galli (Il Mulino, 2019); Sovranità. Origine e futuro di un concetto chiave di Dieter Grimm (Laterza, 2023), che ho curato insieme a Olimpia Malatesta (nell’Introduzione, intitolata non a caso “Sovranità, non sovranismo”, spiego l’imprescindibilità del concetto e della sua storia teorico-giuridica, così come viene ricostruita da Grimm). Il nostro recupero della nozione di sovranità è in chiave democratica e costituzionale, ed è funzionale a mettere in discussione l’assolutizzazione del vincolo esterno.
Allo stesso modo, è del tutto improprio ricondurre il tema della nazione e dello Stato-nazione (entro cui incubano la democrazia rappresentativa moderna e lo stesso potere costituente rivoluzionario) al nazionalismo, grave degenerazione dalle cause complesse, non ultima il “momento Polanyi”, cioè la richiesta di protezione sociale da parte dei ceti popolari impoveriti e inferiorizzati, derivante dalla grave crisi economica e sociale generata del liberoscambismo e del proto-globalismo imperante tra secondo Ottocento e prima parte del Novecento. Anche qui, confonderli è segno di decadenza culturale e perdita di senso storico (urge un ripasso di Chabod e Mazzini). Ovvero di subalternità all’ideologia globalista neoliberale, la cui cifra è appunto la spoliticizzazione, la destoricizzazione e la naturalizzazione dei fenomeni sociali. Non a caso, è ormai invalsa e sdoganata una tendenza a operare paragoni storici surreali, imbarazzanti, privi di qualsiasi fondamento (ad esempio per giustificare la propaganda bellicista mainstream, che è oggi il mantra dell’Unione Europea).
Sulla tradizione, innanzitutto bisogna ricordare che anche quella moderna è una “tradizione” (composita, perché frutto di filoni diversi). La dialettica tra tradizione e modernità, così come quella tra trascendenza e immanenza, è costitutiva dello statuto del Moderno, come dimostra il dibattitto sulla teologia politica e la secolarizzazione, alimentato da studiosi notoriamente “fascisti” o “neofascisti” come Carlo Galli, Mario Tronti, Michele Nicoletti, Roberto Esposito, Giorgio Agamben, Jean-François Kervégan, José Luis Villacañas, Paul Kahn, Charles Taylor, Jean-Claude Monod, oltre che dal sottoscritto. Per non parlare del dibattito di poco più di venti anni fa tra Jürgen Habermas e l’allora cardinale Ratzinger, sulle tesi di Ernst-Wolfgang Böckenferde (“Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che, di per sé, non è in grado di garantire”).
Come avvertiva Pasolini, bisogna guardarsi dal “fascismo degli antifascisti”. Ma forse, in questo caso, siamo soprattutto di fronte alla “mezza cultura” della post-sinistra, che affossa pensiero critico e senso della complessità della politica, sostituendovi un moralismo senza ethos, un ideologismo dogmatico che da un lato è nemico del confronto libero delle idee e serve solo a confermare il “suprematismo morale” dei custodi della sinistra che non c’è, dall’altro è privo di autentici, saldi riferimenti ideali. La resilienza dei simulacri produce solo feticci identitari, cui aggrapparsi disperatamente, senza alcuna possibilità di comprendere e incidere. Cordialmente,
Geminello Preterossi