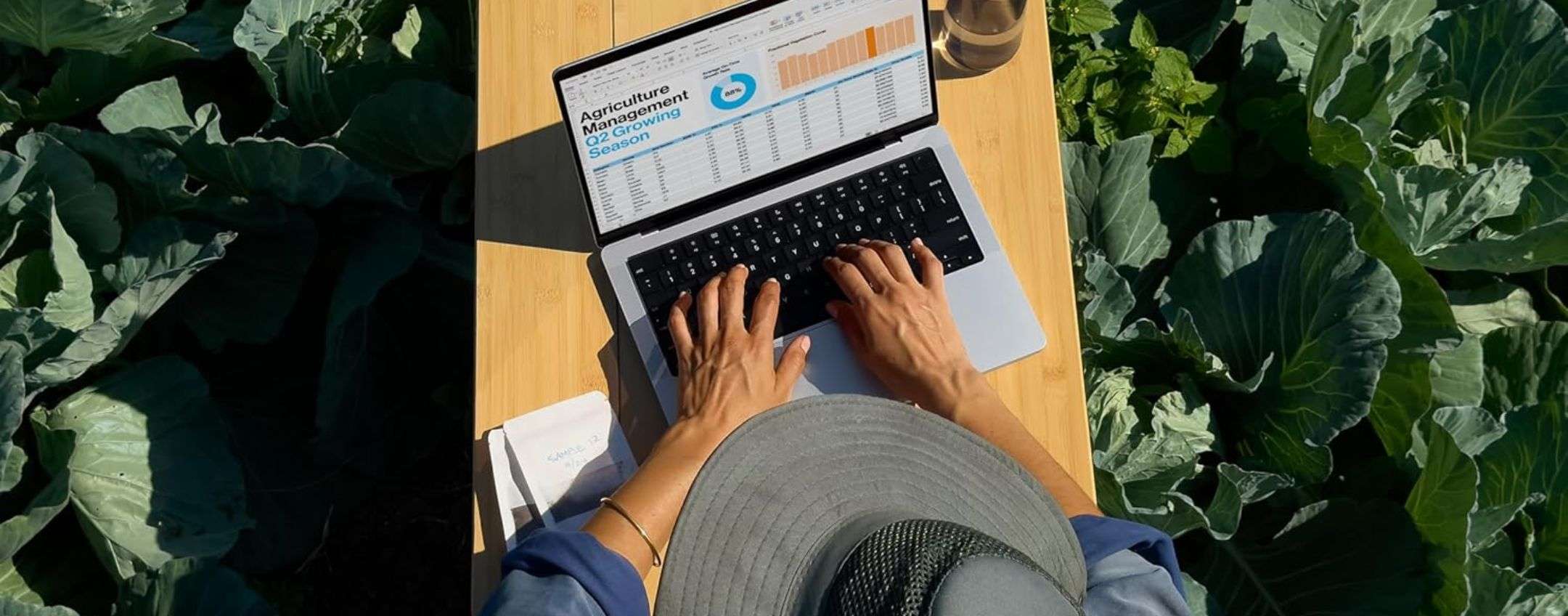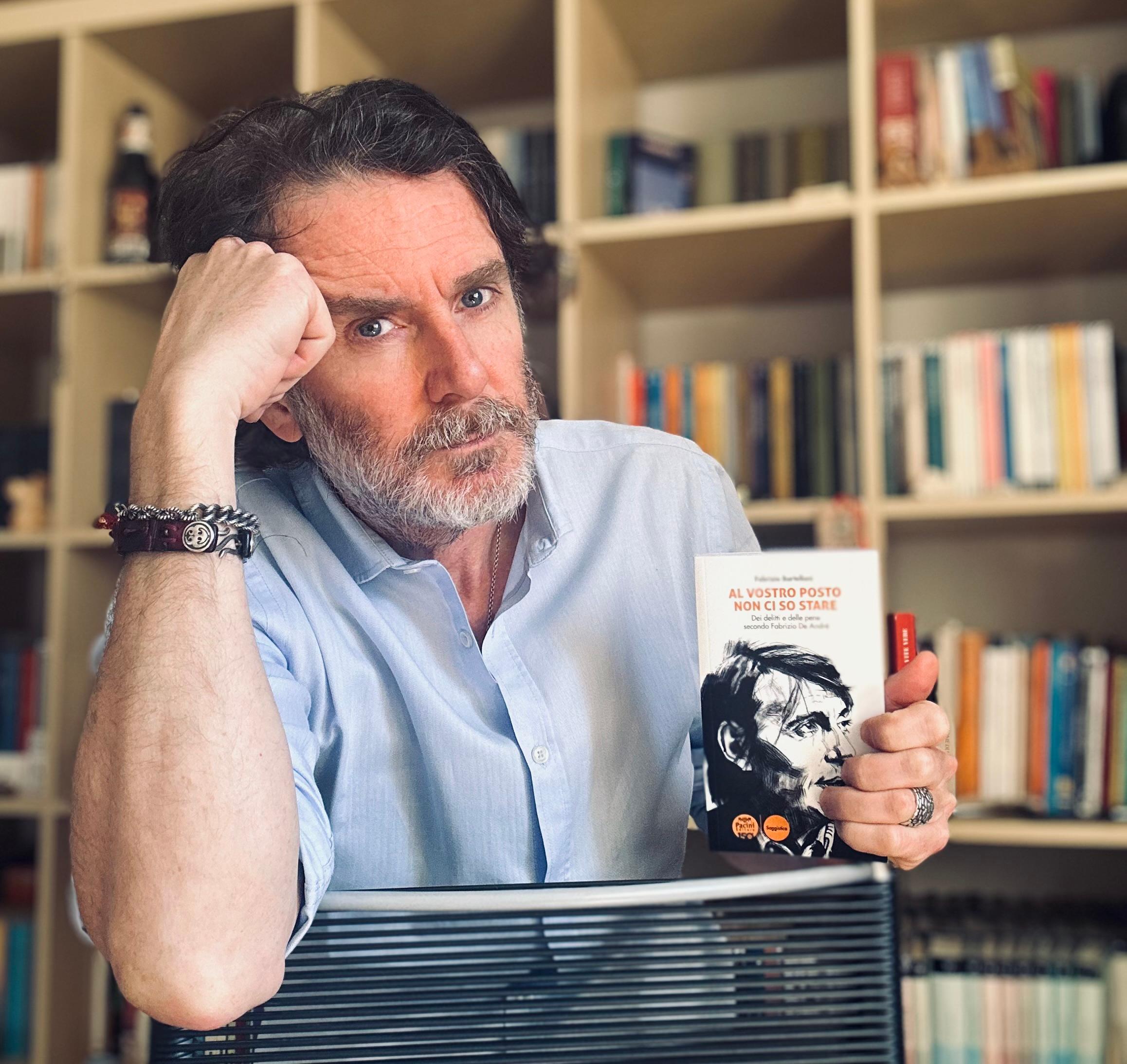La legge Basaglia rivalutava il senso di ‘normalità’: anche lo sport inclusivo si propone come alternativa
di Marco Pozzi In friulano “mato” è sinonimo di “uomo”, di “tizio”: “ho incontrato un mato”, senza discriminazioni sanitarie, come se la follia stesse naturalmente in ogni essere umano. E al di là del luogo comune Trieste-città-dei-matti, forse qualche collegamento c’è davvero, proprio nei luoghi in cui è nata la riforma di Franco Basaglia, che […] L'articolo La legge Basaglia rivalutava il senso di ‘normalità’: anche lo sport inclusivo si propone come alternativa proviene da Il Fatto Quotidiano.

di Marco Pozzi
In friulano “mato” è sinonimo di “uomo”, di “tizio”: “ho incontrato un mato”, senza discriminazioni sanitarie, come se la follia stesse naturalmente in ogni essere umano. E al di là del luogo comune Trieste-città-dei-matti, forse qualche collegamento c’è davvero, proprio nei luoghi in cui è nata la riforma di Franco Basaglia, che nel 1961 si trasferisce a Gorizia e dal 1971 appunto a Trieste.
Una settimana prima dell’approvazione della famosa legge che porta il suo nome, il 4 maggio 1978, sul Paese Sera scrive in risposta a Mario Tobino, psichiatra, scrittore, vincitore del Premio Strega nel 1962: “Non crediate, io stesso sono stato innamorato di Tobino e del suo manicomio, affascinato dai suoi scritti che parlavano con stile rarefatto della ineluttabile miseria umana. Ero ancora giovane assistente […]. Quando entrai però a lavorare nel manicomio di Gorizia l’impatto con la realtà fu del tutto diverso, ho potuto verificare ogni cosa, controllare ogni sensazione. Ebbene era tutto falso! Dove erano le donne oscene e cattive, quei bei personaggi femminili descritti dal Tobino? Nella realtà del manicomio non c’era da avere pietà e compiacersi della sofferenza ma soltanto lavorare duramente per abbattere giorno per giorno quei muri, quei camerini dove le ‘libere donne’ erano state recluse per anni soltanto perché non dessero fastidio a nessuno.”
C’è una rappresentazione letteraria e c’è la realtà: nella mente ci si costruisce immagini che nel mondo non esistono. Suggestione versus esperienza.
Quel “non c’era da avere pietà e compiacersi della sofferenza ma soltanto lavorare duramente per abbattere giorno per giorno quei muri”, ricorda alcune riflessioni dei giocatori di baskin, i quali spesso esprimono gratificazione se vengono corretti e rimproverati come qualunque atleta, e non commiserati come esseri a parte: è proprio la compassione che discrimina.
Franco Basaglia invitava ad incontrare le sue persone, non più recluse, ma che finalmente discutevano e si esprimevano. Stessa cosa con lo sport: non attraverso la parola ma attraverso un pallone, non attraverso un’assemblea ma su un campo, in un palasport. I contesti sono molto diversi, eppure una concezione accomuna. Qualcosa che non riguarda il singolo in sé ma la società in cui vive, l’istituzione che lo prende in carico. Un antico aforisma recita che “natura non facit saltus”. Se immaginiamo una retta, o un segmento, che rappresenti la capacità di un individuo di svolgere le azioni degli schemi motori di base ‒ camminare, correre, rotolare, saltare, arrampicarsi, lanciare, afferrare ‒, fra i due estremi di assoluta padronanza e assoluta inabilità, qual è il valore di soglia oltre il quale si parla di abilità e prima del quale si parla di disabilità? Per ogni valore ipotizzato, sempre ∃ ε≠0 che consenta di spostare prima o dopo il limite convenzionale, toccando ogni ipotizzabile valore nella continuità della retta R.
La spiegazione è un po’ troppo ingegneristica, d’accordo, ma il succo dovrebbe intendersi. La malattia mentale non è più irrecuperabile, ma un’infinita sfumatura di gradazione che tracciano lo spazio fra sanità e follia, così come nello sport è fra neurotipico e disabilità. Al netto ovviamente dei casi specifici, che coinvolgono anche la sicurezza collettiva, c’è qualcosa che unisce le disabilità e la salute mentale, poiché nessuno può dirsi perfettamente sano e nessuno perfettamente savio, così come nessuno è perfettamente malato o pazzo (viene in mente il personaggio del principe Myskin nel romanzo L’idiota, nel quale Fëdor Dostoevskij voleva rappresentare “l’uomo assolutamente buono”).
Come modello alternativo alla reclusione prima della legge Basaglia, anche lo sport inclusivo si propone come istituzione alternativa/complementare al modello olimpico e a quello paralimpico, che includono ed escludono abilità e disabilità, secondo una certificazione medica, in modo come un operatore logico booleano: o uno o l’altro, on/off. Dentro o fuori.
Il concetto di “normalità” invece si muove nell’insieme delle possibilità e varia a seconda delle epoche e delle latitudini. “Normalità” sancisce un limite, di ciò che ci sta intorno o che vi si allontana, più o meno, in direzioni diverse; è un centro di gravità, per dare appoggio alle pratiche individuali e collettive. È il valore di soglia in una tabella, l’indicatore fra dati più o meno misurabili, il responso di una perizia, o il risultato di un test. Messa così, non sarà soltanto suggestione?
Su Raiplay si può vedere I giardini di Abele, documentario del 1968 di Sergio Zavoli con Franco Basaglia, girato nel manicomio di Gorizia.
L'articolo La legge Basaglia rivalutava il senso di ‘normalità’: anche lo sport inclusivo si propone come alternativa proviene da Il Fatto Quotidiano.