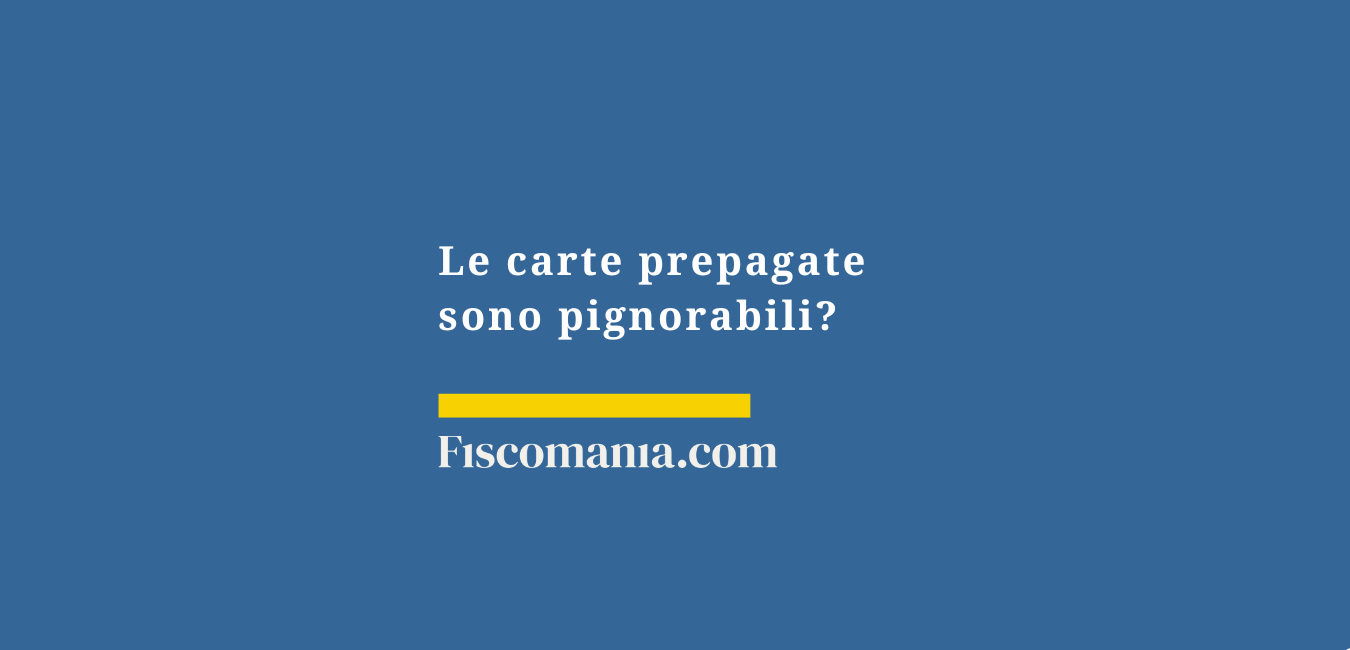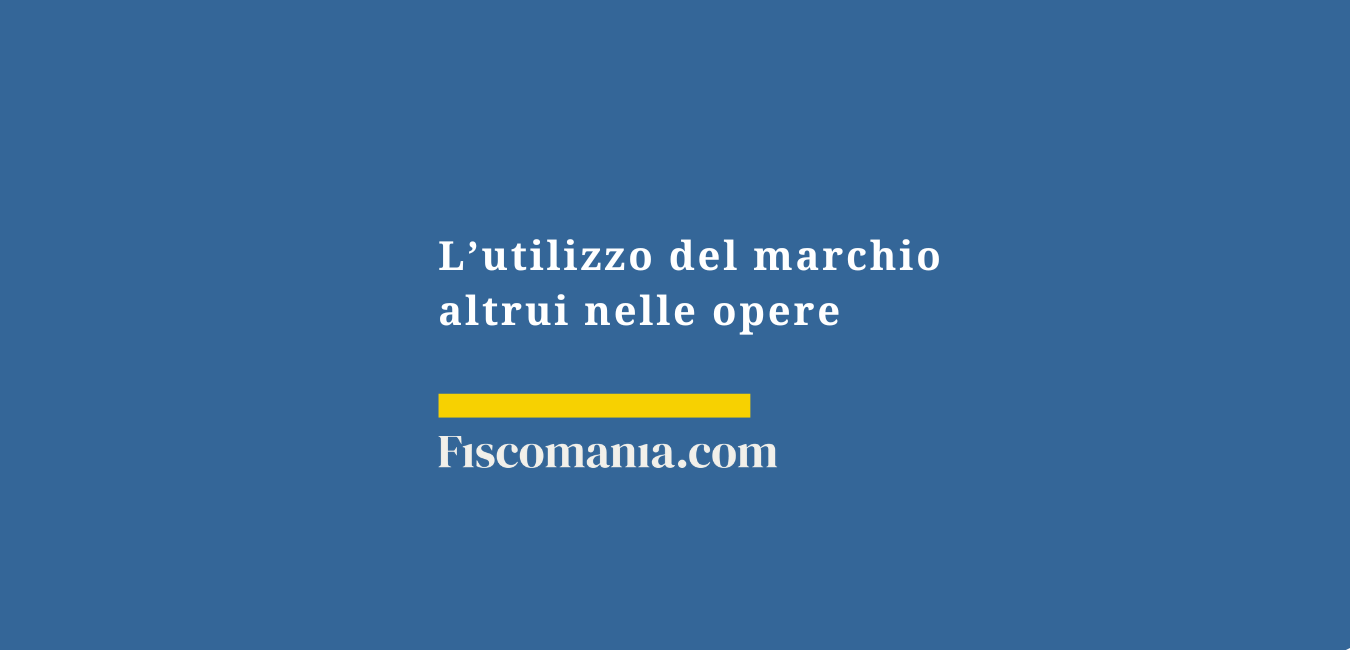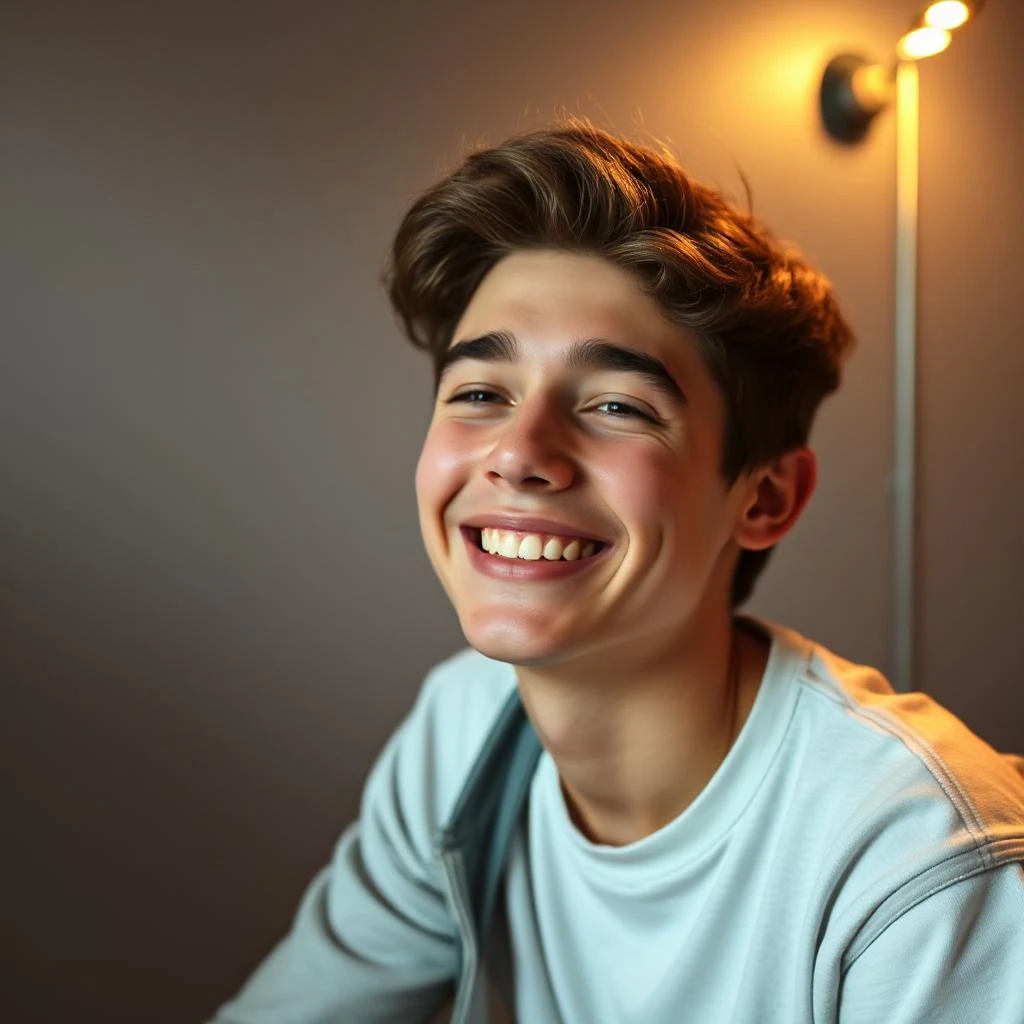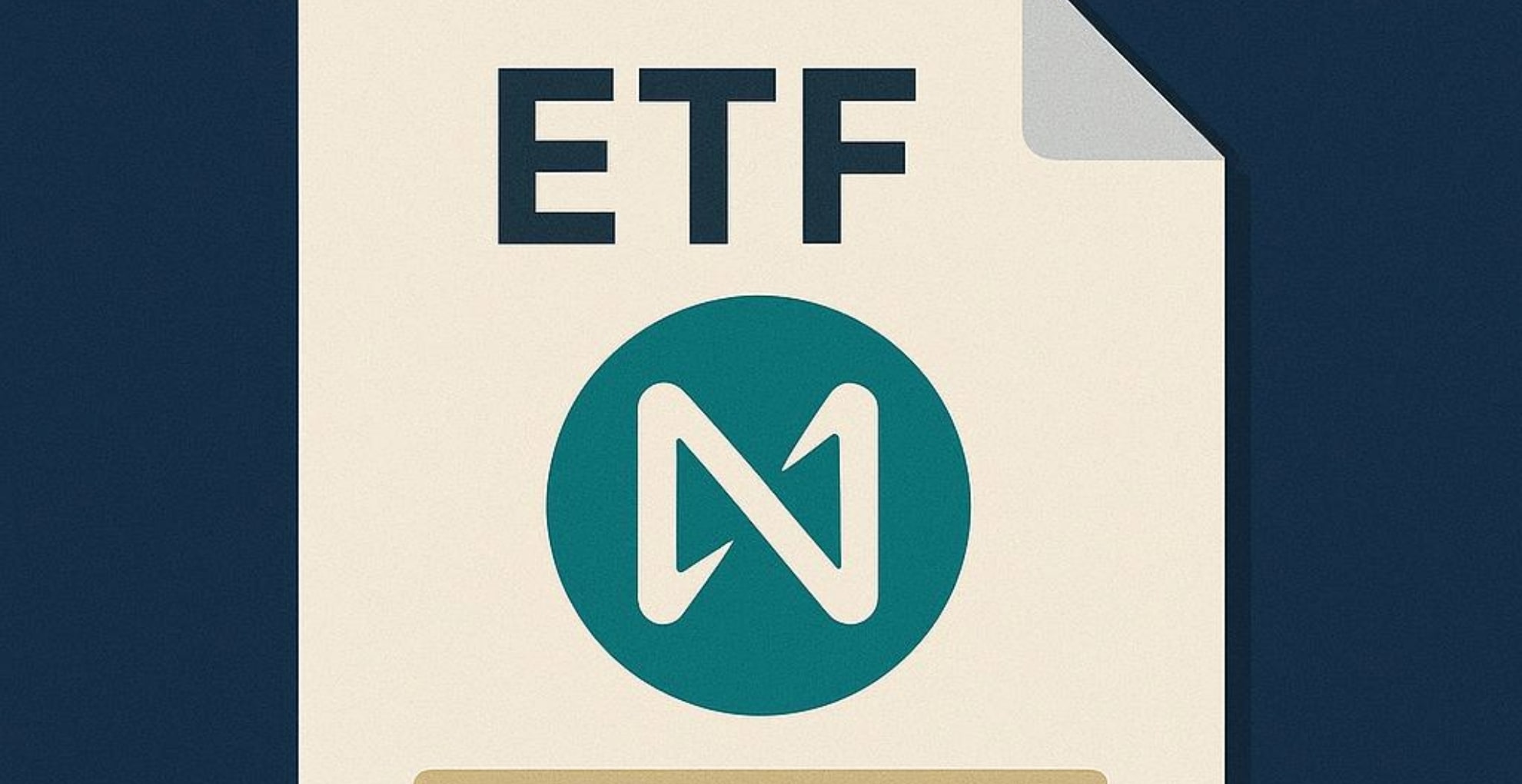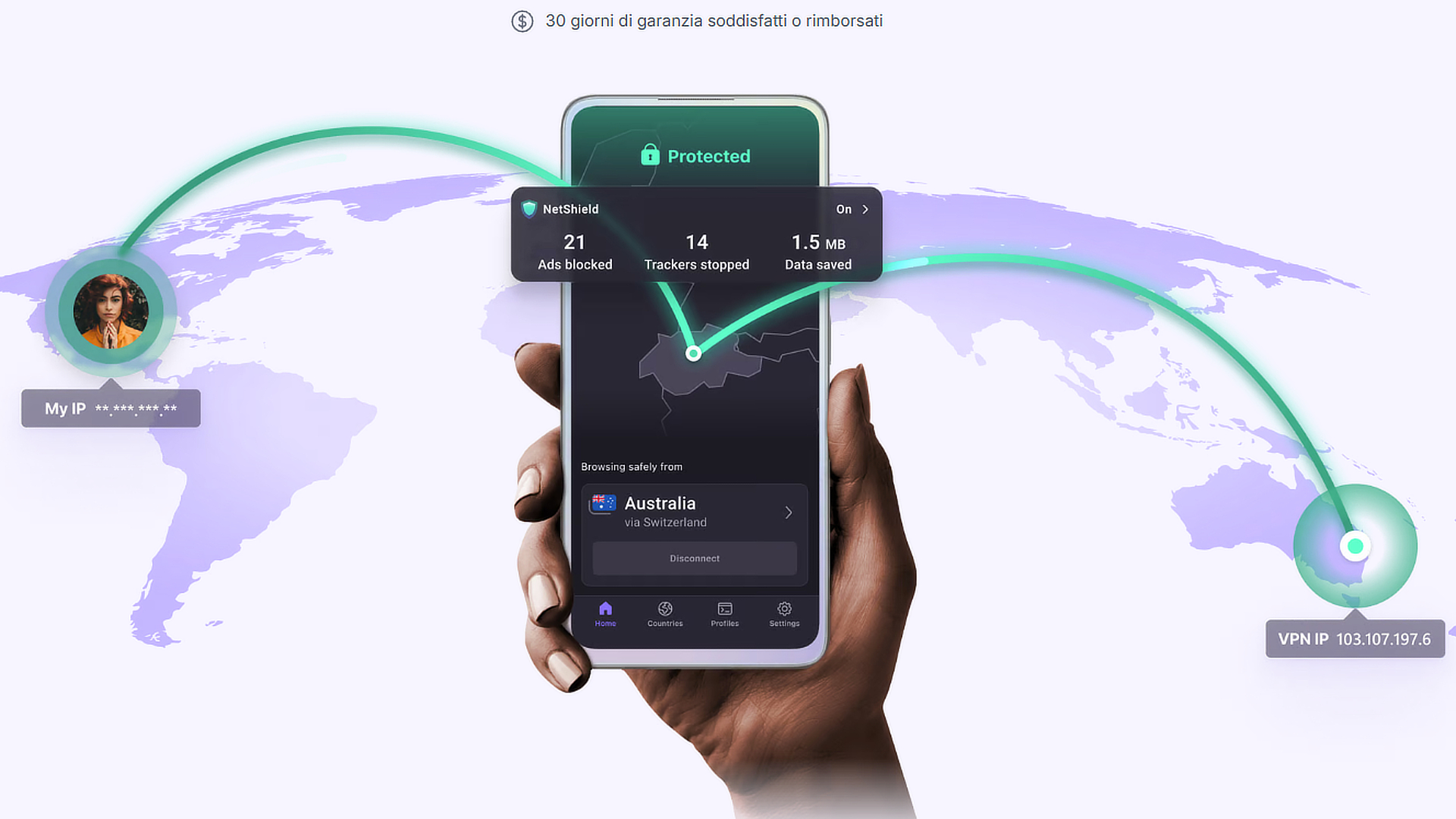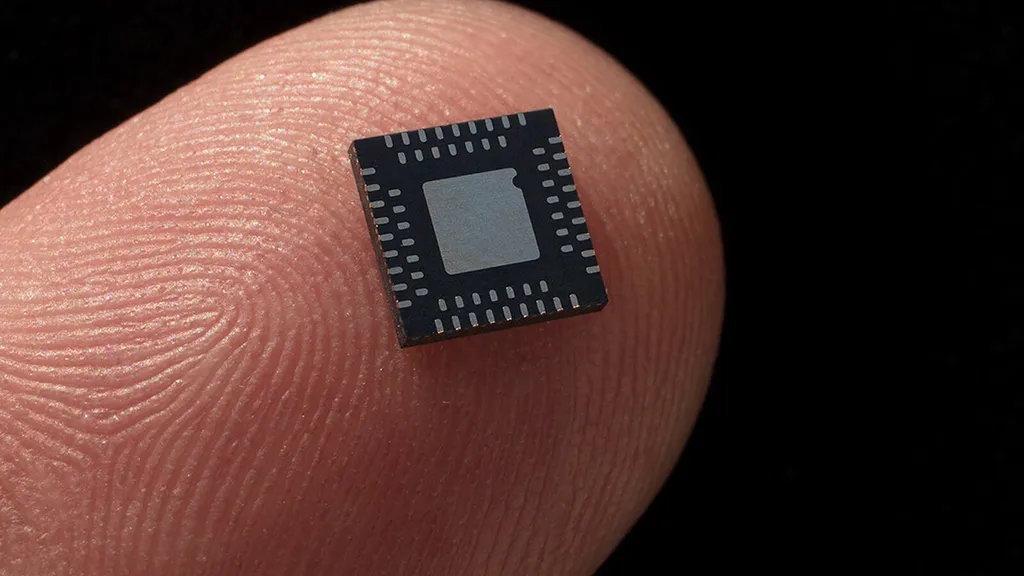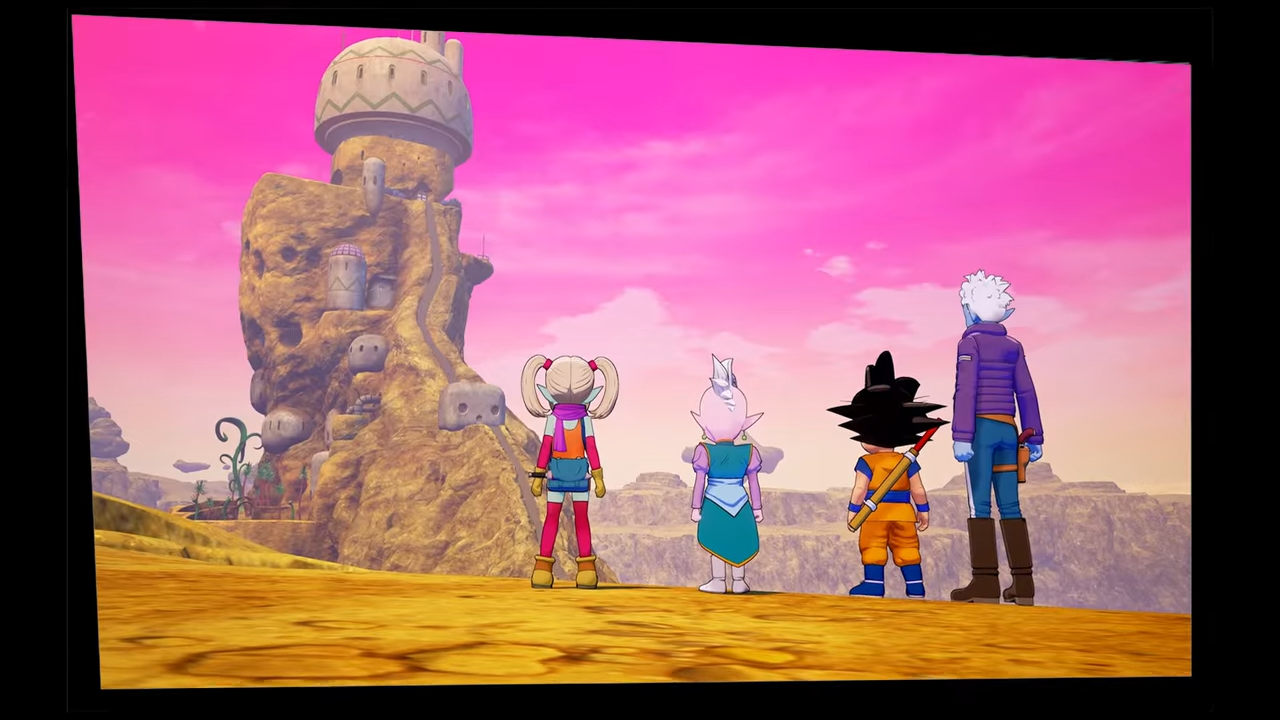La Corte dei Conti Ue fa a pezzi il Next generation Eu di von der Leyen: “Impossibile misurare se si è speso bene e con quali risultati”
La Corte dei conti Ue boccia sonoramente il Next generation Eu di Ursula von der Leyen, arrivato a metà percorso. Lo strumento da oltre 800 miliardi creato al culmine della pandemia per risollevare l’economia del Vecchio continente affossata dalle conseguenze del Covid risente di una serie di gravi peccati originali, secondo l’organo indipendente di controllo. […] L'articolo La Corte dei Conti Ue fa a pezzi il Next generation Eu di von der Leyen: “Impossibile misurare se si è speso bene e con quali risultati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Corte dei conti Ue boccia sonoramente il Next generation Eu di Ursula von der Leyen, arrivato a metà percorso. Lo strumento da oltre 800 miliardi creato al culmine della pandemia per risollevare l’economia del Vecchio continente affossata dalle conseguenze del Covid risente di una serie di gravi peccati originali, secondo l’organo indipendente di controllo. Si concentra sui progressi nell’attuazione invece che sugli effettivi risultati ottenuti, non prevede la raccolta di informazioni dettagliate sui costi effettivi delle misure finanziate, non definisce chiaramente le condizioni per ottenere i pagamenti, non garantisce un’adeguata protezione degli interessi finanziari della Ue dalle frodi. Ciliegina sulla torta, l’emissione di debito comune per finanziarlo si è rivelata molto più costosa del previsto e il debito contratto, sommato agli interessi, “eserciterà una notevole pressione sui futuri bilanci dell’Ue”. Abbastanza per far dire a una dei due auditor Ue responsabili dell’analisi, Ivana Maletić, che in futuro “andrà evitato che strumenti simili siano gestiti senza disporre di informazioni sui costi effettivi e sui beneficiari finali” o “cosa si ottiene realmente”.
L’analisi, presentata martedì, parla di criticità fin dal titolo: Orientamento alla performance, obbligo di rendicontazione e trasparenza: cosa insegnano le criticità dell’RRF. Il focus è sull’utilizzo delle risorse del cosiddetto “dispositivo per la ripresa e la resilienza”, cuore del Next generation Eu, noto in Italia come Pnrr. “Anche se ha svolto un ruolo cruciale nella ripresa post-pandemica dell’UE”, è la conclusione tranchant della Corte, “le informazioni sui risultati sono scarse e quelle sui costi effettivi sono inesistenti. Di conseguenza, non è chiaro quello che i cittadini ottengono in concreto grazie a questi fondi. La Corte invita i responsabili delle politiche UE a tener conto di quanto appreso dall’RRF al momento di elaborare nuovi strumenti con finanziamenti basati sulla performance e non sui costi”. Il tasto più dolente infatti è proprio questo: il meccanismo in base al quale i pagamenti si basano sul conseguimento da parte degli Stati membri dei traguardi e obiettivi previsti dal loro piano concordato con Bruxelles si è dimostrato tutt’altro che virtuoso, spiega il documento, perché quelle milestone si focalizzano “sulle realizzazioni anziché sui risultati” e sui costi stimati anziché quelli effettivi. Non mancano casi in cui i secondi sono risultati inferiori ai primi, in base ai quali è stato erogato il finanziamento. Con evidente spreco di risorse. Non solo: ne deriva che “l’efficienza della spesa e il rapporto costi-benefici non possono essere misurati“.
Si dirà che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a monitorare i progressi. Poi riportati in una piattaforma interattiva che distingue la spesa per ognuno dei sei pilastri. Ma “ciascun traguardo e obiettivo nell’ambito di un determinato PNRR ha lo stesso valore unitario”, replica la Corte, “che non riflette né il costo effettivo né il costo stimato della misura in questione e neppure la natura del traguardo o dell’obiettivo. Questo modo di presentare i progressi compiuti nell’ambito dei sei pilastri è fuorviante“. Non basta: spesso, ha riscontrato la Corte, gli Stati membri “hanno trasmesso alla Commissione dati inattendibili o non confrontabili“, su cui la Commissione “effettua solo basilari controlli di plausibilità”. Il risultato è che “l’attendibilità dei dati risulta ridotta”.
In questo quadro di scarsa trasparenza, il ritmo di assorbimento dei finanziamenti da parte dei Paesi sconta notevoli ritardi: a metà 2024 oltre la metà delle richieste di pagamento non era stata presentata entro i termini (fa eccezione l’Italia, che arranca sulla spesa effettiva ma le rate le ha chieste per tempo). Inoltre aver ricevuto i fondi non significa affatto che “abbiano raggiunto i destinatari finali e l’economia reale”: in una precedente relazione, sulla base dei dati su 15 Stati membri, la Corte ha rilevato che solo la metà dei fondi versati era arrivato a destinazione. Nonostante le misure vadano completate entro agosto 2026, alla fine dello scorso anno “la maggior parte dei traguardi e degli obiettivi doveva ancora essere conseguita in misura soddisfacente”. Ma almeno quello che è stato fatto ha contribuito a rispondere alle sfide principali che la Commissione si era posta, cioè la transizione energetica e quella digitale? La risposta della Corte è negativa: “L’RRF ha contribuito in misura limitata a raggiungere gli obiettivi dell’UE di livello più elevato e a rispondere alle sfide strutturali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese”. La maggior parte delle misure digitali e per il mercato del lavoro incluse nel campione ha conseguito le realizzazioni previste, ma finora “solo la metà circa di esse mostra risultati”. Quanto agli obiettivi climatici, “il contributo finanziario dell’RRF è verosimilmente sovrastimato”: gli audit della Corte hanno mostrato che alcuni coefficienti climatici (quelli per le ferrovie, le reti elettriche e i nuovi edifici) conducono a stime in eccesso, ad esempio perché non tengono conto delle emissioni di gas a effetto serra nella fase di costruzione”.
Tutto questo è costato caro alle casse della Ue, che al 30 giugno 2024 aveva emesso obbligazioni per quasi 360 miliardi di euro per finanziare il piano. Le prime sono state emesse quando i tassi erano bassi, ma poi i costi di finanziamento sono saliti. Tanto che “vi è il rischio che entro il 2026 i costi di finanziamento per i prestiti contratti per NGEU possano più che raddoppiare rispetto alla stima iniziale” di 14,9 miliardi. Il rimborso del debito contratto è a carico del bilancio dell’Ue. La Commissione aveva proposto di rimborsarne una parte con nuove risorse proprie da introdurre entro l’inizio del 2023, ma non se n’è fatto nulla per mancanza di accordo politico. Di qui una “notevole pressione sui futuri bilanci dell’Ue”.
Conclusione delle 66 pagine di analisi: il piano che von der Leyen ha rivendicato come “storico” è stato viziato da una sequela di errori da non ripetere: “I finanziamenti dei futuri strumenti basati sulla performance dovranno essere meglio collegati ai risultati e disciplinati da regole chiare: altrimenti, questo sistema non andrebbe utilizzato”, ha detto Jorg Kristijan Petrovič, coautore dell’analisi.
L'articolo La Corte dei Conti Ue fa a pezzi il Next generation Eu di von der Leyen: “Impossibile misurare se si è speso bene e con quali risultati” proviene da Il Fatto Quotidiano.