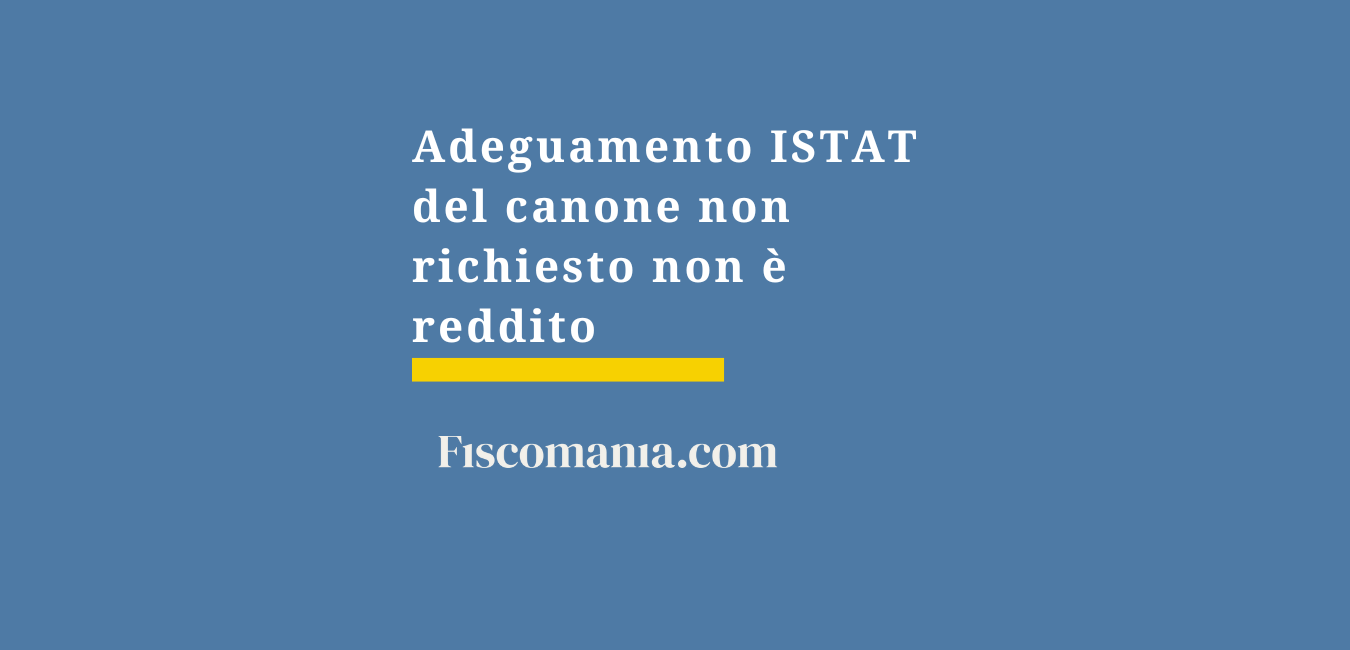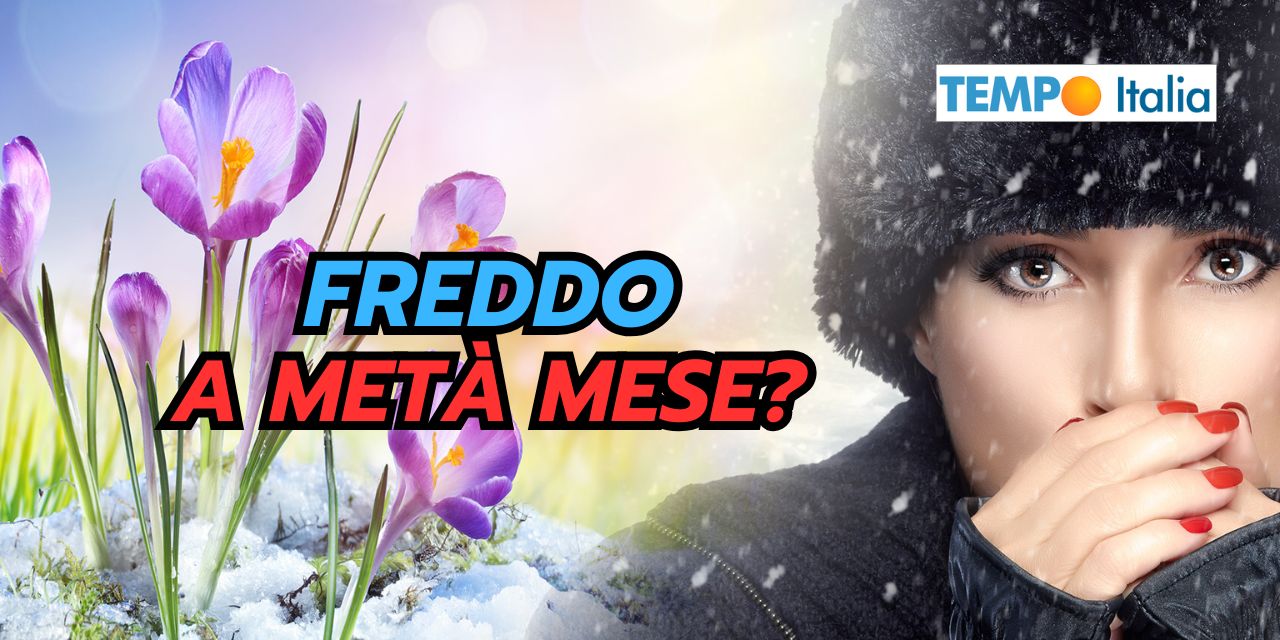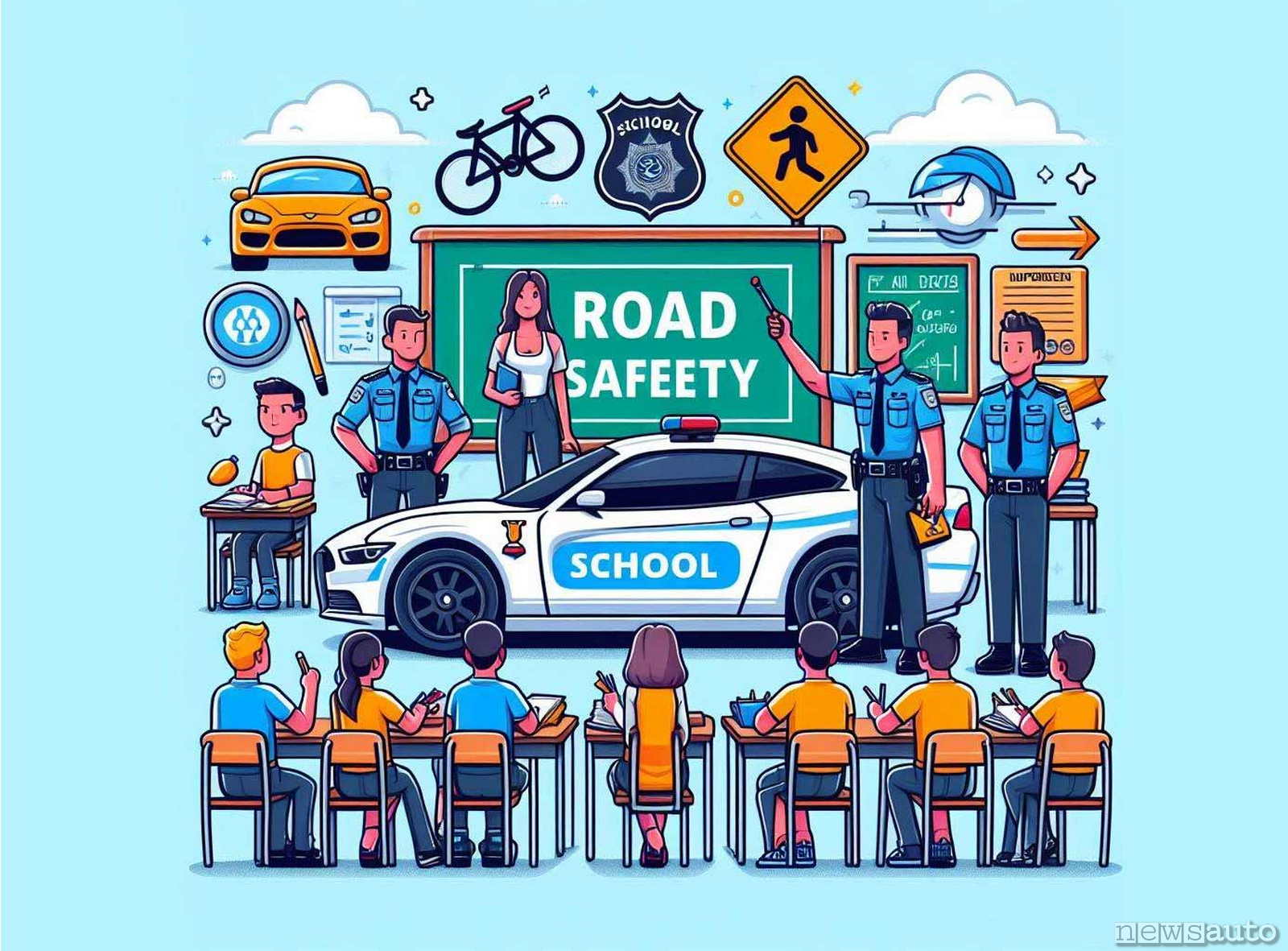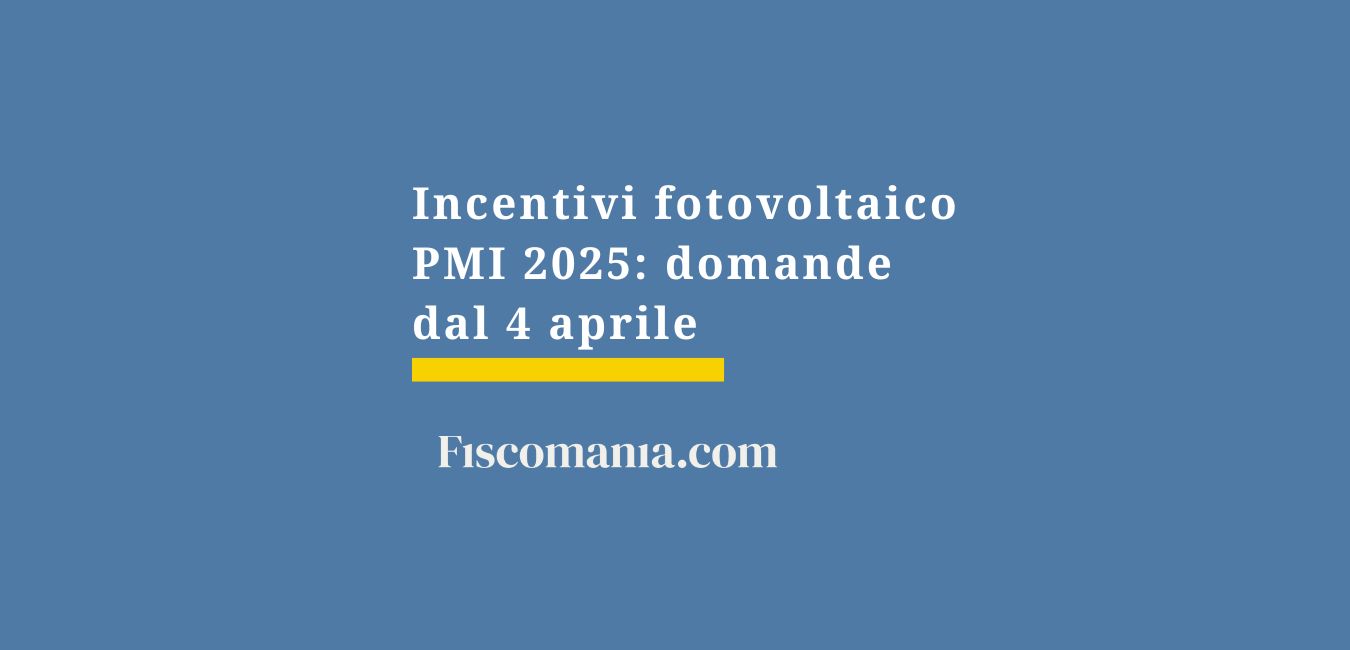Il “compito” della scienza giuridica e i suoi spaesamenti
“Agli ignavi non si addice il mestiere del giurista” (D. Valitutti, La bella addormentata, p. 108) Silete, theologi, in munere alieno. Notissimo è l’antico monito che Alberico Gentili rivolgeva, alla […]

“Agli ignavi non si addice il mestiere del giurista”
(D. Valitutti, La bella addormentata, p. 108)
Silete, theologi, in munere alieno. Notissimo è l’antico monito che Alberico Gentili rivolgeva, alla fine del XVI secolo, ai teologi e alla loro pretesa di conformare il mondo – e ogni ipotesi di conoscenza di esso – ad una Veritas che, in tempi di guerre di religione, non era più “eguale” per tutti. Un imperativo, quello gentiliano, che aveva anche il sapore di un’actio finium regundorum tra le “scienze”, reclamando l’irriducibile autonomia della scienza giuridica.
Questa stessa autonomia, oggi, appare minacciata dall’economicismo neoliberale e dalla tecnica scatenata di schmittiana memoria, in un contesto nel quale, per dirla con Foucault, “il successo ha preso il posto della legittimazione”[1], sicché le stesse “forme” giuridiche sembrano essere sempre più subordinate (e funzionalizzate) alla “sostanza” non già di principi di giustizia (che, negli ordinamenti contemporanei, sono anch’essi positivizzati – e, quindi, pur sempre “formalizzati” – nelle Costituzioni) ma di un “risultato” ottimale, tecnico-economico, secondo termini efficientistici[2]. La “situazione storico-spirituale” dello Stato della società industriale di forsthoffiana memoria[3], insomma, altro non sarebbe che quella in cui la tecnica stessa – secondo il suggerimento di Emanuele Severino nel celebre dialogo con Natalino Irti[4] – si è trasformata nella Grundnorm dell’Ordinamento.
Tornare ad interrogarsi sul metodo e sul problema dell’autonomia della scienza giuridica, come fa Dante Valitutti nel suo prezioso volume dato alle stampe per i tipi dell’Editoriale Scientifica (D. Valitutti, La bella addormentata. La scienza del diritto e il ‘problema’ della sua autonomia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 1-373), appare perciò tutt’altro che un compito inattuale. Al contrario, è, quella odierna, l’occasione sia per una doverosa rimeditazione, attraverso i classici della teoria del diritto, dello statuto gnoseologico della scienza giuridica – in un’era in cui lo “scettro” della Giurisprudenza, “intesa come la scienza capace di guidare la legislazione e la giurisdizione”, pare essere stato “deposto da tempo” (così l’A., p. 13) – attraverso una “auto-riflessione” sul metodo (posto che, per il Carnelutti evocato dall’A., “il diritto equivale al suo metodo”: p. 19), sia, correlativamente, per rivendicare il ruolo “attivo” del giurista, che, secondo la lezione di G. U. Rescigno, “proprio perché descrive il diritto vigente, coopera alla costruzione del diritto vigente”[5].
Per Valitutti la stessa capacità conformativa del diritto – il che significa: la sua intima “missione” ordinante (come ha ribadito recentemente Massimo Luciani nel suo ultimo libro[6]) – richiede una scienza giuridica consapevole del suo ruolo: evocando, nel primo capitolo, lo Schmitt lettore di Savigny de La situazione della scienza giuridica europea[7], per l’A., “se lo Ius si dà di principio autonomamente (…) nel lavoro di ‘intermediazione’ di uno o più soggetti differenti durante il processo della loro applicazione” – è il sentiero della Rechtsverwirklichung originantesi dalla cooperazione di tutti i “formanti” – “che le singole norme prendono vita, incidendo sulla realtà” (p. 39). È in questi termini, così, che Valitutti legge la stessa critica schmittiana (o, almeno, dello Schmitt del ’50, preoccupato di lasciare in sordina il decisionismo degli anni Trenta) al “positivismo legale-statualistico in voga nella seconda metà del XIX secolo” (p. 56). Ciò non significa, però, si badi, rinunziare alla pretesa di calcolabilità cara ai positivisti: respingere l’aspirazione alla calcolabilità assoluta (ibidem) non vuol dire rifiutare in toto l’idea di un diritto che è, ontologicamente, “ragione e prevedibilità”[8]. Anzi, Valitutti ha ben chiaro, proprio sulla scia dello scritto schmittiano, nell’era della prassi della “legge o del decreto motorizzato” – la quale non permette più “alla scienza giuridica un ampio margine di manovra per la sua attività di commento e di rielaborazione critica della statuizione positiva” (p. 67) –, che la pretesa del diritto alla prevedibilità subisce una crisi profonda. Una crisi che sembra oggi raggiungere il suo acmé, in un contesto nel quale, per dirla con Natalino Irti, il contrasto tra razionalità tecno-economica e razionalità giuridica spinge la prima forma di sapere a divergere così radicalmente da quello giuridico da impedirgli “di offrire il ‘prevedere’, ossia il calcolo del domani”[9].
Crisi di prevedibilità che, non a caso, si accompagna talora ad una pericolosa “oscurità” della produzione normativa, che crea inevitabilmente – per citare la meritoria sentenza n. 110 del 2023 della Corte costituzionale (di cui Valitutti valorizza anche la rivendicazione della centralità degli “strumenti dell’esegesi normativa”) – “le condizioni per un’applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell’art. 3 Cost.”.
Un duplice scacco, evidentemente, per la scienza giuridica, che, per il Valitutti lettore del “secondo” Schmitt, dovrebbe invece “ricevere dal legislatore il diritto vigente”, “criticare, se necessario, quel diritto vigente” e “contribuire a rideterminarlo, dopo averlo criticato, facendosi nel caso indispensabile strumento ‘di filtro’ tra il potere politico che fa le leggi e quello giudiziario che deve applicarle” (pp. 88-89).
Certo, è pur vero che, sebbene siano innegabili le “sfide” del contemporaneo, la discussione sul “problema” dell’autonomia della scienza giuridica non è affatto nuova. E lo stesso Valitutti, naturalmente, ne è consapevole, come traspare dallo sforzo ricostruttivo del secondo capitolo, dedicato a Kirchmann. “Tre parole di rettifica del legislatore, ed intere biblioteche diventano carta straccia”; “la legge positiva fa del giurista un verme nel legno marcio”: sarebbe troppo semplice evocare questi celebri dicta di un autore per il quale “la scienza giuridica non può farsi scienza (…) perché è il diritto come oggetto (…) a non poter essere compreso come oggetto di scienza” (p. 121). Ma Valitutti, che dell’autonomia della scienza giuridica è alfiere, di Kirchmann mette in luce con abilità il “paradosso”: “quello cioè di uno studioso (…) che critica aspramente la perenne mobilità del dato normativo – architrave concettuale su cui si fonderebbe proprio quel sistema della legalità osteggiato da Schmitt – e, al tempo stesso, tuttavia, rifugge ideologicamente da chi, a quella mobilità – che, spesso si traduce in instabilità – del diritto, ha risposto tentando di offrire una lettura con un riferimento proprio agli schemi della Legitimität” (com’è il caso di quel Savigny tanto caro allo Schmitt del primo capitolo di Valitutti).
Uno spazio per l’autonomia della scienza giuridica, comunque, rimane aperto. Ed è quello che l’A. coltiva sin dal finire del secondo capitolo: la scienza del diritto come “politica del diritto”, che “studia il diritto”, per dirla con l’Erik Wolf del ‘53[10], “non solo come è, ma anche come deve essere”: “critica del diritto (positivo) così come esso è nel presente per renderlo (o tentare di renderlo) come dovrebbe essere nel futuro” (p. 167). Il che vuol dire, “in un ordinamento a costituzione rigida, scritta e lunga”, che “ogni considerazione immanente al piano del diritto (positivo) che sia (…) alla ricerca dei suoi scopi non può che tener conto del quadro dei principi costituzionali inscritti in quel piano” (p. 189).
Non stupisce, allora, considerate queste conclusioni, se Valitutti sottoponga a critica, nel terzo capitolo, la filosofia analitica del diritto, che avrebbe disconosciuto, da Bobbio in avanti, “il problema ontologico” della scienza giuridica (pp. 198 ss.), respinto come “metafisico” e, perciò, suscettibile di ideologismo. Eppure, si è giuristi (analitici), secondo il modello scarpelliano, in funzione di una precisa “scelta di campo” (p. 250): per riprendere Mario Jori, “una scelta favore di un ordinamento o di un tipo di ordinamento”, quello democratico-costituzionale, “viene elevata a scelta di metodo per ‘la’ scienza giuridica”[11]. Ma che un ordinamento sia qualificabile come democratico e costituzionale, a ben vedere, dipende pur sempre dal diritto positivo (cos’è la Costituzione se non diritto positivo, ancorché supralegislativo?), non da un “postulato” che si pretende come fondamento del metodo della scienza giuridica in quanto tale.
Per Valitutti, così, diventa più utile recuperare un altro filone della filosofia del diritto italiana, che passa attraverso Ascarelli e Capograssi. Valitutti valorizza, sulla scia del secondo, “la dimensione relazionale e concreta dell’esperienza giuridica”, per presentare il giurista, sulle orme del primo, “quale custode di questa esperienza” (p. 287). L’ordinamento, “l’insieme delle norme di un sistema giuridico”, “è – può presentarsi – al tempo, come dato (al giurista) e come costruito (dal giurista)”, il che implica che lo studioso del diritto – anzi, la “comunità” degli studiosi (posto che la pratica interpretativa è sempre una “pratica con-divisa”: p. 319) – ne è sia custode che creatore (p. 290).
Un giurista immerso in una “comunità”, nella vivida carne dalla Storia (Orestano docet: p. 348), che si inserisce in un “contesto della tradizione” (p. 371): questa è l’immagine di giurista che, in ultima istanza, Valitutti ambisce a ri-costruire, difensore dell’autonomia della scienza giuridica e argine intellettuale alle derive dell’economicismo, della tecnica e, correlativamente, dell’anomia.
Un giurista consapevole del suo Beruf: che non è semplice professione, ma, in ultima istanza, un compito, una vocazione, una missione.
[1] M. Foucault, La nascita della biopolitica, trad. it. Feltrinelli, Milano, 2017, pp. 27 ss.
[2] In argomento, v. R. Bin, La sostituzione dei giuristi con i tecnici: i cambiamenti indotti nella pubblica amministrazione, in Consulta Online, 1/2024, pp. 285 ss.
[3] E. Forsthoff, Lo Stato della società industriale, trad. it. Giuffrè, Milano, 2011.
[4] N. Irti – E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma-Bari, 2001.
[5] G. U. Rescigno, Il giurista come scienziato, in Diritto pubblico, 3/2003, p. 847.
[6] M. Luciani, Ogni cosa al suo posto, Giuffrè, Milano, 2023.
[7] C. Schmitt, La situazione della scienza giuridica europea, trad. it. Quodlibet, Macerata, 2020.
[8] M. Luciani, Ogni cosa al suo posto, cit., p. 27.
[9] N. Irti, Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino, 2016, p. 16.
[10] E. Wolf, Fragwürdigkeit und Notwendigkeit der Rechtswissenschaft, Freiburg, 1953.
[11] M. Jori, Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi, Giuffrè, Milano, 1987.