Rivista di Diritto del Risparmio
Sul tasso effettivo di un prestito (“TAEG”)[*]
di Fabrizio CACCIAFESTA [**]
In un articolo apparso di recente su questa Rivista, gli Autori ripercorrono la storia della scelta, da parte della Commissione Europea, del TAEG in interesse composto (d’ora in avanti, TAEG sic et simpliciter) come indicatore sintetico di costo ufficiale ed obbligatorio per le operazioni di credito; e criticano la delibera, esprimendo l’opinione che il “TAEG in interesse semplice” (d’ora in avanti: TAEGis) avrebbe migliori qualità informative.
Dalla lettura ci sembra però che si possano trarre conclusioni non corrette. Crediamo opportuno evidenziarle, visto che l’argomento, connesso con la pratica dei contratti di prestito, pare destinato a restare di attualità, e attira l’interesse di molti non specialisti. Informazioni inesatte, o mal interpretate, possono alimentare una conflittualità pretestuosa, e dannosa per gli attori.
In sintesi, e come illustreremo nei prossimi paragrafi: contrariamente a quanto affermato nell’articolo, il TAEG non è stato inventato nel 1984 da un economista belga, ma è in uso da sempre (v. par. 2); la sua sostituzione con un TAEGis è concettualmente impensabile (par. 3), e – soprattutto – non sarebbe di alcun vantaggio per gli utilizzatori del credito (par. 4): i contratti non risulterebbero né più convenienti, né meglio comprensibili. Non è affatto vero che, fuorviata, la Comunità Europea abbia con la sua decisione autorizzato le banche ad applicare l’interesse composto nei loro rapporti con la clientela. Come, per ottime ragioni, si insegna a fare nelle università, gli operatori impiegano la legge dell’interesse composto per effettuare le loro valutazioni, ma questo non implica che facciano pagare interessi anatocistici quando concedono un prestito.
Dobbiamo però ammettere, lo diciamo con imbarazzo, che i colleghi incaricati dal Parlamento Europeo di riferire sull’argomento (nel seguito, “i Consulenti”; tra quelli nominati nell’articolo citeremo Kirschen, Seckelman e Soto) avrebbero potuto svolgere il loro compito in modo più soddisfacente. Precisiamo che non abbiamo letti per intero i loro contributi: il nostro giudizio si basa solo sui brani riportati, alquanto deludenti e non privi di errori anche rilevanti (par. 5). Ciò, comunque, nulla toglie alla validità delle loro conclusioni: che sono, correttamente, per l’assoluta irrinunciabilità e validità dello strumento TAEG.
________________________
[*] Contributo approvato dai referee.
[**] Già professore ordinario di Matematica Finanziaria presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia.















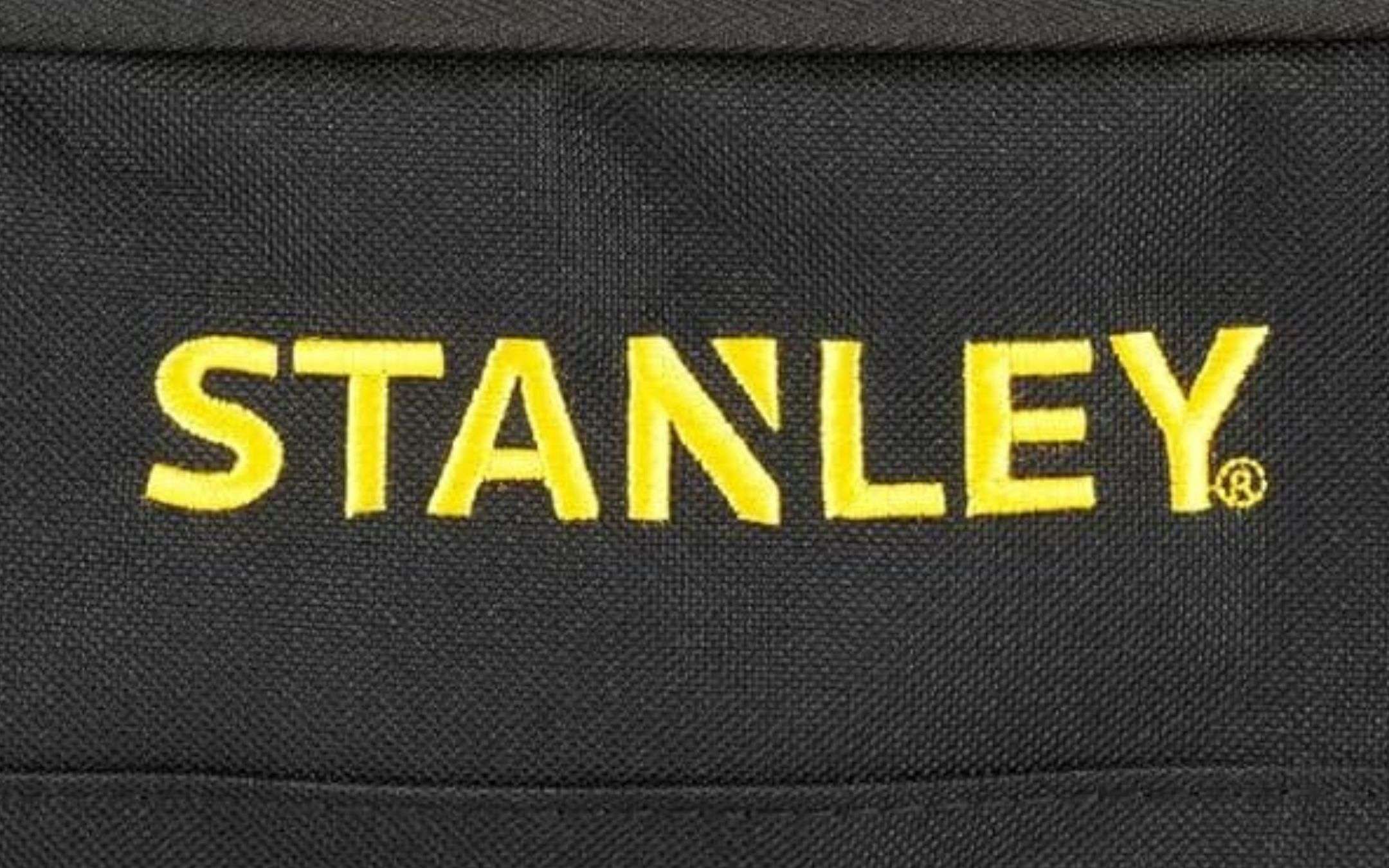

































![Alfa Romeo 164, Lancia Thema 8.32 e Saab 9000 Aero, le gemelle diverse [VIDEO]](https://www.autoblog.it/app/uploads/2025/04/51720826_2471848919553348_653438287213494272_n-1.jpg?#)





 Iscriviti alla nostra newsletter settimanale
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

