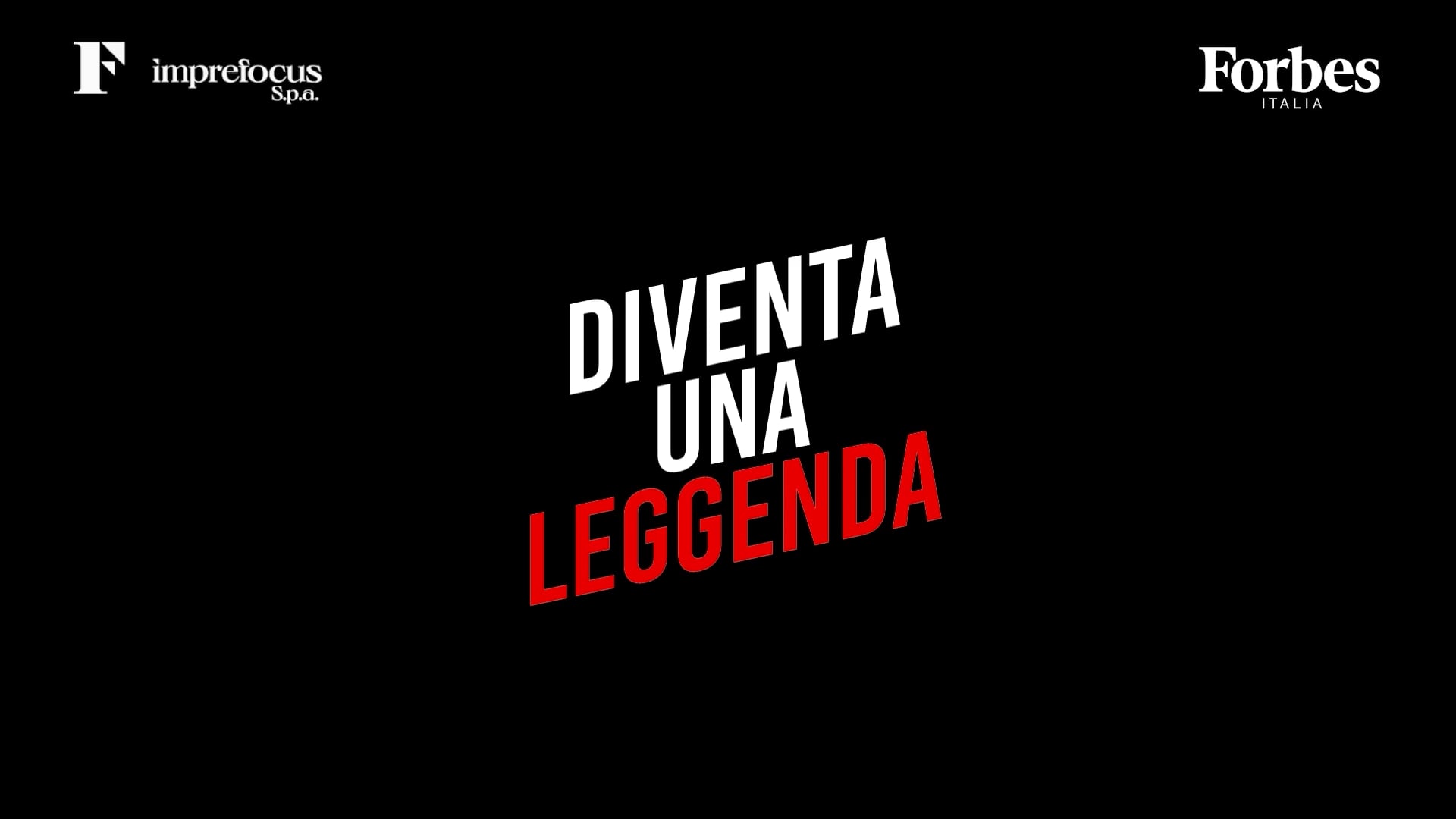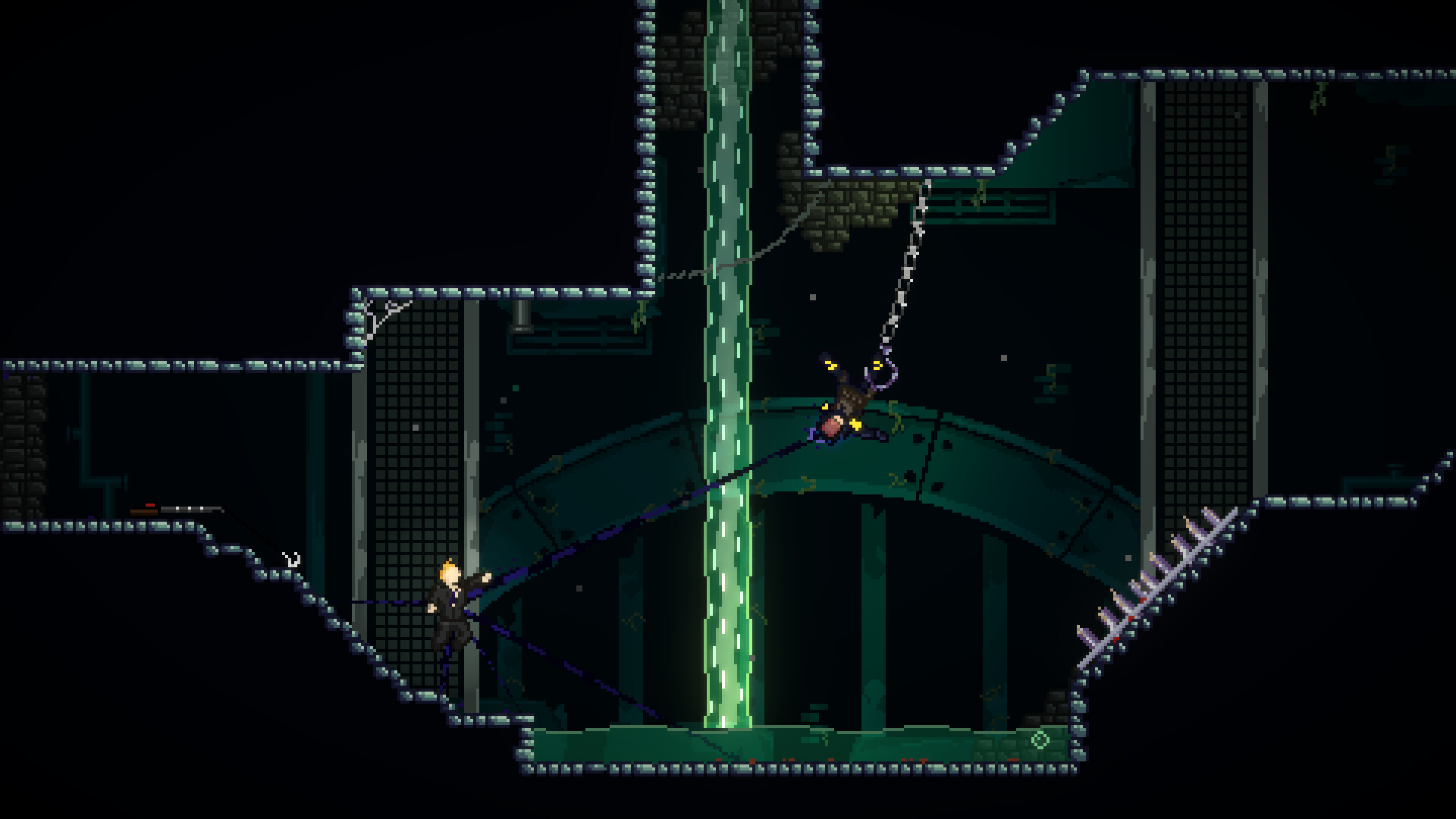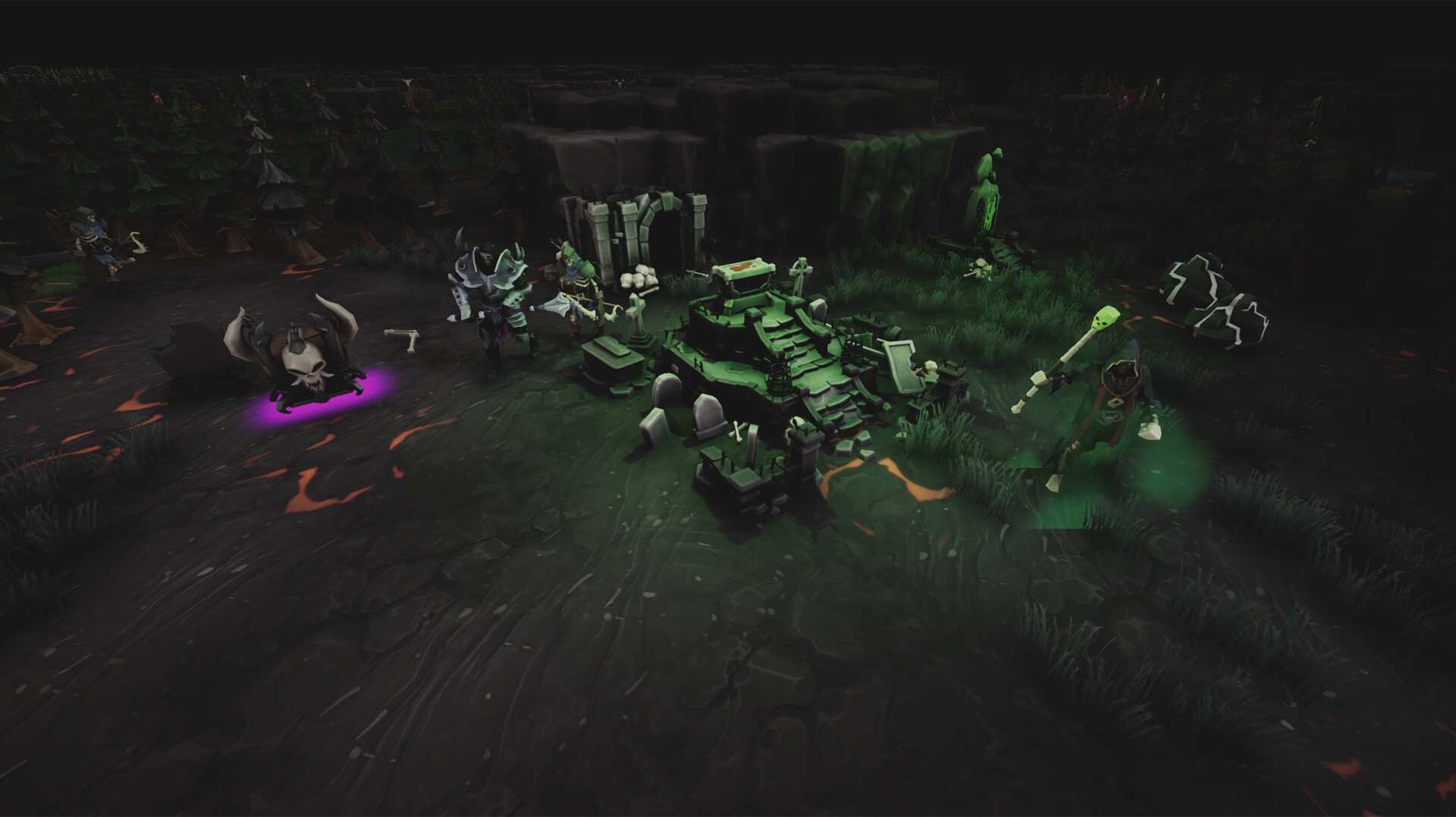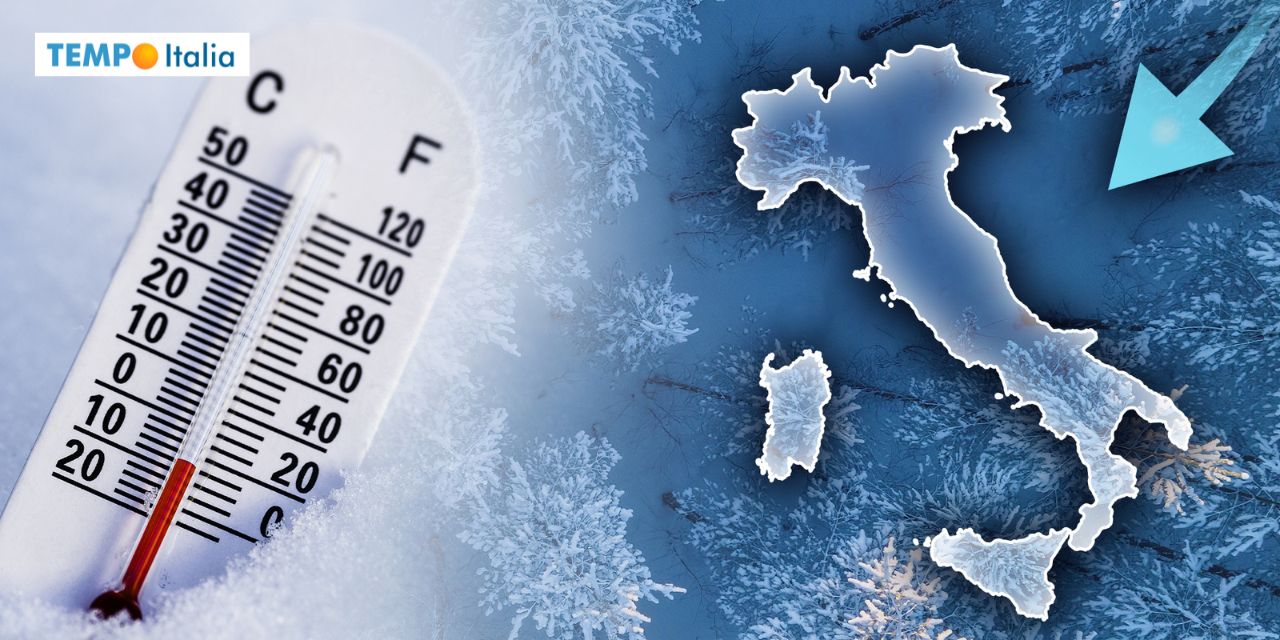Erionite, la fibra 100 volte più tossica dell’amianto: cos’è, dove si trova e perché è pericolosa
È silenziosa, invisibile e letale. Si chiama erionite e potrebbe essere già intorno a noi, nelle rocce vulcaniche che compongono i materiali con cui costruiamo le nostre case e coltiviamo i nostri campi. Da decenni questa fibra minerale è responsabile di un’epidemia devastante di mesotelioma maligno in Cappadocia, in Turchia, e ora anche in Italia...

È silenziosa, invisibile e letale. Si chiama erionite e potrebbe essere già intorno a noi, nelle rocce vulcaniche che compongono i materiali con cui costruiamo le nostre case e coltiviamo i nostri campi.
Da decenni questa fibra minerale è responsabile di un’epidemia devastante di mesotelioma maligno in Cappadocia, in Turchia, e ora anche in Italia è scattato l’allarme. Un recente studio internazionale ha infatti confermato che la sua tossicità può superare di cento volte quella del famigerato amianto, rendendola una minaccia reale e immediata per la salute pubblica.
Dove si trova l’erionite
L’erionite è un minerale appartenente alla famiglia delle zeoliti che si trova naturalmente in numerose formazioni vulcaniche, soprattutto tufi e rocce piroclastiche. La sua presenza è stata documentata in oltre 100 siti distribuiti in almeno 26 Paesi nel mondo, ma le zone più critiche si trovano in Turchia, dove ha causato un’epidemia di mesotelioma maligno, e in Italia, dove affiora in alcune regioni a rischio geologico.
In Italia, le prime segnalazioni risalgono agli anni ’70: l’erionite è stata rinvenuta nei Monti Lessini (Veneto) e in alcune zone della Sardegna, ma studi recenti hanno evidenziato nuove occorrenze in rocce vulcaniche nella provincia di Vicenza. Gli esperti ipotizzano che anche formazioni dei Colli Albani (Lazio) e dei Campi Flegrei (Campania) possano contenere questo minerale fibroso.
In Europa, oltre alla Turchia, sono stati identificati depositi in Germania, Francia, Austria e Repubblica Ceca, ma al momento manca una mappatura geologica sistematica del rischio. La situazione italiana desta particolare attenzione, perché i tufi zeolitici sono tuttora utilizzati in agricoltura, edilizia e altri settori produttivi, con il rischio potenziale di esposizione a fibre cancerogene.
Perché l’erionite è così tossica?
L’erionite è considerata uno dei materiali naturali più pericolosi per la salute umana, tanto da essere classificata come cancerogeno certo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suo potere cancerogeno è stimato fino a 100 volte superiore a quello dell’amianto, per via della sua forma fibrosa, della biopersistenza nei tessuti e della capacità di innescare infiammazioni croniche.
Quando inalata, la fibra viene ingerita dai macrofagi – le cellule immunitarie che tentano di distruggere i corpi estranei – ma a causa della sua forma allungata e sottile, spesso non riesce ad essere eliminata. Questo fenomeno, noto come “frustrazione della fagocitosi”, provoca un’escalation di reazioni biologiche dannose:
- aumento del pH cellulare,
- iperattivazione dei mitocondri,
- sovrapproduzione di radicali liberi (ROS),
- danno ossidativo a DNA, membrane e proteine.
Il ciclo si ripete ogni volta che la fibra viene rilasciata e fagocitata di nuovo, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di mesoteliomi pleurici maligni e altre forme tumorali. È proprio quanto accaduto in Cappadocia, dove l’uso di tufo contenente erionite per costruire le abitazioni ha portato a un’epidemia di tumori con tassi di mortalità mai registrati altrove.
Usi industriali dell’erionite e rischi legati all’esposizione indiretta
A differenza dell’amianto, l’erionite non è mai stata utilizzata intenzionalmente su larga scala. Tuttavia, rappresenta una minaccia silenziosa perché si trova in molte rocce vulcaniche ancora impiegate in vari settori:
- Edilizia: tufi vulcanici e zeoliti naturali vengono usati in cementi, malte, laterizi e prodotti in fibrocemento.
- Agricoltura: le zeoliti sono aggiunte al suolo per migliorarne le proprietà, e impiegate anche nella zootecnia come lettiere assorbenti e additivi nei mangimi.
- Industria chimica: le zeoliti, simili all’erionite, trovano applicazione nella depurazione delle acque, nella catalisi e come agenti essiccanti.
Il problema nasce quando rocce zeolitiche naturali contengono tracce di erionite. Se queste non vengono identificate e controllate, le fibre possono aerodispersersi durante le fasi di estrazione, lavorazione o demolizione, mettendo a rischio lavoratori e cittadini.
Per questo motivo, sono state avviate diverse indagini geologiche e sanitarie per monitorare i siti sospetti e prevenire l’uso di materiali contenenti fibre pericolose. Le normative italiane vietano la commercializzazione di minerali cancerogeni, ma l’erionite non è ancora regolata in modo esplicito come l’amianto, rendendo necessaria una mappatura urgente dei depositi naturali.
Una minaccia sottovalutata
L’erionite rappresenta una minaccia reale e sottovalutata, soprattutto in aree vulcaniche dove affiora naturalmente e può finire nei materiali da costruzione o nei campi agricoli. Studi recenti hanno chiarito i meccanismi cellulari devastanti attraverso cui questo minerale agisce, rendendolo potenzialmente più letale dell’amianto.
La comunità scientifica e le autorità sanitarie stanno lavorando per mappare i siti pericolosi, sostituire i materiali a rischio con alternative sicure e rafforzare la sorveglianza epidemiologica. Ma il primo passo resta l’informazione: conoscere l’erionite è l’unico modo per evitarne l’esposizione e prevenire le gravi conseguenze sulla salute.
Non vuoi perdere le nostre notizie?
- Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram
- Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite
Fonte: ResearchGate – SGB
Ti potrebbe interessare anche:
- Amianto killer: raffineria Kuwait condannata a risarcire la famiglia dell’operaio morto per mesotelioma
- Cos’è il mesotelioma, il cancro causato dall’amianto che ha colpito Franco Di Mare
- Amianto, a oltre 30 anni dalla legge che ne vieta l’uso ancora troppe morti causate dall’esposizione alla fibra killer