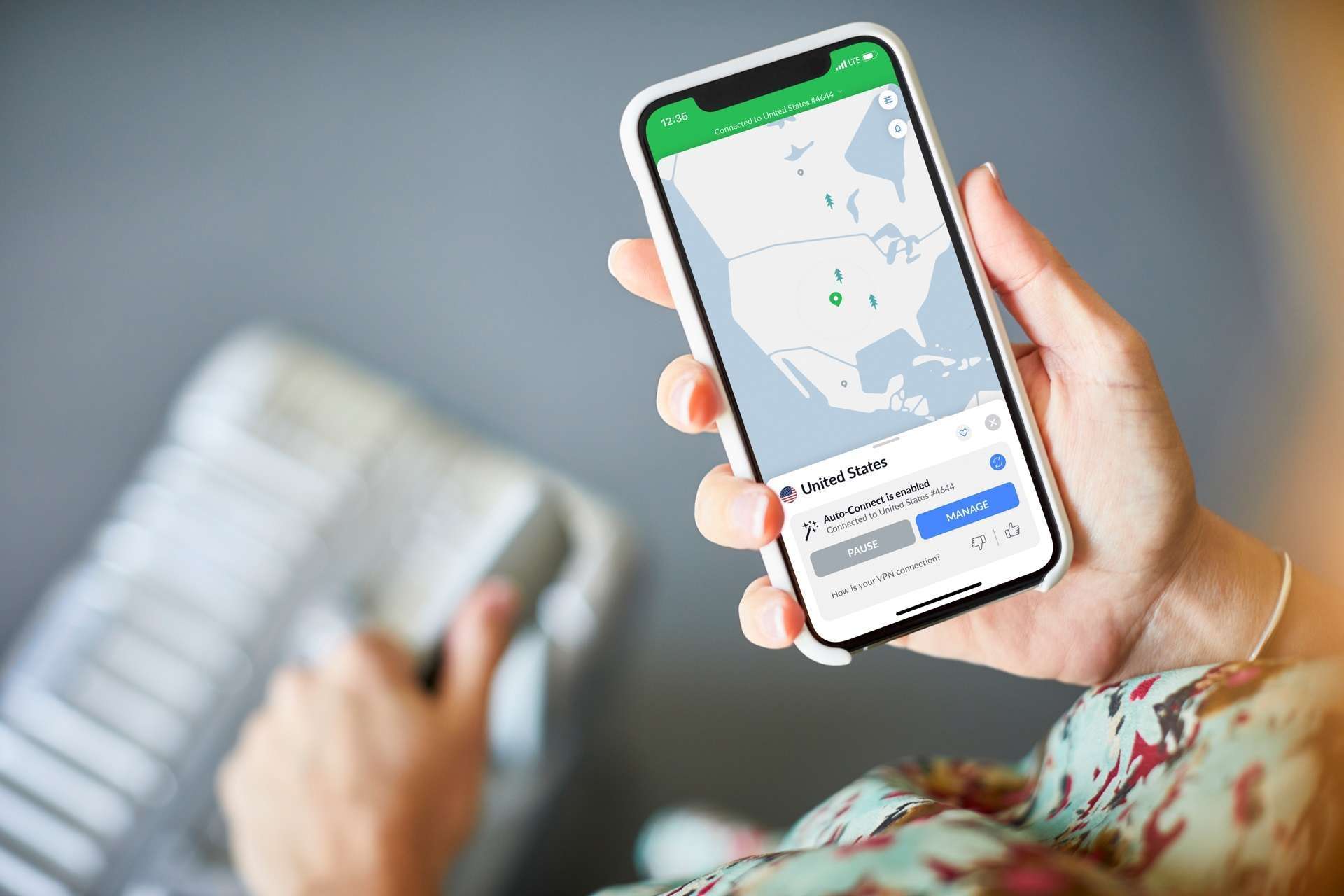Emergenza salari, “l’Italia si è adagiata accettando di competere sui bassi costi del lavoro invece che sulla qualità”
Pubblichiamo un estratto del libro “La questione salariale” di Andrea Garnero, economista del lavoro all’Ocse, e Roberto Mania, giornalista (Egea, 2025) Roberto Mania – È il nuovo mondo, di un altro capitalismo, quello – appunto – delle aziende giganti, come prima non avevamo conosciuto, che escono rafforzate dalla crisi finanziaria e che, nei fatti, prevalgono […] L'articolo Emergenza salari, “l’Italia si è adagiata accettando di competere sui bassi costi del lavoro invece che sulla qualità” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblichiamo un estratto del libro “La questione salariale” di Andrea Garnero, economista del lavoro all’Ocse, e Roberto Mania, giornalista (Egea, 2025)
Roberto Mania – È il nuovo mondo, di un altro capitalismo, quello – appunto – delle aziende giganti, come prima non avevamo conosciuto, che escono rafforzate dalla crisi finanziaria e che, nei fatti, prevalgono sui tentativi degli Stati nazionali di regolarle dentro i binari della concorrenza. Queste imprese, nello stesso tempo, per le loro caratteristiche transnazionali rendono poco agevole l’azione dei sindacati, ai quali in Italia è affidato il compito di definire, negoziandolo con le controparti imprenditoriali, l’entità del salario di categoria.
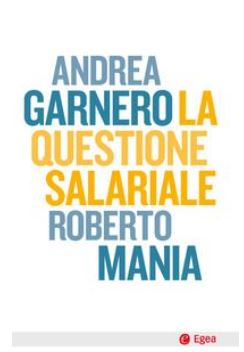 Sulla scena globale il sindacato tende a scomparire, a essere inglobato, ad essere parte minoritaria. La questione salariale va vista, quindi, partendo da questa prospettiva dove predomina un capitalismo vincente, assai più aggressivo che nel passato. E i salari crescono meno di quanto dovrebbero un po’ in tutto il mondo.
Sulla scena globale il sindacato tende a scomparire, a essere inglobato, ad essere parte minoritaria. La questione salariale va vista, quindi, partendo da questa prospettiva dove predomina un capitalismo vincente, assai più aggressivo che nel passato. E i salari crescono meno di quanto dovrebbero un po’ in tutto il mondo.
Resta, tuttavia, l’anomalia italiana. I numeri dell’OCSE ci dicono che dal 1991 al 2023 i redditi da lavoro a parità di potere d’acquisto in Italia sono scesi del 3,4 per cento contro un aumento del 30 per cento e più in altri paesi OCSE. Un divario gigantesco. C’è, insomma, un caso tutto italiano. Ma prima di vederlo più da vicino, penso si debba chiarire cosa ci sia dentro questo indicatore dell’OCSE che ha indubbiamente contribuito, con il ritorno dell’inflazione dopo l’invasione russa dell’Ucraina, a fare scoppiare finalmente in Italia la questione dei salari, perché il gap tra l’Italia e gli altri è davvero clamoroso. È un passaggio che ci aiuta a fare chiarezza in un dibattito spesso confuso, dove i numeri sono piegati agli interessi contingenti di parte, alle semplificazioni e speculazioni ideologiche, e non usati per provare a capire cosa sta accadendo da anni nel nostro mercato del lavoro.
Andrea Garnero – Quell’indicatore dell’OCSE ha avuto tanta attenzione in Italia negli scorsi anni perché in qualche modo quantifica la gravità della questione salariale. Tuttavia, non misura i salari in sé per sé, ma i redditi annuali da lavoro in parità di potere d’acquisto. Potrà sembrare una differenza sottile, ma è importante per interpretare bene quei numeri. I redditi annuali da lavoro includono ovviamente la dimensione dei salari orari, che è ciò che regolano i contratti collettivi o un eventuale salario minimo ma anche le ore di lavoro nella settimana e le settimane di lavoro nell’arco dell’anno. In quell’indicatore, quindi, ci sono anche i redditi di chi lavora part-time e di chi ha un rapporto di lavoro precario. Inoltre, è un indicatore che riflette la composizione del mercato del lavoro e la sua evoluzione nel tempo.
Quei numeri dell’OCSE, allora, non ci dicono che la singola ora lavorata è pagata oggi meno di quanto fosse pagata nel 1991. Il valore della singola ora è aumentato, anche se meno che altrove. Ciò che è cambiato radicalmente è la struttura del mercato del lavoro: dagli anni Novanta in poi sono entrate nel mercato del lavoro nuove persone, nuovi occupati con forme contrattuali diversificate, non necessariamente con il contratto a tempo indeterminato. Sono entrate più donne che purtroppo, lo sappiamo, sono pagate meno degli uomini e persone con contratti part-time o temporanei che non solo non coprono 40 ore a settimana tutte le settimane ma, in media, sono anche pagate meno per ora lavorata. È aumentata la percentuale di lavoratori stranieri.
Questi mutamenti significativi nella struttura del mercato del lavoro, insieme a una crescita salariale in sé debole, spiegano perché l’indicatore OCSE è sceso. In sostanza, la crescita degli occupati e la loro diversificazione ha trascinato giù la media. Questo processo non è accaduto solo in Italia, tutti i paesi europei hanno assistito a un fenomeno simile che è legato in gran parte alla trasformazione della struttura economica con il sorpasso dei servizi sulla manifattura dove il part-time, per fare un esempio, è piuttosto incompatibile con la rigidità della catena di montaggio.
Mutando la struttura dell’economia certe forme contrattuali diventano applicabili e per le imprese diventa conveniente spezzettare il lavoro, esternalizzare parti del processo produttivo. Una volta erano tutti dipendenti della stessa azienda: dall’amministratore delegato all’addetto alle pulizie. Ora non è più così; ora ci sono ambiti interi di attività che vengono appaltati all’esterno, a società terze, con altri contratti di lavoro, spesso con condizioni di lavoro inferiori a quelle originali. Scelte dettate da ragioni di efficienza ma che si traducono in tagli anche dei salari. Non necessariamente del salario orario, ma, per esempio, delle ore di impiego di una persona, sotto l’orario standard giornaliero.
Dietro l’indicatore OCSE ci sono le trasformazioni nell’economia, le nuove regole del lavoro, la fragilità della contrattazione collettiva minacciata sempre più dai contratti cosiddetti «pirata», sottoscritti da sindacati di comodo con il solo scopo di ridurre i trattamenti economici e normativi dei lavoratori, e, infine, i ritardi nei rinnovi contrattuali di categoria.
Dunque, è una questione che va oltre i salari, è una questione del lavoro, della sua variegata, nuova, natura. È avvenuto ovunque, ma in Italia in forma particolarmente acuta e unica nel suo genere. Rispetto agli anni Novanta e prima, avere un lavoro non è più sufficiente per evitare di cadere in povertà. Nel 2023, il 9,9 per cento degli occupati, come dicevi, era povero, una cifra in calo rispetto al picco del 12,2 per cento toccato nel 2017 e 2018, ma pur sempre più elevata della media europea (8,3 per cento). E questo non è un problema solo per i lavoratori di oggi ma anche per i pensionati di domani. Un lavoratore povero sarà con buona probabilità un pensionato povero, ammesso che riesca a cumulare il minimo contributivo necessario per una pensione.
Roberto Mania – Tornando al tema della difficoltà del sistema di evolvere, mi pare che, anziché alzare l’asticella della competizione, una quota non irrilevante delle imprese italiane abbia accettato in quegli anni di competere sui costi finendo per posizionarsi in concorrenza con i produttori cinesi o di altri paesi emergenti, invece di competere sulla qualità con le imprese di altri paesi sviluppati.
Andrea Garnero – Certo, questo è un tema controverso, ma c’è. Il salario non è una variabile indipendente, in un duplice senso. Da una parte, nel senso originale e cioè che non può essere stabilito in maniera indipendente da quella che è la situazione economica di un paese, un settore o un’impresa; ma dall’altra – e questa è un’autocritica al discorso dominante tra gli economisti – non è nemmeno una variabile indipendente rispetto al determinare, a influenzare, gli stessi risultati economici.
Insomma, il fatto che negli scorsi trent’anni l’Italia si sia adagiata, o ampi settori dell’Italia (penso in particolare ai servizi non esposti alla competizione internazionale) si siano adagiati in un equilibrio tra «contrattini» e salari bassi, un po’ pagati rispettando le regole e un po’ pagati fuori busta, ha sicuramente giocato un ruolo nel definire i contorni della nostra economia. I bassi salari che originano dal blocco della crescita sono diventati essi stessi un fattore di bassa crescita e produttività. Puoi abbassare i salari e fare tutti i contrattini che vuoi ma se ti metti a competere con la Cina, o con il Marocco o l’Albania sul terreno dei costi, finisci fuori gara. Sì, certo, ci sono, eccome, imprese italiane che competono su altri e alti livelli ma non pesano sufficientemente nel sistema.
Queste aziende più produttive, di medie e grandi dimensioni, non si trascinano dietro le altre, anche per una questione di posizionamento nella catena globale del valore. Le nostre imprese più produttive, che innovano, che investono, che pagano anche meglio delle altre, non si posizionano necessariamente al picco della catena del valore ma sono o al basso o in mezzo, e non hanno esse stesse una catena. Questo è un fattore importante. È ovvio che non si può chiedere al padroncino di essere ogni giorno al passo con le ultime novità tecnologiche, formative ecc. Anche il migliore dei padroncini ha un limite visto che nell’arco della giornata deve fare tutto, dal produrre, al vendere, al fare pubblicità, al rendicontare, al pensare al futuro. Questo lo possono fare di più le aziende al cui interno i ruoli sono altamente specializzati, in cui c’è l’area ricerca, l’area finanza, l’area marketing… Questi modelli si diffondono nel paese se le imprese produttive e competitive riescono a trascinare il resto. Un ruolo che le grandi imprese del secondo dopoguerra hanno svolto, sia le pubbliche sia le private. La FIAT dei tempi d’oro, per esempio, competendo nel mondo, obbligava a stare al passo anche i propri fornitori.
L'articolo Emergenza salari, “l’Italia si è adagiata accettando di competere sui bassi costi del lavoro invece che sulla qualità” proviene da Il Fatto Quotidiano.