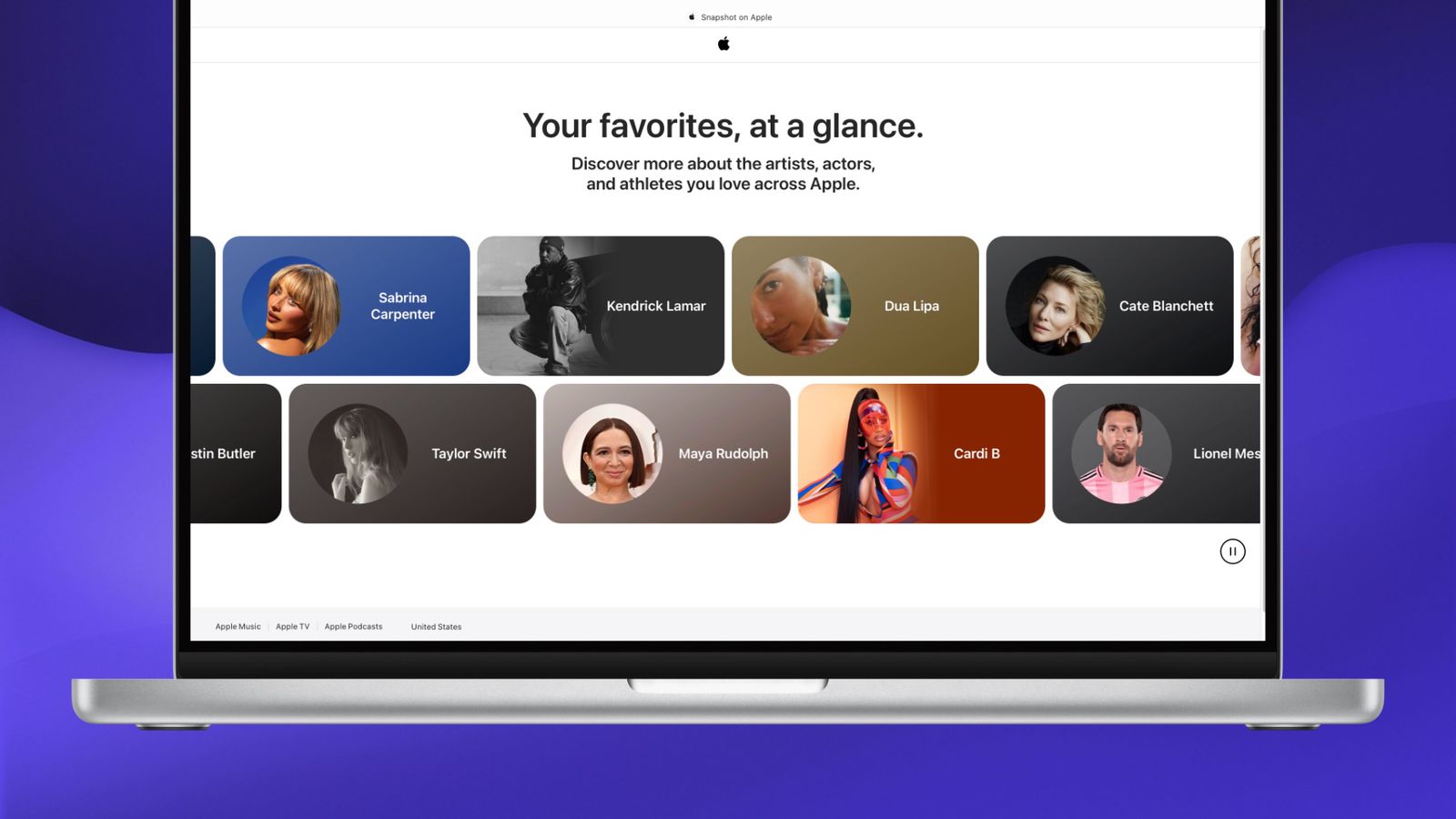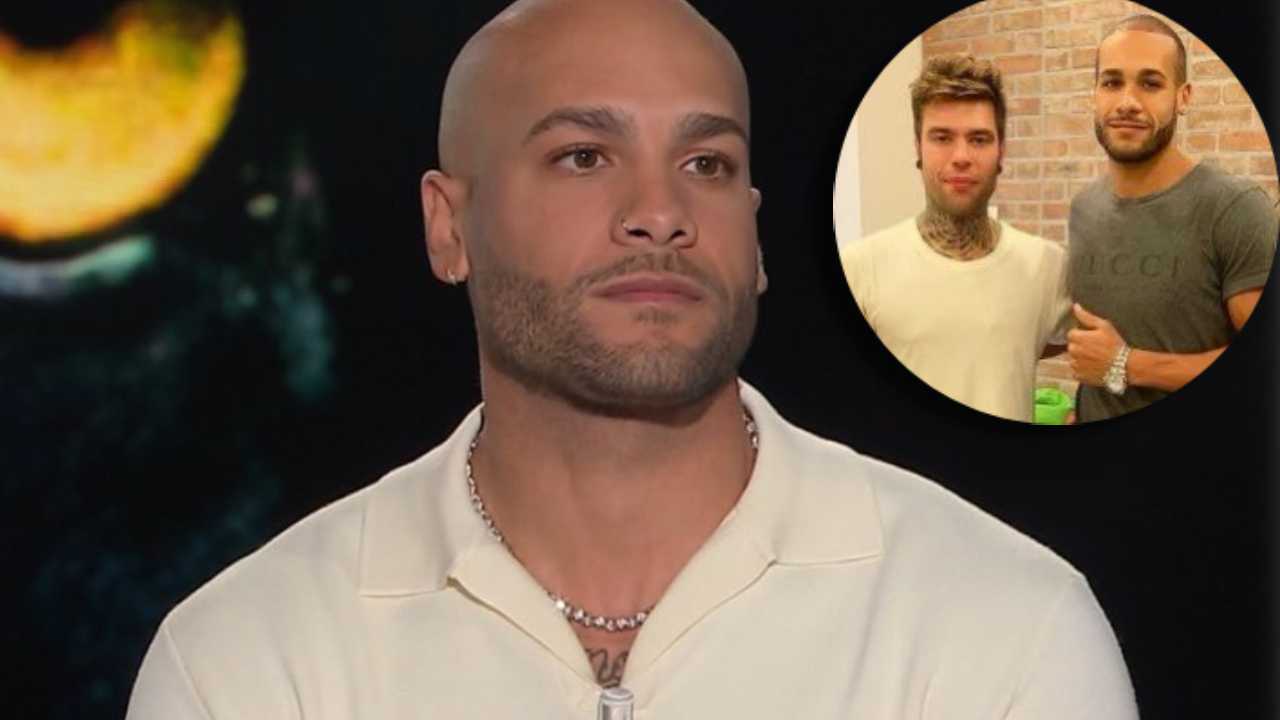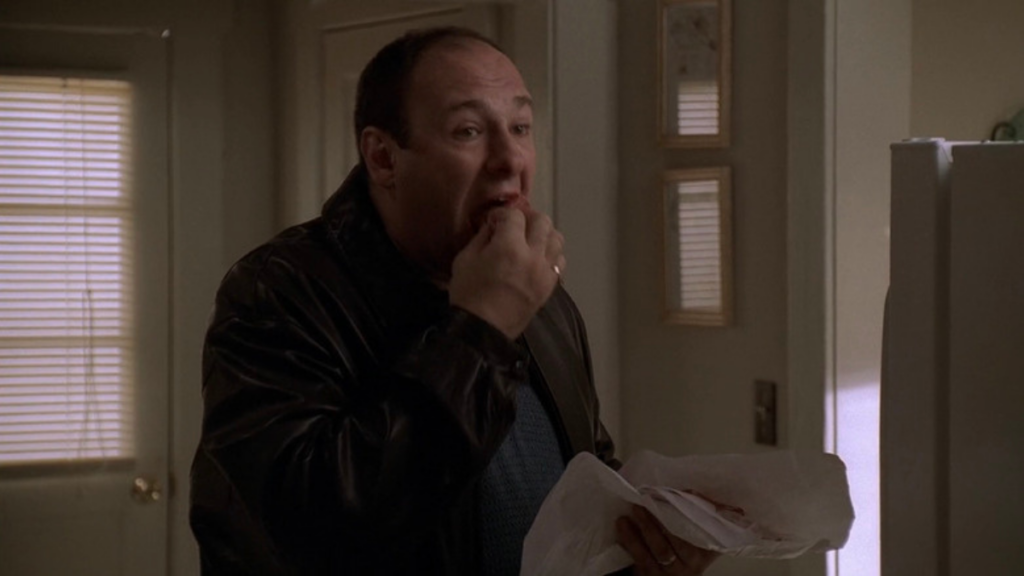Il
passaggio da una fase di La Niña a un evento di El Niño rappresenta uno degli snodi più delicati per l’intero sistema climatico globale. Questo cambiamento, che si origina nel
Pacifico equatoriale, ha ripercussioni significative anche sull’
assetto meteorologico europeo, in particolare sull’area del
bacino del Mediterraneo e sull’
Italia. Comprendere le dinamiche di questa transizione è cruciale per interpretare fenomeni meteo estremi, variazioni stagionali e tendenze a lungo termine. L’analisi si basa su fonti scientifiche accreditate come la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), il
Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) e diverse pubblicazioni su riviste peer-reviewed come
Nature Climate Change e
Geophysical Research Letters.
La Niña e
El Niño sono due fasi opposte del fenomeno noto come
ENSO (El Niño-Southern Oscillation), che influisce fortemente sull’equilibrio termico e sulla circolazione atmosferica del pianeta.
La Niña raffredda le acque superficiali dell’
Oceano Pacifico centro-orientale, mentre
El Niño produce un marcato riscaldamento. Questa variazione termica altera la
circolazione di Walker, con effetti a cascata che si propagano ben oltre i confini del Pacifico. Secondo la
NOAA, il 2024 ha visto concludersi una delle fasi di La Niña più persistenti degli ultimi decenni, durata
tre inverni consecutivi. A partire dalla metà del 2024, le anomalie termiche nel Pacifico hanno indicato una progressiva transizione verso una condizione
El Niño moderata, confermata anche dal
Copernicus Climate Change Service. L’
Europa, pur non trovandosi direttamente nel raggio d’azione dell’ENSO, subisce gli
effetti teleconnessi di questi eventi tramite modifiche alla
circolazione atmosferica planetaria, in particolare al
getto polare e all’
Oscillazione Nord Atlantica (NAO). Quando si passa da La Niña a El Niño, si osservano i seguenti effetti medi su scala europea: Durante
El Niño:
- L’alta pressione delle Azzorre tende a spostarsi verso nord-est.
- Si indebolisce il getto zonale atlantico, con un’ondulazione più accentuata.
- Le perturbazioni atlantiche possono penetrare più frequentemente verso l’Europa meridionale, intensificando fenomeni precipitativi.
- Gli inverni risultano spesso più miti e umidi nella fascia centro-meridionale del continente, inclusa l’Italia.
Uno studio pubblicato su
Climate Dynamics da
Brönnimann et al. (2015) ha evidenziato come gli inverni europei durante El Niño presentino
temperature superiori alla media e un
aumento della piovosità in Europa sudoccidentale, con una relativa siccità nel Nord Europa e in Scandinavia. Il
bacino del Mediterraneo, considerato un
hotspot climatico dalla comunità scientifica, risponde in maniera amplificata ai cambiamenti di ENSO. In condizioni di
El Niño, il
Mediterraneo centro-occidentale sperimenta una
maggiore instabilità atmosferica, con un
aumento delle piogge autunnali e
eventi temporaleschi più intensi, in particolare tra
Settembre e Novembre. Secondo quanto riportato dallo studio di
Mariotti et al. (2002) pubblicato su
Geophysical Research Letters, durante El Niño la circolazione atmosferica nella regione mediterranea favorisce l’afflusso di
aria umida subtropicale, che si scontra con masse d’aria più fredde in arrivo da nord. Questo contrasto intensifica la
genesi ciclonica nel
Mar Tirreno e nel
Mar Ligure, aumentando la frequenza di
alluvioni lampo e fenomeni di
medicane (uragani mediterranei). In Italia, l’effetto di un
El Niño in fase attiva tende a manifestarsi con
inverni più piovosi e miti al Centro-Sud, mentre il
Nord può rimanere parzialmente
protetto da barriere orografiche e anticicloniche. Durante le fasi transitorie verso El Niño, in particolare nei primi mesi di consolidamento del fenomeno, l’
Italia centro-meridionale è spesso sede di un’
attività ciclonica intensa, soprattutto nelle zone di
Sicilia,
Calabria,
Sardegna,
Campania e
Puglia. Le precipitazioni possono risultare
al di sopra della media del periodo, con accumuli anche superiori ai
100 mm in 24 ore, come già osservato durante eventi El Niño passati, ad esempio nel
1997-1998 e nel
2009-2010. Uno studio del
CNR-ISAC (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima) condotto nel 2019 ha confermato che le
anomalie positive delle SST (Sea Surface Temperature) nel Mediterraneo associate a El Niño intensificano l’
evaporazione e la convezione atmosferica, alimentando
temporali autorigeneranti e
fenomeni di flash flood. Man mano che l’evento El Niño progredisce, la stagione primaverile e soprattutto
l’estate vedono un maggiore contributo dell’
anticiclone subtropicale africano, che può estendersi con maggiore frequenza e intensità verso l’
Europa meridionale, determinando
ondate di calore estreme con temperature che possono superare facilmente i
40°C nelle
aree interne della Sardegna, della
Puglia e della
Basilicata. Questa configurazione è ben documentata anche nei report del
Copernicus Climate Bulletin, che ha rilevato negli anni caratterizzati da El Niño un’anomalia termica positiva media tra
+1,5°C e +2,5°C sulle regioni meridionali italiane nei mesi estivi. L’influenza del passaggio da La Niña a El Niño si riflette anche nei
regimi eolici e nella
stabilità dell’aria. Il
vento di scirocco, caldo e umido, tende a presentarsi con maggiore frequenza lungo il versante adriatico e sul basso Tirreno, mentre il
maestrale è meno dominante a causa del rallentamento del flusso atlantico. Nel complesso, l’atmosfera risulta
più instabile, con un maggiore
indice CAPE (Convective Available Potential Energy), che misura il potenziale convettivo. Valori di CAPE superiori ai
1000 J/kg, più comuni durante i periodi El Niño, sono un indicatore di una maggiore propensione allo sviluppo di
supercelle temporalesche, con rischio di
grandinate e
downburst. Le implicazioni non si limitano al breve termine. Il cambiamento del regime meteo causato da El Niño può avere
ripercussioni a lungo termine sulla disponibilità idrica e sulla produttività agricola. Le coltivazioni tipiche del
Mezzogiorno, come
olivo,
vite,
agrumi e
ortaggi, risentono della
variabilità idrica: abbondanza di piogge in inverno seguita da siccità e calore estivo può causare
stress idrico e fitopatologie. Il
CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria) ha più volte sottolineato come eventi ENSO possano compromettere la
stabilità del raccolto, modificando anche i calendari di semina e raccolta. Monitorare con precisione la
transizione da La Niña a El Niño è fondamentale per mettere in atto strategie di
mitigazione del rischio meteo. In Italia, l’integrazione dei dati provenienti da
Copernicus,
NOAA e le previsioni stagionali di
ECMWF permette una sempre maggiore accuratezza nella previsione di scenari meteo a medio e lungo termine. L’impiego combinato di
modelli dinamici e
modelli statistici consente di anticipare le tendenze meteo stagionali con mesi di anticipo, fornendo indicazioni cruciali per la
protezione civile, la
gestione delle risorse idriche, la
pianificazione agricola e il
settore energetico.
El Niño in Europa, meteo subito sconvolto in Italia

 Il passaggio da una fase di La Niña a un evento di El Niño rappresenta uno degli snodi più delicati per l’intero sistema climatico globale. Questo cambiamento, che si origina nel Pacifico equatoriale, ha ripercussioni significative anche sull’assetto meteorologico europeo, in particolare sull’area del bacino del Mediterraneo e sull’Italia. Comprendere le dinamiche di questa transizione è cruciale per interpretare fenomeni meteo estremi, variazioni stagionali e tendenze a lungo termine. L’analisi si basa su fonti scientifiche accreditate come la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) e diverse pubblicazioni su riviste peer-reviewed come Nature Climate Change e Geophysical Research Letters. La Niña e El Niño sono due fasi opposte del fenomeno noto come ENSO (El Niño-Southern Oscillation), che influisce fortemente sull’equilibrio termico e sulla circolazione atmosferica del pianeta. La Niña raffredda le acque superficiali dell’Oceano Pacifico centro-orientale, mentre El Niño produce un marcato riscaldamento. Questa variazione termica altera la circolazione di Walker, con effetti a cascata che si propagano ben oltre i confini del Pacifico. Secondo la NOAA, il 2024 ha visto concludersi una delle fasi di La Niña più persistenti degli ultimi decenni, durata tre inverni consecutivi. A partire dalla metà del 2024, le anomalie termiche nel Pacifico hanno indicato una progressiva transizione verso una condizione El Niño moderata, confermata anche dal Copernicus Climate Change Service. L’Europa, pur non trovandosi direttamente nel raggio d’azione dell’ENSO, subisce gli effetti teleconnessi di questi eventi tramite modifiche alla circolazione atmosferica planetaria, in particolare al getto polare e all’Oscillazione Nord Atlantica (NAO). Quando si passa da La Niña a El Niño, si osservano i seguenti effetti medi su scala europea: Durante El Niño:
Il passaggio da una fase di La Niña a un evento di El Niño rappresenta uno degli snodi più delicati per l’intero sistema climatico globale. Questo cambiamento, che si origina nel Pacifico equatoriale, ha ripercussioni significative anche sull’assetto meteorologico europeo, in particolare sull’area del bacino del Mediterraneo e sull’Italia. Comprendere le dinamiche di questa transizione è cruciale per interpretare fenomeni meteo estremi, variazioni stagionali e tendenze a lungo termine. L’analisi si basa su fonti scientifiche accreditate come la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) e diverse pubblicazioni su riviste peer-reviewed come Nature Climate Change e Geophysical Research Letters. La Niña e El Niño sono due fasi opposte del fenomeno noto come ENSO (El Niño-Southern Oscillation), che influisce fortemente sull’equilibrio termico e sulla circolazione atmosferica del pianeta. La Niña raffredda le acque superficiali dell’Oceano Pacifico centro-orientale, mentre El Niño produce un marcato riscaldamento. Questa variazione termica altera la circolazione di Walker, con effetti a cascata che si propagano ben oltre i confini del Pacifico. Secondo la NOAA, il 2024 ha visto concludersi una delle fasi di La Niña più persistenti degli ultimi decenni, durata tre inverni consecutivi. A partire dalla metà del 2024, le anomalie termiche nel Pacifico hanno indicato una progressiva transizione verso una condizione El Niño moderata, confermata anche dal Copernicus Climate Change Service. L’Europa, pur non trovandosi direttamente nel raggio d’azione dell’ENSO, subisce gli effetti teleconnessi di questi eventi tramite modifiche alla circolazione atmosferica planetaria, in particolare al getto polare e all’Oscillazione Nord Atlantica (NAO). Quando si passa da La Niña a El Niño, si osservano i seguenti effetti medi su scala europea: Durante El Niño: