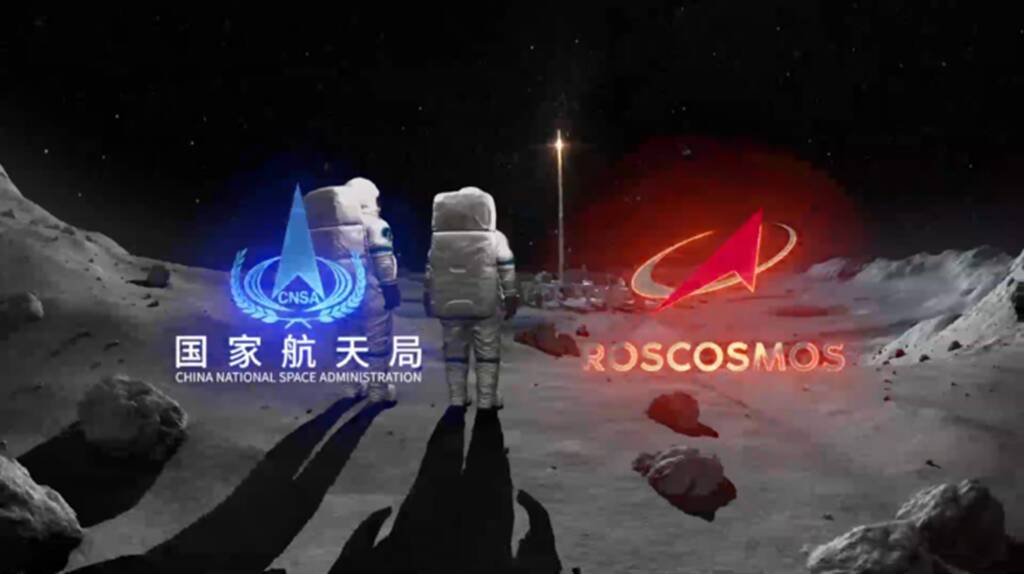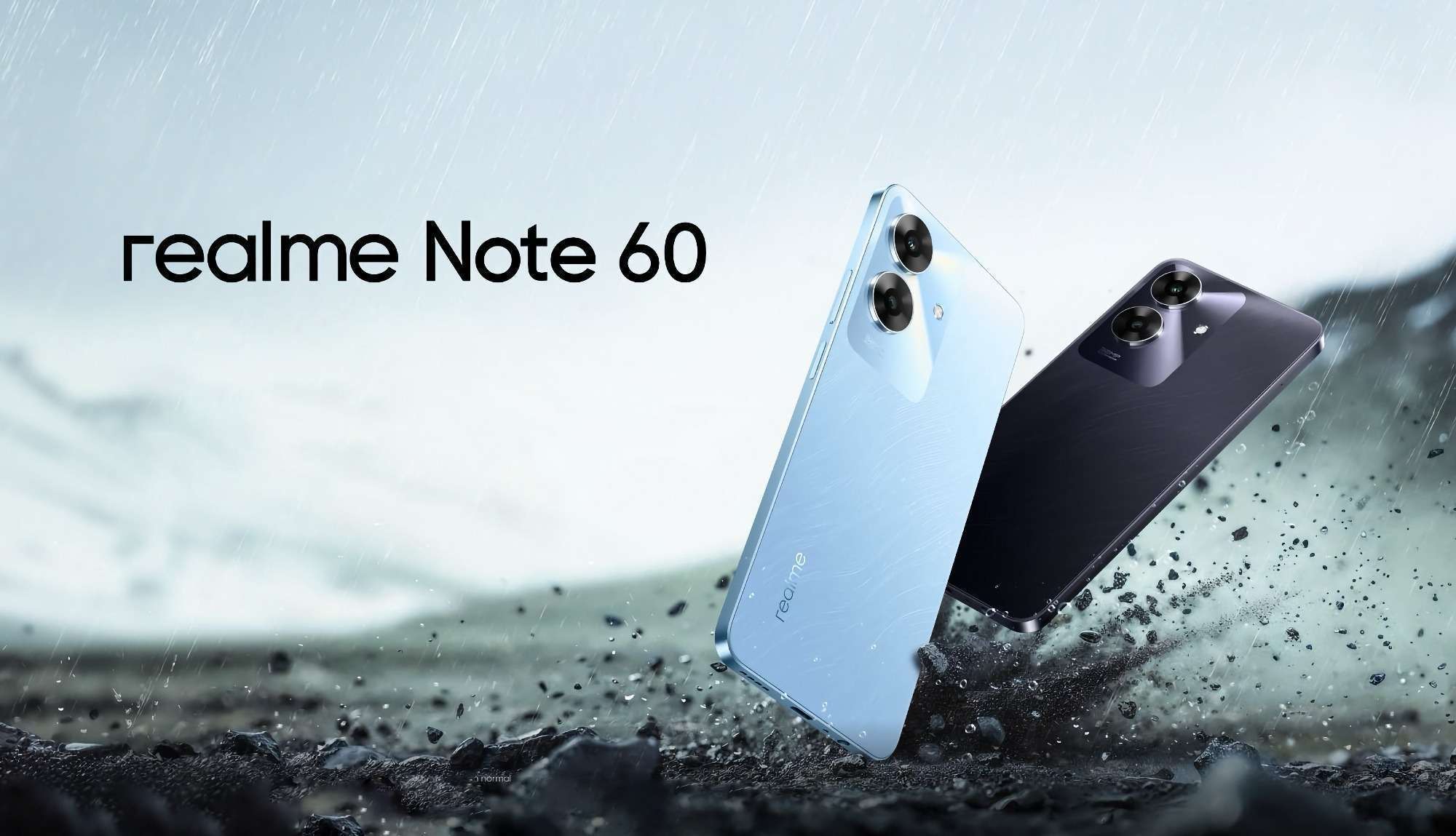Tasse e regole su finanza e digitale: per rispondere a Trump bisogna ribaltare il liberismo di Maastricht
Rispondere ai dazi sulle merci imposti dal presidente americano Donald Trump è indispensabile ma non è sufficiente: per fare male all’America e ottenere un vero potere negoziale con Trump occorrerà […]

Rispondere ai dazi sulle merci imposti dal presidente americano Donald Trump è indispensabile ma non è sufficiente: per fare male all’America e ottenere un vero potere negoziale con Trump occorrerà tassare i servizi finanziari e digitali americani in Europa e regolamentare i movimenti di capitale da e verso l’America. La questione è semplice: l’Europa esporta molto rispetto al suo PIL mentre gli Stati Uniti d’America importano poche merci europee rispetto al PIL. Quindi i dazi commerciali applicati dall’Europa per gli USA contano relativamente poco: per fare del male al portafoglio dell’America occorre invece che i paesi europei e l’Unione Europea tassino il forte surplus americano nel settore dei servizi. Inoltre per rispondere alle politiche protezionistiche americane occorrerà che i governi europei abbandonino nel più breve tempo possibile il liberismo di mercato sancito a Maastricht. Questa UE liberista non è infatti in grado di essere competitiva in un mondo in cui dominano i criteri geopolitici di potenza rispetto a quelli puramente commerciali.
Le politiche ultraprotezionistiche avviate da Trump impongono il rapido superamento della logica europea basata sul libero commercio e sul libero mercato. Le questioni commerciali e finanziarie sono ormai diventate soprattutto scelte geopolitiche. I governi nazionali e la UE dovrebbero cominciare a pianificare delle serie strategie di autosufficienza sia in campo industriale che monetario e finanziario per difendersi dalle politiche americane e isolarsi dalle future prevedibili gravi crisi finanziarie generate a Wall Street. In questo contesto anche in Europa la politica dovrebbe tornare a governare i mercati.
L’amministrazione Trump, grazie al protezionismo spinto e alle sue manovre tariffarie shock, punta a spingere le industrie estere a produrre direttamente in America per non pagare i nuovi pesanti dazi alla frontiera americana. Trump vuole attirare nuovi investimenti produttivi negli USA, reindustrializzare l’America e così chiudere, o almeno ridurre, nel medio e lungo periodo il pesante deficit commerciale americano. L’economia americana ha infatti dei piedi di argilla. Gli USA sono il più grande debitore del mondo, con un debito pubblico pari a oltre 36 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari, pari al 122% del PIL. A causa del doppio deficit, commerciale e di bilancio pubblico, gli USA sarebbero già falliti se non fosse che il dollaro è la moneta dominante e che è richiesto a livello mondiale come valuta di riserva, per il commercio tra le nazioni e per le speculazioni finanziarie. Solo il privilegio esorbitante del dollaro tiene a galla l’America ultraindebitata: infatti i titoli di debito americani sono molto richiesti perché valgono come i dollari e in più generano interessi. Il dollaro è dunque molto richiesto e per questo motivo è sopravvalutato: questo fa bene a Wall Street e alle grandi società finanziarie che possono comprare merci e industrie estere con una moneta che vale più del suo potere d’acquisto reale. Ma la sopravvalutazione del dollaro fa male all’industria USA perché le merci americane costano più di quelle dei competitor nei mercati internazionali. Il dollaro forte ha prodotto il dominio finanziario degli USA e però anche la deindustrializzazione dell’America. Trump, con la sua pazza e caotica politica, vorrebbe rovesciare questo trend (anche se paradossalmente il caos che crea mette in grande pericolo la stabilità e la forza della valuta mondiale).
Di fronte a questa strategia velleitaria e imperiale, l’Unione Europea tentenna e è divisa: gli amici del fascistoide Trump, come Giorgia Meloni, vorrebbero piegare la schiena e subordinarsi all’alleato americano. Altri vorrebbero invece reagire al bullismo ingiustificato dell’amministrazione americana. Tuttavia la UE dovrebbe avere il coraggio di rispondere non tanto imponendo dazi alle merci americane ma penalizzando il settore dove l’America è più forte e da dove trae i maggiori guadagni, quello dei servizi digitali e della finanza. La UE dovrebbe innanzitutto stringere i controlli sui movimenti di capitale e sul mercato finanziario. Il presidente francese Emmanuel Macron ha per esempio già avvertito che le grandi industrie europee dovrebbero frenare i loro investimenti negli USA. Ma non basta: occorre colpire il surplus americano nel settore dei servizi. Rispetto agli USA la bilancia commerciale della zona euro segna infatti una forte eccedenza negli scambi commerciali di merci, pari nel 2024 a 213 miliardi di euro (quasi il 68% in più rispetto ai 127 miliardi del 2015). Ma l’eurozona presenta un disavanzo sugli scambi di servizi: in questo caso sono gli Usa in surplus, per ben 156 miliardi. E anche sui trasferimenti di reddito gli Usa sono in forte avanzo, per 52 miliardi: il surplus americano è dunque pari a 208 miliardi di euro. Alla fine, considerando altre poste minori, nel 2024 il surplus complessivo dell’eurozona sugli Usa nelle partite correnti è pari a solo 3 miliardi di euro, dopo che nel 2023 questa voce era invece risultata in deficit per 30 miliardi. Nel 2023 erano gli Usa ad essere in surplus. La bilancia delle partite correnti tra eurozona e USA, che comprende merci e servizi, è quindi in generale abbastanza equilibrata.
Se si vogliono colpire davvero gli Stati Uniti occorre dunque tassare i servizi, come per esempio i servizi digitali delle piattaforme oligopoliste americane, da Amazon a Apple, da Netlix a Google; e poi tassare le royalties sui brevetti americani e i profitti realizzati in Europea e trasferiti in America, in particolare quelli relativi ai servizi bancari e alla speculazione finanziaria. Bisognerebbe però che in Europa non ci fossero paradisi fiscali come l’Irlanda, il Lussemburgo, l’Olanda, Malta e Cipro, e che l’Europa fosse unita di fronte al non più alleato americano. Bisognerebbe anche che Bruxelles decidesse di vincolare, almeno per via fiscale se non per via amministrativa, il flusso di investimenti, pari a circa 300 miliardi all’anno, che dall’Europa parte per essere impiegato nelle borse valori statunitensi e nel mercato dei titoli del Tesoro americano. Bisognerebbe fare pagare tasse elevate sugli investimenti finanziari e produttivi delle società europee in America.
Inoltre bisognerebbe che la UE mettesse un limite alla possibilità, attualmente pressoché illimitata, delle grandi finanziarie americane, come JP Morgan, Blackrock, Vanguard, State Street, di acquisire pacchetti di controllo, o comunque quote azionarie significative, nelle imprese strategiche europee – come le banche, le società di energia, telecomunicazioni, della difesa, le imprese hi-tech -. Le grandi società finanziarie americane gestiscono infatti fondi per migliaia di miliardi di dollari e detengono pacchetti di controllo o di quasi controllo delle maggiori imprese europee. Gli Stati europei dovrebbero usare la Golden Share per imporre un limite alle quote azionarie delle grandi finanziarie americane nelle loro imprese strategiche, così come fanno già nei confronti degli investitori cinesi. Limiti agli operatori americani andrebbero posti anche per la partecipazione alle aste pubbliche europee. Solamente con politiche protezionistiche a livello finanziario l’Europa potrebbe giocare carte valide nella trattativa con l’amministrazione Trump. Altrimenti la partita è persa in partenza e l’Europa (Italia compresa) diventerà sempre più deindustrializzata, piena di debiti, divisa e subordinata alla potenza americana.
Più in prospettiva, per rispondere alle strategie di Trump e al conflitto geopolitico con la Russia di Putin, occorrerebbe che Bruxelles fosse in grado di superare il liberismo e di realizzare quella che gli economisti chiamano, forse impropriamente, una “economia di guerra”. Un’economia fortemente programmata per realizzare obiettivi strategici è infatti indispensabile non solo per rispondere alla competizione globale e, nel campo della difesa, per prevenire possibili aggressioni, ma anche e soprattutto per realizzare politiche ecologiche, di lotta alle conseguenze del cambiamento climatico. Una seria politica industriale è inoltre essenziale per avviare, auspicabilmente, credibili politiche di distensione e di pace che finora Bruxelles non ha mai colpevolmente iniziato nel caso della guerra in Ucraina.
Un fatto è certo: nel nuovo contesto multipolare e di scontro tra le grandi potenze gli Stati sono destinati a assumere un ruolo sempre più rilevante e diretto nell’economia e nei rapporti internazionali: sovranità nazionale e autosufficienza tornano a essere più importanti dei “vantaggi comparati” legati al libero commercio internazionale. Nel clima di nazionalismo montante l’economia di mercato tende a trasformarsi nel suo opposto, l’economia di guerra. Prevale la logica dell’autonomia strategica per quanto riguarda le risorse energetiche, le materie prime, le tecnologie avanzate – microchip, intelligenza artificiale, computer quantistici, 5G, cybersicurezza, digital money, data management, biotecnologie, ecc) –. Il problema è che USA, Cina, Russia sono in buona parte autosufficienti sia a livello di materie prime e agricole sia sul piano tecnologico e militare: ma la UE e i singoli paesi europei (forse con la parziale eccezione francese) assolutamente no. La UE di Maastricht è del tutto impreparata a raccogliere la sfida.
Nel quadro di un’economia di guerra i governi dell’Unione Europea dovrebbero idealmente cooperare – come in parte suggerisce anche il rapporto sulla competitività di Mario Draghi – per il controllo delle importazioni e delle esportazioni, la pianificazione delle produzioni industriali strategiche, il controllo dei prezzi dei generi e dei servizi di base (come l’elettricità e il gas). La UE dovrebbe attuare una politica di pieno impiego per sfruttare tutte le risorse disponibili; e gli Stati della UE dovrebbero condividere costi e profitti di queste iniziative, senza che nessuno perda o, al contrario, guadagni profitti indebiti sulle spalle di altri. Un compito titanico e quasi impossibile per 27 paesi diversi con 27 economie concorrenti tra loro!
Il nuovo contesto globale richiede che le attività produttive non siano più considerate solo in vista del potenziale profitto ma soprattutto sotto il profilo dell’importanza strategica, anche se fossero in perdita. Il profitto non è più l’obiettivo esclusivo dell’attività economica. In un’economia di guerra, in una economia programmata, lo Stato deve pianificare la produzione in vista di obiettivi predeterminati: il profitto viene dopo, se c’è. Lo Stato, con i suoi organi specializzati nella gestione delle risorse strategiche acquista un ruolo centrale nell’economia, sia come pianificatore sia, talvolta, come produttore diretto. In generale solo lo Stato ha la capacità di vedere lontano e di sostenere anche finanziariamente strategie economiche di lunga scadenza: i mercati infatti chiedono rendimenti a breve termine.
Gli Stati centralizzati e autoritari, come quello russo e cinese, e come gli Stati fascisti o comunisti tendenzialmente autarchici, come per esempio il Nord Corea, sono in generale assai più pronti a realizzare un’economia di guerra, proprio perché non permettono all’economia di essere gestita solo in base alla logica del profitto privato e perché ragionano in base a obiettivi strategici di lungo periodo. La Russia nel giro di due anni ha saputo trasformare la sua economia in una economia di guerra, con piena occupazione o quasi. La Cina ha saputo programmare da almeno venti anni la sua supremazia nel campo della mobilità elettrica e delle tecnologie energetiche alternative ai fossili. Gli Stati centralizzati e con potere politico forte possono essere in grado di indirizzare e riconvertire rapidamente le produzioni per ottenere i loro obiettivi prioritari.
Bisognerebbe dunque che la UE coordinasse le politiche industriali e protezionistiche a livello europeo e che gli Stati europei intervenissero pesantemente nell’economia, fino anche a nazionalizzare e a controllare direttamente i comparti strategici per lo sviluppo economico, come per esempio l’energia. In Italia per esempio lo Stato dovrebbe detenere la quota di maggioranza dell’ENI per garantire alle imprese e ai cittadini energia sicura e a prezzi calmierati.
La gestione della moneta e del credito assumerà un’importanza assolutamente centrale nel nuovo contesto: in una economia di mercato il sistema bancario opera in maniera decentrata e anarchica, solo in base ai criteri di profitto e di valorizzazione del capitale per gli azionisti (che spesso sono esteri). In un sistema di economia di guerra il credito viene invece amministrato centralmente e gestito in base agli obiettivi programmati. Considerando che la UE non ha risorse sufficienti per finanziare lo sviluppo, le nuove tecnologie rinnovabili e la difesa, solo la Banca Centrale Europea può finanziare i debiti della UE e degli Stati. I governi europei dovrebbero dunque decidere di limitare la completa indipendenza della BCE affinché questa sia chiamata a coprire la riorganizzazione delle attività industriali e statali, le ingenti spese per la lotta ai cambiamenti climatici e l’industria della difesa. La BCE dovrebbe garantire i debiti pubblici della UE e dei paesi europei, e “monetizzare il debito”, cioè emettere moneta per finanziare il debito che il mercato eventualmente non è disposto a accollarsi. Ma l’indipendenza della BCE e la proibizione della monetizzazione dei debiti sono in Europa più sacre delle Tavole di Mosè.
Direzione pubblica del credito, aumento della spesa e del debito pubblico, monetizzazione dei debiti, bassi tassi di interesse, inflazione e piena occupazione, fanno a pugni con le politiche di austerità che la UE conduce da sempre. Il nuovo contesto dovrebbe allora comportare il rovesciamento della logica che sottende il Trattato di Maastricht: la UE infatti attualmente affida il credito esclusivamente al settore privato e ai mercati finanziari deregolamentati. L’Unione inoltre non ha una politica fiscale comune ma impone solo vincoli assurdi e controproducenti sulla spesa e sul debito pubblico. La UE non ha neppure una politica efficace e unitaria di regolamentazione del settore finanziario. Per tutti questi motivi è del tutto incapace a prepararsi alla nuova competizione nel mondo delle grandi potenze.
L’Unione Europea nata sui principi più estremi del liberismo rischia di rimanere l’unica area economica a praticare ancora le dottrine reaganiane di “affamare la bestia dello Stato”. I sacri principi di Maastricht relativi alla prevalenza dei mercati sulla politica, all’estromissione dello Stato dalle attività economiche, alla competizione come unico criterio di politica economica, al pareggio di bilancio pubblico, alla rinuncia di ogni forma di cooperazione fiscale, rovinano l’economia continentale e costringono la UE alla dipendenza rispetto al resto del mondo.
In conclusione, la UE è molto debole di fronte ai competitor perché non è in grado di coordinare e centralizzare una politica industriale, è strutturalmente troppo divisa e non dispone delle risorse fiscali indispensabili per competere. Non a caso ogni Stato sta cercando di fare da sé o di formare delle alleanze con chi ci sta, come è il caso delle “unioni dei volenterosi” in campo militare.
L’Unione Europea è dunque di fronte a un bivio: o supererà le regole di Maastricht o rischia, come ha profetizzato Draghi, l’agonia e la disintegrazione. Nel nuovo contesto geopolitico le piccole modifiche e i piccoli passi suggeriti da Ursula von der Leyen sono del tutto insufficienti. Come curare un malato in coma con una minestra riscaldata. Ancora più sbagliato è spingere l’Europa a riarmarsi a debito. Alla fine o si supererà Maastricht e si respingerà una politica assurdamente bellicista, o l’Europa è destinata a diventare un insieme disgregato di colonie.