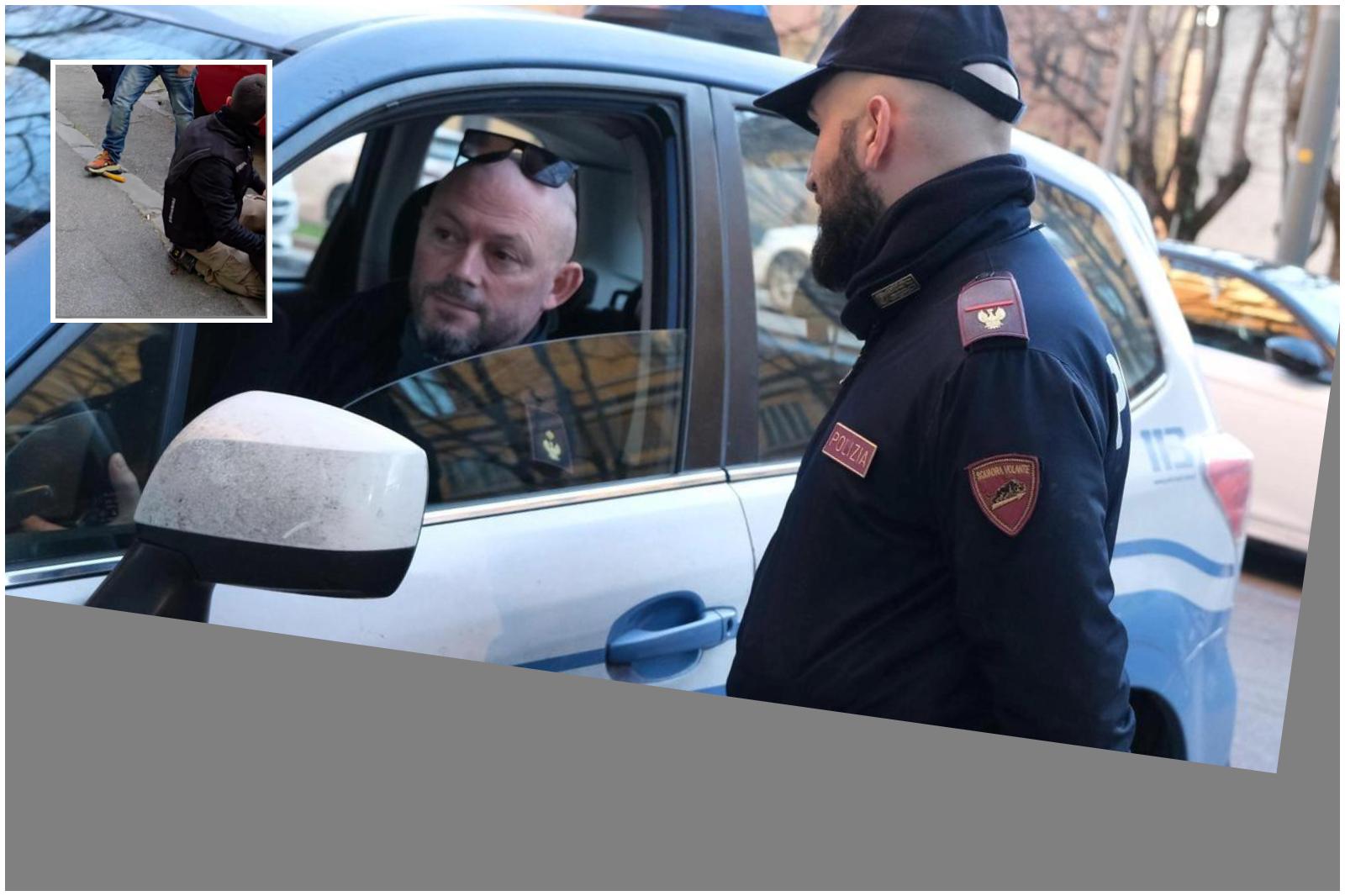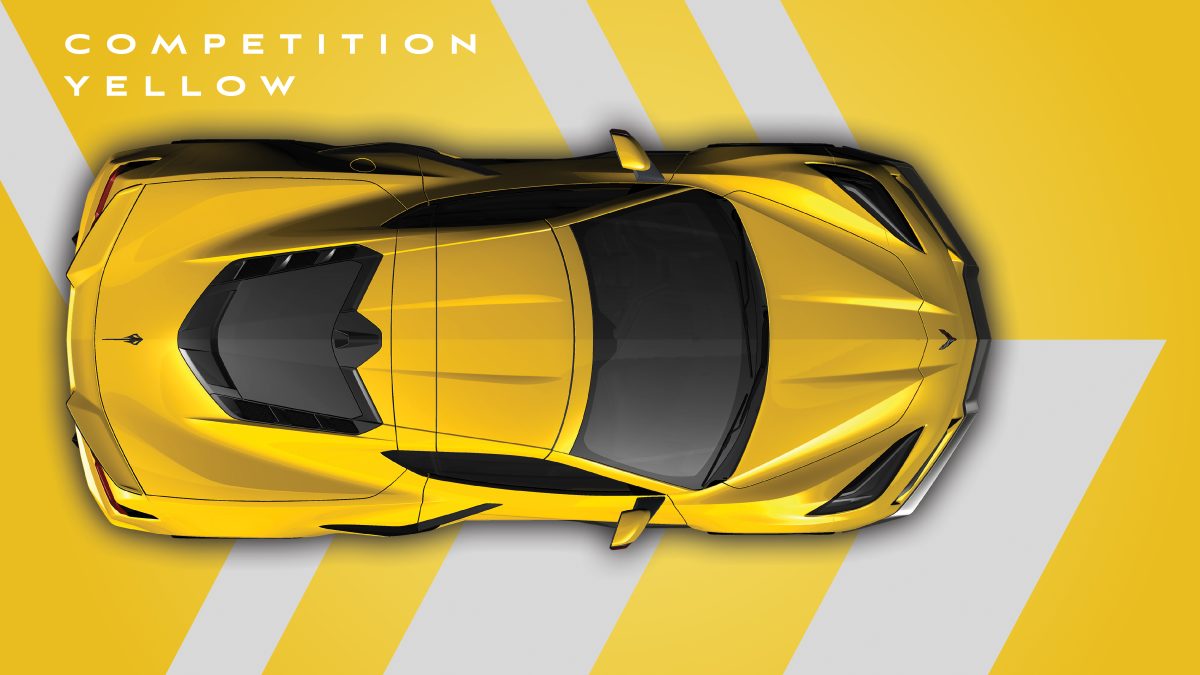Tassa Ue sulla CO2 alla frontiera. Come la vuole modificare l’Italia?
Dopo due anni di sperimentazione, iniziata nell’ottobre 2023 e destinata a concludersi nel dicembre 2025, dal 2026 entrerà in funzione in maniera definitiva nell’Ue (e dal 2027 nel Regno Unito) la prima carbon border tax al mondo. Imporrà dazi alle aziende che importano beni ad alta intensità emissiva, come elettricità, idrogeno, acciaio, alluminio e cemento. […] The post Tassa Ue sulla CO2 alla frontiera. Come la vuole modificare l’Italia? first appeared on QualEnergia.it.

Dopo due anni di sperimentazione, iniziata nell’ottobre 2023 e destinata a concludersi nel dicembre 2025, dal 2026 entrerà in funzione in maniera definitiva nell’Ue (e dal 2027 nel Regno Unito) la prima carbon border tax al mondo.
Imporrà dazi alle aziende che importano beni ad alta intensità emissiva, come elettricità, idrogeno, acciaio, alluminio e cemento.
Lo scopo principale del Cbam (“Carbon border adjustment mechanism”) è evitare che le imprese europee delocalizzino le attività industriali in Paesi dove sono in vigore norme ambientali meno severe.
Secondo alcuni governi europei questo meccanismo potrebbe però minare la competitività nel Vecchio Continente. Per questo motivo Italia, Francia e Slovacchia hanno presentato ieri, 27 marzo, al Consiglio Ambiente Ue un “non-paper” (link in basso) in cui chiedono una serie di modifiche urgenti al regolamento.
Presente a Bruxelles per l’Italia la viceministra al Mase, Vannia Gava, che a margine dell’evento ha incontrato i commissari europei per l’Energia, Dan Jorgensen, l’Ambiente e la Resilienza idrica, Jessika Roswall, e il Mediterraneo, Dubravka Suica.
Revisioni anticipate e oneri amministrativi
In generale i tre firmatari si augurano che venga effettuata una valutazione dell’impatto del provvedimento sulla competitività dell’industria europea alla fine del periodo di transizione, anticipandola rispetto al 2028, anno in cui è attualmente prevista. In questo modo Bruxelles avrebbe tempo per porre eventuali correttivi.
“Per la prima volta – sottolinea una nota del Mase – un ampio numero di Stati membri ha sostenuto la necessità che la Commissione svolga una vera analisi sul funzionamento dello strumento prima della piena entrata in vigore, anziché a posteriori, e di non escludere nessuno strumento di difesa competitiva”.
Italia, Francia e Slovacchia chiedono inoltre di non sottovalutare gli oneri amministrativi associati all’attuazione del Cbam, la cui complessità “può comportare ritardi e un aumento significativo dei costi di gestione e operativi per le aziende europee”. Per questo motivo invocano una “semplificazione del quadro normativo per fornire agli operatori norme tecniche chiaramente definite”.
Ricordiamo che, proprio per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità, l’Ue ha già stabilito che oltre l’80% delle aziende ammissibili alla nuova tassa sarà esentato.
Un’altra richiesta riguarda l’estensione del Cbam alle emissioni indirette, che dovrebbe avvenire “solo se non compromette la decarbonizzazione e la competitività dei settori elettrointensivi”.
I due nodi sul “carbon leakage”
La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (il cosiddetto “carbon leakage”) viene attenzionata sotto due punti di vista nel non-paper.
Per quanto riguarda il consumo o utilizzo finale dei prodotti (“downstream”) la richiesta è di ampliare entro la fine del periodo di transizione la lista di circa 20 beni considerati a “rischio fuga”, in modo da inglobare “alcuni prodotti finali altamente lavorati”, per i quali “potrebbe essere necessario considerare un metodo semplificato per il calcolo delle emissioni incorporate”.
L’altra criticità riguarderebbe invece le esportazioni, poiché le attuali norme Cbam “rischiano di creare uno svantaggio non compensato per i prodotti europei coperti dall’Ets ed esportati nei mercati di Paesi terzi”.
In questa fase, infatti, il Cbam non prevede alcuna misura per prevenire il rischio di fuga di carbonio dalle esportazioni. L’articolo 30 del regolamento dispone solo una valutazione ex post ogni due anni a partire dalla fine del periodo di transizione.
Ma questo approccio potrebbe rappresentare un pericolo per l’industria Ue, sostengono i tre Paesi firmatari, che invocano una “valutazione ex ante prima della fine del periodo di transizione”.
- Il non-paper (pdf)