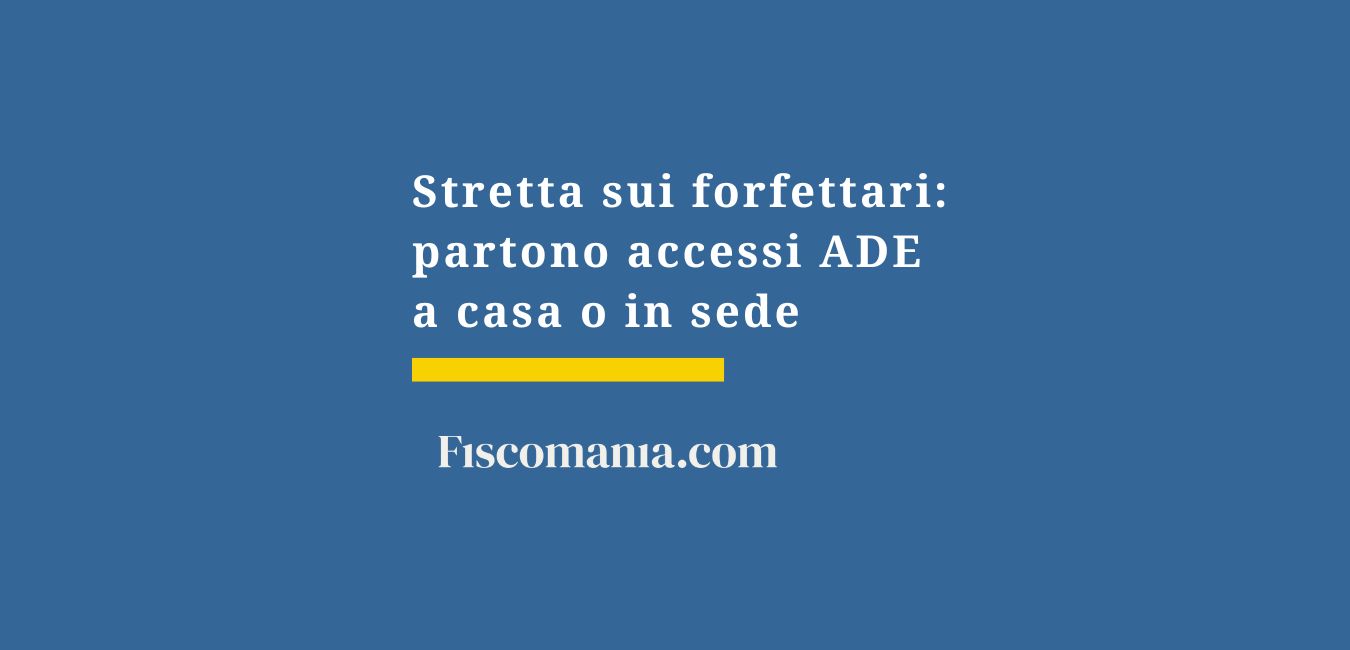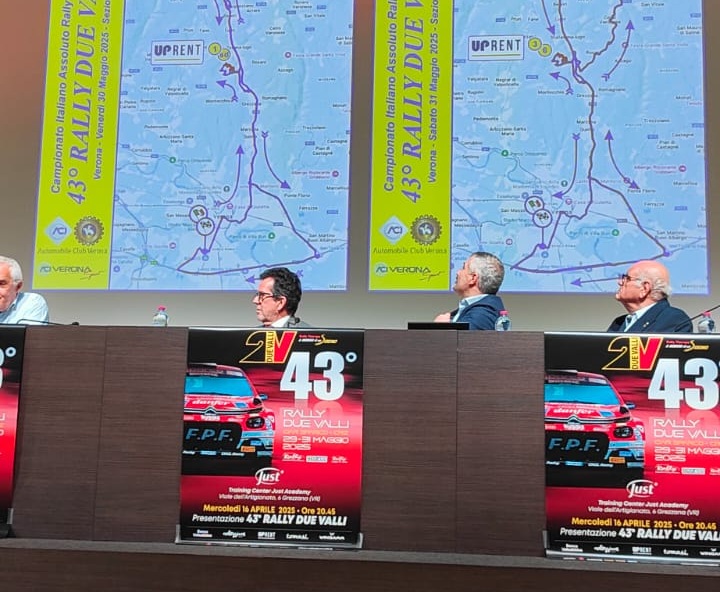Il blu, il puzzle e l’autismo: chi sceglie i simboli che lo rappresentano? Intervista a Sofia Gottardi
Cominciamo da una domanda semplice, ma fondamentale: perché il blu è associato all’autismo? Il blu è uno dei colori più amati al mondo, da sempre legato a sensazioni di fiducia, calma e sicurezza. Ed è proprio per questo che è stato scelto dalle Nazioni Unite, nel 2007, come colore simbolico della Giornata Mondiale per la […] The post Il blu, il puzzle e l’autismo: chi sceglie i simboli che lo rappresentano? Intervista a Sofia Gottardi appeared first on The Wom.


Cominciamo da una domanda semplice, ma fondamentale: perché il blu è associato all’autismo? Il blu è uno dei colori più amati al mondo, da sempre legato a sensazioni di fiducia, calma e sicurezza. Ed è proprio per questo che è stato scelto dalle Nazioni Unite, nel 2007, come colore simbolico della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra ogni anno il 2 aprile.
Il blu è da sempre associato a emozioni come la serenità, la sicurezza e la razionalità. Secondo alcuni studi sulla percezione dei colori, è uno dei colori più amati al mondo. Non è un caso, allora, che sia stato scelto per rappresentare una condizione come l’autismo, che coinvolge la sfera della comunicazione, delle relazioni e dell’elaborazione sensoriale.
Il blu evoca anche profondità, proprio come l’autismo, che non è una realtà lineare o semplice da definire
Ogni persona autistica è diversa, e il blu – che può essere chiaro, scuro, brillante o profondo – diventa simbolo di questa variabilità infinita.
Il blu, un colore “scoperto” tardi, ma entrato nella nostra vita in modo potente
Non tutti sanno che il blu è uno degli ultimi colori ad essere stati riconosciuti dalle civiltà antiche. Nell’Iliade e nell’Odissea, ad esempio, non viene mai nominato. Il mare, per Omero, è “scuro come il vino”. Anche nella Bibbia il blu è assente. Le prime popolazioni a valorizzarlo furono gli Egizi, con l’uso dei lapislazzuli nelle maschere funerarie e nei gioielli. Solo secoli dopo si iniziarono a creare pigmenti come il blu oltremare, il blu di Prussia o quello sintetico.
Oggi il blu domina il mondo digitale: dai social network ai loghi di grandi aziende, è un colore che ci circonda e ci comunica qualcosa di affidabile, aperto, connesso.
Gli altri simboli dell’autismo
Se il blu è stato accolto come colore ufficiale per promuovere la consapevolezza sull’autismo, più controversa è la questione del simbolo del puzzle, spesso utilizzato per rappresentare l’autismo. È un simbolo nato negli anni ’60, creato molto probabilmente da persone non autistiche, con l’idea che l’autismo fosse “un mistero da risolvere”, qualcosa di incompleto.
Oggi molte persone autistiche prendono le distanze da quel simbolo: lo trovano riduttivo, stigmatizzante, e persino alcune volte offensivo. Come ci ha raccontato una persona autistica che intervisteremo tra poco, ovvero la comedy e attivista Sofia Gottardi:
Quando aiutavo un bambino autistico con i compiti, era lui a completare i puzzle, non io. E allora, davvero a chi manca un pezzo?
Per questo, negli ultimi anni, si sta diffondendo un altro simbolo: il segno dell’infinito colorato, che rappresenta la neurodiversità in tutte le sue forme. È un’immagine che non cerca di semplificare l’autismo, ma anzi lo celebra nella sua complessità e ricchezza.
LEGGI ANCHE – Autismo: nasce a Milano un nuovo centro specializzato
Dare voce a chi l’autismo lo vive davvero
Aprile è l’occasione per riflettere non solo su cosa significa essere autistici, ma anche su come ne parliamo. Chi decide i simboli? Chi racconta? E soprattutto: chi viene ascoltato?
Se vogliamo costruire una società più accogliente e consapevole, dobbiamo coinvolgere direttamente le persone autistiche. Non bastano i colori, non bastano i gesti simbolici: serve ascolto, spazio, rappresentanza.
Perché come dice Sofia Gottardi:
Non si può parlare di autismo senza noi. Sarebbe come organizzare un convegno sull’aborto solo con uomini sul palco
Dunque parliamone direttamente con lei, Sofia Gottardi, comica vicentina classe 1996, anche lei autistica, che grazie alla sua comicità originale e senza filtri abbatte anche pregiudizi e discriminazioni.
Intervista a Sofia Gottardi
Il tuo lavoro come comica è stato in qualche modo influenzato dall’autismo? E a proposito di umorismo: si può fare ironia (sana e consapevole) sull’autismo?
Il mio stand-up comedy show attuale, Autistica Sprint, parla di vari argomenti, tra cui dell’autismo. Questo perché, quando ho ricevuto la diagnosi due anni fa, mi si è davvero aperto un mondo, e mi sono divertita a studiare il tema attraverso tutte le fonti che trovavo. Da una parte so che, nel mio lavoro, sensibilizzare sullo spettro dell’autismo può aiutare sia me che altre persone autistiche a essere meno discriminate. Dall’altra, ne parlo perché lo trovo un tema sinceramente interessante. Studiandolo, mi sono interrogata non solo su me stessa, ma anche sul concetto di identità, di relazione sociale e interpersonale, di normalità… mi fermo, altrimenti non la smetto più! Non mi definisco un’attivista: semplicemente sono una comica che vuole parlare di ciò che vive, che le piace o la colpisce, sperando – nel farlo – di far sentire meno sole diverse persone. Ma, come si vede dal mio One Disagiata Show su YouTube e dai miei video su Instagram, parlo anche di tanti altri argomenti. C’è chi dà per scontato che un* comic* parte di una minoranza faccia comicità di un tipo specifico, e questo mi fa molto ridere. Hannah Gadsby e Jim Jefferies, ad esempio, sono entrambi autistici: la prima è amatissima dalle attiviste femministe, il secondo assolutamente odiato. La prima ha parlato ampiamente della sua diagnosi, il secondo solo brevemente. E ho conosciuto comici neurodivergenti che non ne hanno mai parlato. Ognuno fa la sua scelta. Personalmente, preferirei che si parlasse di autismo nella comicità senza disinformare, perché davvero moltissime persone non sanno niente dell’autismo – neanche le basi. Informarsi su un argomento prima di scherzarci sopra non lo vedo come una limitazione alla comicità. Al contrario: più cose sai, più spunti hai per nuove battute – magari che nessuno ha mai pensato prima, proprio perché nessuno aveva approfondito certi particolari. C’è chi preferisce che si scherzi sull’autismo con un’ottica di sensibilizzazione, chi invece predilige un’ottica di black humor, più provocatoria. Io preferisco far capire le mie idee mescolando diversi stili. Come ho spiegato nel mio TEDx: meglio il Black Humor o la sensibilizzazione? Non devi scegliere, il black humor può essere usato come una valvola di sfogo per i propri disagi. Quindi non è obbligatoriamente slegato da una funzione informativa. Ovviamente non tutti apprezzano la comicità improntata sulla sensibilizzazione o sul black humor, ma ci sta: son gusti.
Perché secondo te è importante superare simboli come il puzzle e adottare quello dell’infinito?
Il simbolo del puzzle è un simbolo antiquato, inventato da persone non autistiche per descrivere le persone autistiche, in un’epoca in cui c’era ancora più discriminazione sul tema. Il puzzle rappresenta le persone autistiche come individui a cui “manca qualcosa”, come “enigmi da risolvere”. Il simbolo dell’infinito, invece – oltre a essere stato scelto da persone autistiche – rappresenta l’infinità di diversità tra le persone nello spettro. Ne ho parlato anche in un video sul mio profilo Instagram, ma francamente il punto non è solo il simbolo in sé: è un esempio per affrontare un tema molto più ampio, ovvero l’importanza che siano i membri di una comunità a decidere quali sono i simboli che li rappresentano. Non gli altri.
Non pretendo di esprimere il pensiero del 100% delle persone autistiche: mi sono limitata a condividere una visione attualmente molto diffusa nella comunità, e che voglio valorizzare. Quando vedo il simbolo del puzzle, non penso che sia stato scelto con cattiveria o con l’intento di discriminare. Penso semplicemente che non ci sia stato un aggiornamento sul tema. E considerando che la sensibilizzazione su certi argomenti va di pari passo con le scoperte scientifiche e psicologiche, aggiornarsi è fondamentale, soprattutto se si lavora nell’ambito della psicologia, della medicina, della didattica, o anche solo se si desidera organizzare un evento a tema. Pur essendoci ancora molte cose da scoprire sulle neurodivergenze, abbiamo già fatto passi importanti. Pensiamo che, prima degli anni Novanta, si credeva che donne autistiche come me – cioè senza deficit mentali e considerate “praticamente autosufficienti” dalla società (il termine specifico è “autistica con livello di supporto 1”) – non esistessero. È grazie agli studi di Svenny Kopp se, ad esempio, Greta Thunberg ha ricevuto una diagnosi di autismo. Non credo di avere la verità in tasca, né voglio atteggiarmi a quella che sa tutto. Penso che la sensibilizzazione sia un percorso, non uno stato fisso. Mi è capitato, in passato, di fare errori parlando di altre minoranze – compresa la mia – e spero che non succeda più. L’importante è mantenere la mente aperta e ascoltare come le persone vorrebbero essere trattate, per non farle sentire oppresse. Detto questo, mi ha fatto molto riflettere il fatto che diverse persone neurotipiche (cioè non autistiche), dopo aver visto il mio video, si siano sentite così offese da commentare che sono “stupida” o “saccente”, quando avevo solo espresso un consiglio su come venirci incontro. Invidio le persone che si arrabbiano perché qualcuno mette in discussione le loro abitudini di pensiero, anziché indignarsi per la discriminazione che si subisce ogni giorno.

Quali messaggi vorresti vedere di più durante il mese di aprile, e quali invece vorresti fossero eliminati?
Essendo l’autismo una neurodivergenza e non una patologia, è scorretto (oltre che discriminatorio) dire “affetto da” o “soffre di autismo”, così come tutto ciò che descrive l’autismo come una malattia, un problema o una sfida. È giusto riconoscere che le famiglie di persone autistiche – specialmente se con deficit mentali o non verbali – abbiano bisogno di supporto e informazione. Tuttavia, passare il messaggio che i figli autistici siano una tragedia rende più difficile la loro integrazione nella comunità, e fa credere ai genitori che debbano andare nel panico, che non sia possibile costruire un clima familiare sereno.
L’autismo non è il problema. Il problema è la mancanza di informazione, il supporto inadeguato da parte di professionisti aggiornati e la scarsa sensibilizzazione della società
Lo stesso discorso vale per le altre neurodivergenze, come l’ADHD (può capitare che le persone autistiche siano anche ADHD: io e alcuni miei amici, ad esempio, lo siamo). Non supporto eventi o persone che non danno voce a persone autistiche come me – verbali e senza deficit cognitivi – perché considerate “non abbastanza autistiche”. Ogni persona autistica è diversa. Possiamo avere deficit mentali o motori, oppure no; ci sono diversi livelli di supporto, ma siamo tutti autistici. Non è una compromissione del linguaggio a determinarlo, e non averne non ci rende “meno nello spettro”. Spesso, quando dicono “non sei autistica”, in realtà intendono “non sembri avere problemi”, perché l’autismo viene ancora associato automaticamente a un problema.
Il punto è che non è una difficoltà in sé, ma una difficoltà in relazione a una società che non tiene conto delle necessità delle persone considerate “diverse”. Io ho vissuto bullismo e traumi emotivi perché avevo un modo diverso di percepire e relazionarmi con la realtà e con gli altri, senza nemmeno sapere il perché. Venivo trattata come “sbagliata” e, di conseguenza, mi sentivo un errore. Cercavo di cambiare la mia personalità e di sembrare meno neurodivergente possibile, solo per essere accettata. È giusto che ognuno cerchi di venire incontro agli altri, ma da neurodivergente sei quasi sempre tu a dover fare questo sforzo, senza reciprocità. E questo porta, oltre a isolamento sociale e malessere, anche a un enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Dopo aver scoperto di essere autistica, ho compreso meglio come funziono e come posso venire incontro agli altri senza annullarmi, tenendo conto anche delle mie esigenze. Ad esempio: chiedere piccoli accorgimenti come “porta pazienza se non riesco a guardarti negli occhi, sono troppo stanca”. La mia qualità di vita è davvero migliorata. Ma sarei stata sempre peggio se fossi rimasta nella mentalità: “No, non sono autistica perché non ho deficit mentali”. Inoltre, non sopporto l’infantilizzazione delle persone nello spettro – anche con deficit cognitivi – quando vengono definite “angeli”, “speciali”, “innocenti”, “bravissimi a prescindere” solo in quanto autistici. Non si è nello spettro solo da bambini: lo si è sempre. E un neurodivergente con deficit, da adulto, resta un adulto. Come ho già scritto, ogni persona è diversa: ci sono autistici di buon cuore, stronzi, non interessati al sesso, molto molto interessati al sesso, gay, trans, juventini… di tutto! In sintesi, si può fare informazione sulla nostra complessità senza definirci a priori buoni, cattivi, geniali o stupidi.
Come ti vedi nel futuro? E cosa speri cambi – per te, per gli altri, per tuttə?
Nel futuro spero di essere ricca, in grado di volare, camminare sui muri, mangiare Nutella tutti i giorni senza conseguenze fisiche e avere un drago domestico. Spero anche che nessuno venga oppresso o trattato peggio degli altri solo perché è diverso – ma mi rendo conto che questa è un po’ più difficile da realizzare.
The post Il blu, il puzzle e l’autismo: chi sceglie i simboli che lo rappresentano? Intervista a Sofia Gottardi appeared first on The Wom.