“Femminicidi d’onore”, a quattro anni dalla morte di Saman Abbas un libro collettivo sui “diritti negati delle donne migranti”
Ci siamo già dimenticati di Saman Abbas? E delle altre Saman che vivono in Italia oggi? Così come abbiamo archiviato in fretta le storie di Hina Saleem, Sana Cheema e quelle di tutte le altre donne uccise per onore e di cui, spesso, neppure ci si è presi la briga di imparare i nomi. Quattro […] L'articolo “Femminicidi d’onore”, a quattro anni dalla morte di Saman Abbas un libro collettivo sui “diritti negati delle donne migranti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ci siamo già dimenticati di Saman Abbas? E delle altre Saman che vivono in Italia oggi? Così come abbiamo archiviato in fretta le storie di Hina Saleem, Sana Cheema e quelle di tutte le altre donne uccise per onore e di cui, spesso, neppure ci si è presi la briga di imparare i nomi. Quattro anni dopo la morte della giovane 18enne e dopo la sbornia mediatica, con le telecamere si sono spenti anche tanti degli appelli per il cambiamento. Mentre chi si batte contro il patriarcato in tutte le sue forme, continua la lotta e lo fa cercando di trovare spazio per le voci dimenticate delle donne. “Femminicidi d’onore. Dal processo Saman ai diritti negati delle donne migranti” – libro edito da Futura Editrice e a cura di Ilaria Boiano e Isabella Peretti – si fa carico di questo: riportare nel dibattito l’urgenza di una questione ancora troppo spesso liquidata in fretta. E tenere accesa una luce per tutte le altre. Un’opera collettiva, composta da dieci contributi, che nasce dalle esperienze concrete e dalle riflessioni di chi è impegnato in prima linea.

Il femminicidio di Saman Abbas, ricorda nel libro l’attivista per i diritti umani e fondatrice di Trama di Terre Tiziana Dal Pra, è il sesto di un elenco di donne uccise in Italia e che abbiamo dimenticato. Della 18enne appena ammazzata a Novellara, per la cui morte tutta la famiglia è appena stata condannata in appello, e delle “omissioni delle istituzioni che non hanno impedito una fine tragicamente prevedibile”, parlano le avvocate di parte civile Teresa Manente e Rossella Benedetti. “Non stupisce”, scrivono, “che l’Italia sia stata di recente nuovamente condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani per l’inadeguatezza della risposta istituzionale al fenomeno della violenza domestica e per aver omesso di adottare misure operative adeguate e prevenire la violazione del diritto alla vita”. E la domanda, da cui parte l’analisi collettiva, è rivolta alle altre: “Quante Saman ci sono? E dove sono? Sono nelle scuole, nelle famiglie, ragazze che sanno già di essere destinate a un matrimonio non voluto”, scrive Isabella Peretti nell’introduzione. “E quante madri ci sono, assoggettate alla violenza patriarcale, che accompagnano le figlie alla morte, come la madre di Saman?”. Sulla figura di Nazia Shaheen, mamma di Saman condannata all’ergastolo, si concentra l’avvocata Giovanna Fava. “La sua silenziosa presenza pesa come un macigno”, scrive. “Non vi è dubbio alcuno che con l’uccisione della figlia, Nazia uccida anche una parte di sé”. E per cambiare le cose, dice, “non basta raggiungere le ragazze nelle scuole, prima o parallelamente, occorre entrare in contatto con le loro madri, fare in modo che imparino la lingua del paese che le ospita e possano diventare parte integrante della società”, “occorre consentire loro di capire che esistono altre possibilità di scelta anche per loro”. Segue l’intervento di Maria Grazia Calandrone, scrittrice che, tra le varie opere, ha scritto anche la storia della madre, suicida per essere fuggita a un matrimonio violento. E qui presente con un monologo scritto per Terre des Hommes: la storia di Nandhini, giovane donna che ha rifiutato le nozze forzate.
A introdurre l’intervento di Tiziana Dal Pra è una domanda: “Facciamo tutto ciò che possiamo, tutto ciò che dobbiamo?”. L’attivista per i diritti umani inizia con una fotografia: è quella di Hina Saleem, uccisa nel 2006 dal padre e sepolta nel cimitero di Brescia, nel riquadro islamico zona adulti. “Una tomba offerta e pagata da ignoti bresciani, dopo il consenso del fratello e della madre. Questa sepoltura è una tragedia aperta”, scrive Dal Pra, “anche simbolicamente. Per ben tre volte la foto di Hina è stata tolta dalla tomba perché giudicata offensiva e non rispettosa dei dettami religiosi islamici. Il fratello rivendica lo strappo della foto della sorella. Anche da morta Hina fa scandalo. In quella foto sorride e indossa una maglietta fucsia che le lascia fuori una spalla: troppo scoperta, troppo visibile”. Dal Pra continua: “Hina Saleem è la prima ragazza pakistana morta in Italia per un femminicidio d’onore. Ancora fatichiamo in Italia a nominarlo come tale perché forse non vogliamo vedere una radice di violenza che ci riporta troppo indietro, ma così facendo alimentiamo equivoci e alibi nelle nostre azioni di contrasto. Non c’entra l’Islam; e, se c’entra, è dentro un miscuglio di tradizioni. Di sicuro c’entrano il patriarcato e i clan familiari”.
Dal Pra parla della sua esperienza nel sostegno alle giovani che decidono di ribellarsi a destini già segnati. E spesso lo fanno seguendo le proprie emozioni, rifiutandosi di reprimerle: “Alcune ragazze che ho incontrato, sostenuto e accompagnato nel loro percorso di uscita dai matrimoni forzati mi hanno detto: ‘Certo voi siete fortunate, ché potete raccontarvi delle vostre farfalle nello stomaco; per noi queste farfalle sono la nostra condanna a morte’”. E proprio chi decide di seguirle, ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Ma soprattutto, ha bisogno di essere “vista”: “E’ troppo tardi quando conosciamo i nomi delle vittime”, scrive Dal Pra. “Scopriamo le loro non-vite solamente nelle aule dei tribunali dove si chiede giustizia per una morte annunciata e una condanna all’ergastolo anche a una ‘madre assassina’. Cominciamo a vederle, cercarle. E’ il primo decisivo passo da fare”.
Vederle e dare loro la parola, questi i gesti che possono essere rivoluzionari. Peretti continua raccontando l’esperienza del Tribunale delle donne per i diritti delle donne in migrazione, che si è svolto nel 2023, “in cui le donne sono diventate testimoni” e “una Giuria non ha giudicato, ma ascoltato”. E’ nato dall’esperienza del Tribunale delle donne di Sarajevo, dove “solo le donne hanno potuto trascendere il conflitto tra nazionalismi e mettersi insieme”. E da quello spunto, è nata l’esperienza di Roma, alla Casa internazionale delle donne. “Perché le testimonianze delle violenze sono un momento cruciale di costruzione della memoria e del diritto”. E, continua Peretti, “avevano tutte una gran voglia di parlare le donne immigrate che hanno partecipato alle sedute”. “Le migranti che parlano in questo libro, donne afghane, pakistane, nigeriane, ivoriane, indiane, e ci raccontano di matrimoni forzati e di fughe, di violenze ai confini e di violenze nella tratta; di discriminazioni religiose e razziste”, ma anche “di audizioni presso le Commissioni per l’asilo in cui le loro storie tragiche non sono credute”. Peretti, infine, affronta una delle domande centrali: “C’è un crinale tra ‘culture barbare’ e un Occidente dei diritti, o piuttosto sono forme diverse, ma pur sempre violente, con cui ovunque si esprime e persiste il patriarcato?”. La sua riflessione si chiude con quello che è anche un punto di partenza: “Il terreno di incontro”, dice, “è la Costituzione italiana”.
Infine, due approfondimenti firmati da Asia Jan e Mursal e Flavia Mariani si focalizzano sulle donne afghane, “recluse in patria e migranti nel mondo”. “Stanno nascendo”, raccontano, “associazioni di attiviste afghane che costrusicono network a livello internazionale, chiedono l’attenzione e il sostegno della società civile e dell’opinione pubblica per portare avanti le loro cause”. Anche per loro, serve una “giustizia femminista”, come sostiene l’intervento di Ilaria Boiano che chiude il libro. “La sfida è creare un ponte tra le testimonianze delle donne e i processi decisionali istituzionali, garantendo che le competenze tecniche non prevalgano sull’ascolto delle esperienze e che la giustizia risponda non solo ai bisogni legali, ma anche a quelli personali e sociali di chi cerca protezione e riconoscimento”. Per tutte le altre Saman Abbas, Hina Saleem, Sana Cheema. Perché non vengano dimenticate. E perché siano le ultime da aver pagato con la vita il loro desiderio di libertà.
L'articolo “Femminicidi d’onore”, a quattro anni dalla morte di Saman Abbas un libro collettivo sui “diritti negati delle donne migranti” proviene da Il Fatto Quotidiano.


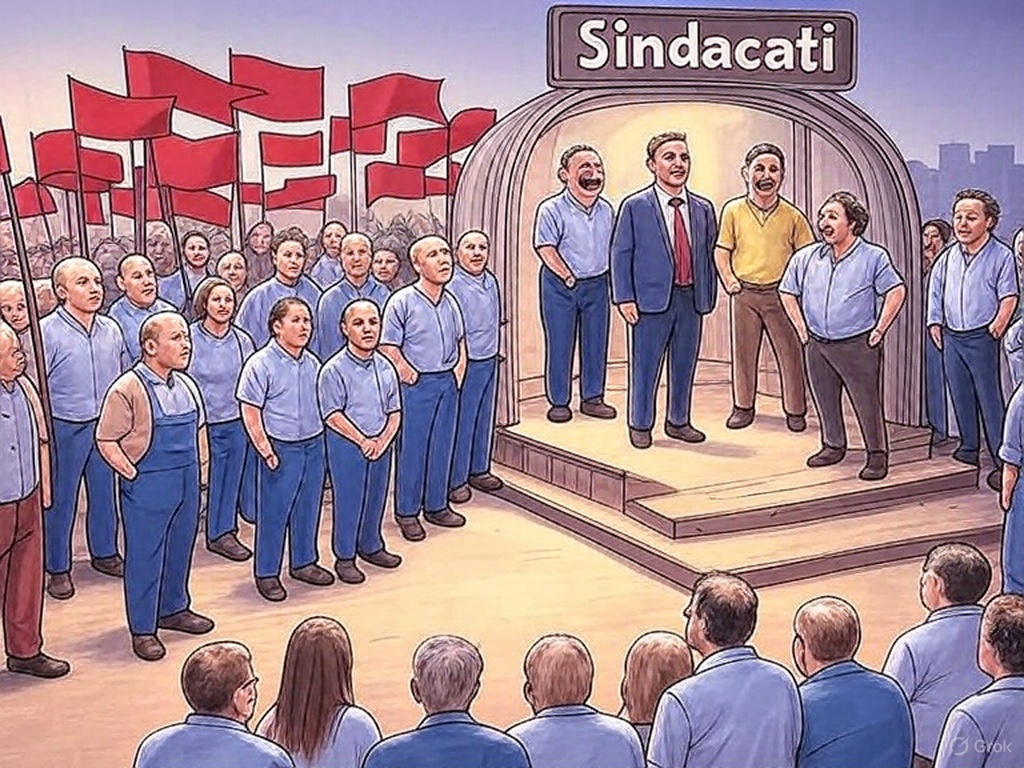



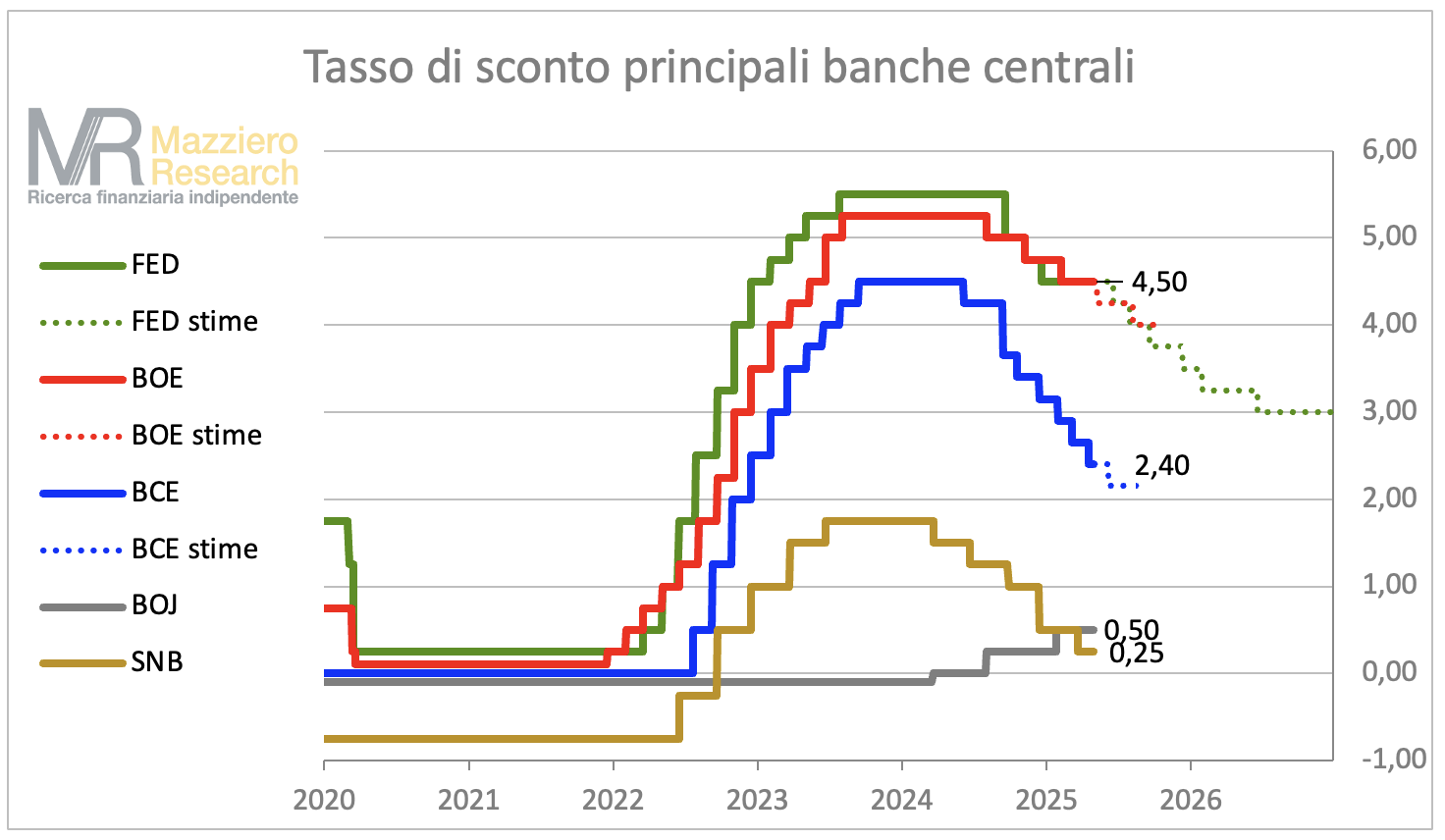





/https://www.html.it/app/uploads/2025/05/meta-ai-______.jpg)
/https://www.html.it/app/uploads/2025/05/apple-gemini-.jpg)





































