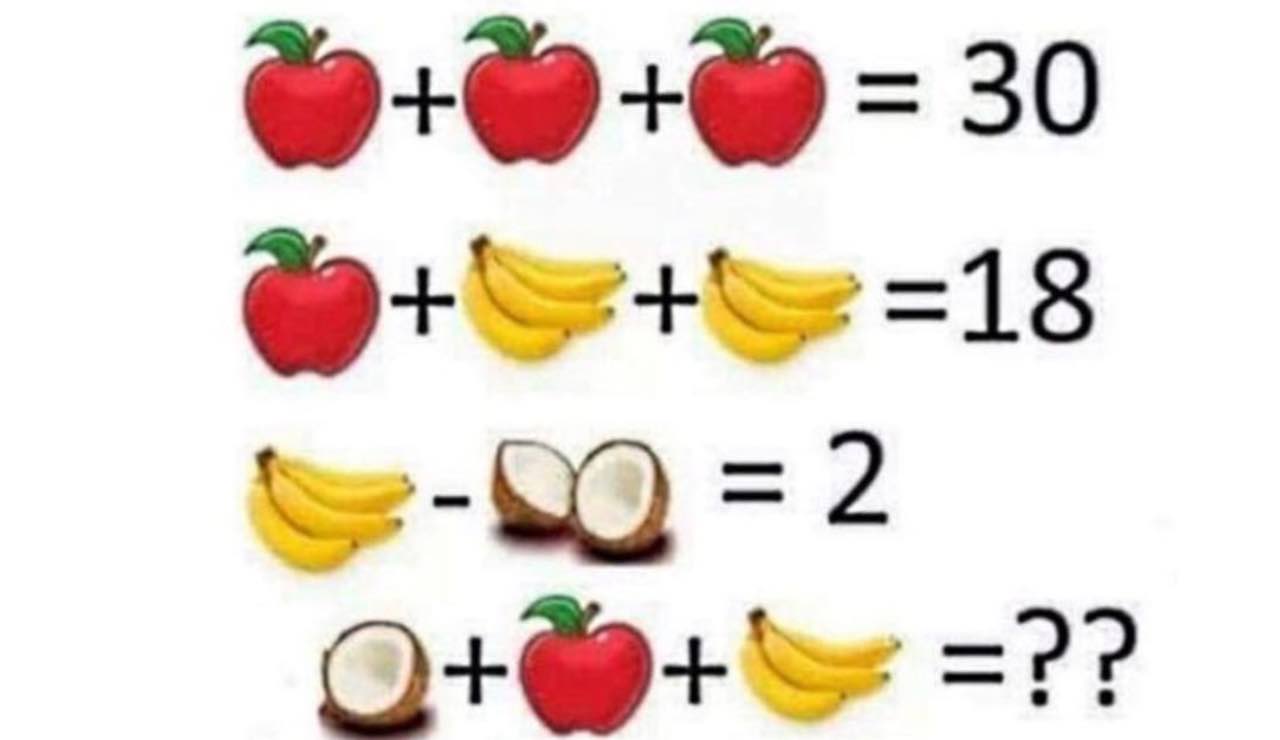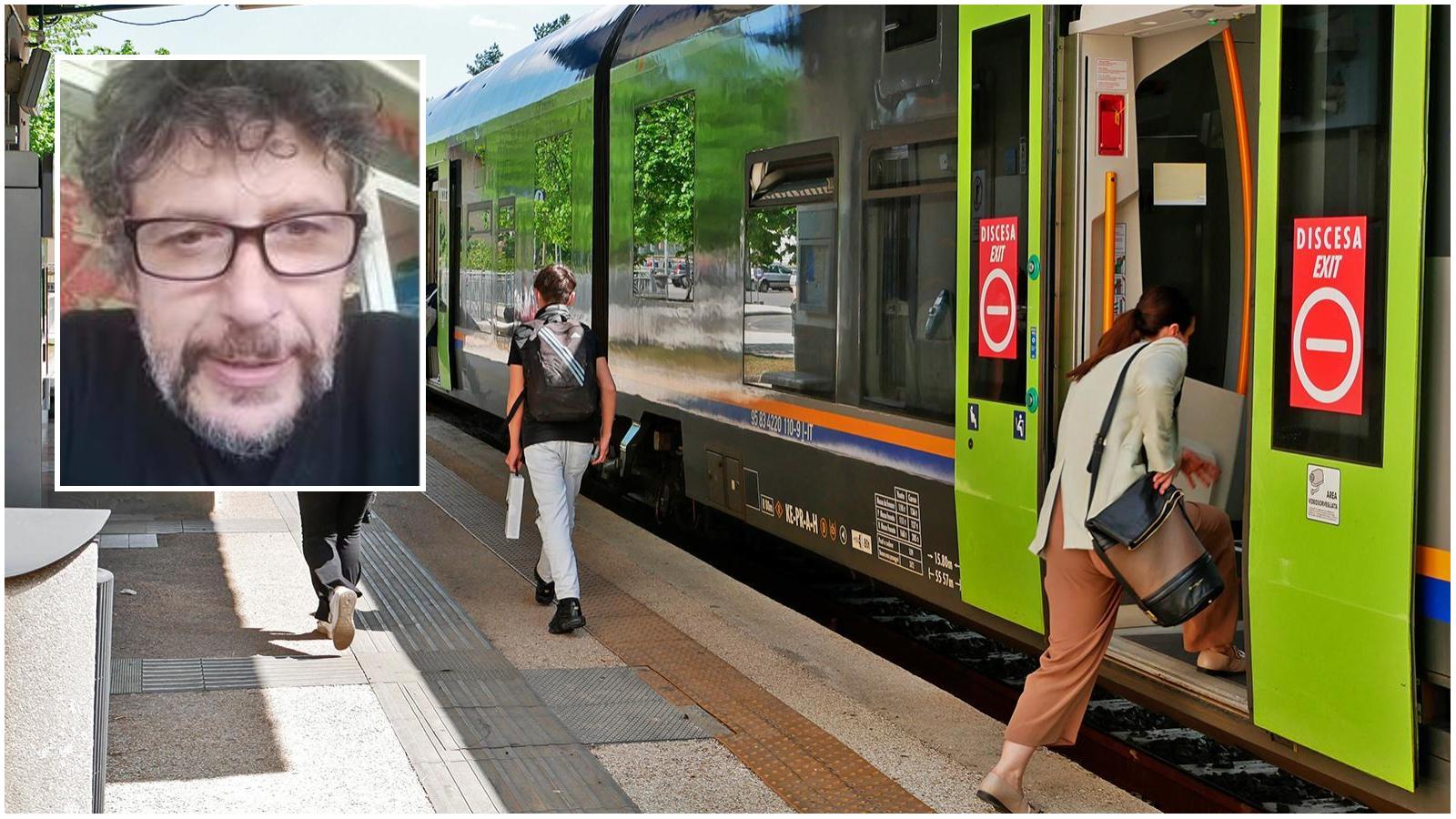Ceto medio alla riscossa
Il combinato disposto della crisi economica (ormai più che ventennale) e della contestuale polarizzazione della ricchezza richiede un nuovo slancio per il pilastro della società e dell’economia. Le soluzioni non mancano L'articolo Ceto medio alla riscossa proviene da Economy Magazine.

Vittima della crisi, e al contempo unico possibile motore per uscirne. La duplice natura del ceto medio italiano ricorda un koan, il paradosso Zen. Da un lato, i numeri dimostrano che la sua difficoltà è figlia del combinato disposto della crisi economica più che ventennale del aese e della contestuale polarizzazione della ricchezza. Dall’altro, è proprio da una riscossa del ceto medio, pilastro della società e dell’economia, che l’Italia dovrebbe trovare nuovo slancio. È questa la verità che si legge in controluce nei rapporti realizzati dal Censis per Cida, la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità che del ceto medio si è fatta paladina. Nelle prossime pagine il suo presidente Stefano Cuzzilla delinea il percorso possibile di un gruppo sociale che una volta sentiva di avere il mondo in mano e che adesso, tra redditi diminuiti, potere reale evaporato e marginalità nel dibattito, rischia di essere tagliato fuori dai giochi.
La crisi dell’economia italiana emerge in tutta la sua evidenza dai dati. Tra il 2003 e il 2023 il nostro Pil è cresciuto molto meno di quello degli altri paesi europei, che a loro volta sono cresciuti molto meno rispetto a quello di paesi di altre aree del pianeta. Più nel dettaglio, il Belpaese ha registrato una crescita reale del 5,3%. Nello stesso periodo, quello francese è aumentato del 24,8%, quello tedesco del 26,8%, quello spagnolo del 27,1%, quello degli Stati Uniti del 50,4%, quello dell’India del 241,3%, quello della Cina del 376,3%.
Proprio mentre l’Italia arrancava e veniva superata praticamente da tutti i concorrenti in termini di crescita, è stata colpita dalla dinamica globale di aumento delle diseguaglianze, con una piccola quota della popolazione che possiede una quota sempre più grande della ricchezza. Il 10% delle famiglie più benestanti possiede quote del totale della ricchezza pari rispettivamente al 53,9% in Francia, al 56% in media nei Paesi dell’Area Euro, al 58,5% in Italia. Il paese dell’Area Euro con il grado di concentrazione più alto della ricchezza, la Germania con il 61,2%, ha però visto l’indicatore tra il 2013 e il 2023 rimanere sostanzialmente stabile, mentre aumentava in Francia di 1 punto percentuale e in Italia di 4,6 punti percentuali.
Alla crescita rallentata – basti pensare che in Italia negli anni Settanta il Pil è cresciuto del 41,6%, negli anni Dieci del terzo millennio dello 0,9% – si è così aggiunto l’ampliarsi delle disparità. Tra il 2001 e il 2021 il reddito disponibile netto delle famiglie pro capite in Italia si è così ridotto del 7,7%, mentre in Germania aumentava del 7,3%, nella media Ue del 9,7% e in Francia del 9,9%. Un fatto che non stupisce a vedere la differenza tra gli stipendi italiani e quelli europei: per fare due esempi, secondo i dati di Indeed un architetto italiano guadagna 24071 euro, contro i 51818 di un collega francese e i 66081 di un tedesco; un medico generico 41909, contro gli 85639 del francese e i 117669 del tedesco.
Al 10% delle famiglie che ormai detiene quasi il 60% della ricchezza fa da contraltare un 50% che ne detiene appena il 7,4%. L’Oxfam rincara la dose: il 5% più ricco delle famiglie italiane, titolare del 47,7% della ricchezza nazionale, possiede quasi il 20% in più della ricchezza complessivamente detenuta dal 90% più povero. Nel 2024 la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata di 61,1 miliardi di euro al ritmo di 166 milioni di euro al giorno, raggiungendo un valore complessivo di 272,5 miliardi di euro detenuto da soli 71 individui. A colpire non è tanto la pittoresca considerazione che l’ammontare permetterebbe di coprire l’intera superficie della città di Milano con banconote da 10 euro, quanto la provenienza di quei denari: Il 63% della ricchezza miliardaria in Italia è frutto di eredità. Oxfam parla apertamente di “natura fortemente ereditaria della ricchezza in Italia: un dato che attesta come, più che altrove, il destino economico degli italiani sia determinato dalla famiglia in cui nascono, piuttosto che dal percorso professionale intrapreso nel corso della loro vita”. Maurizio Franzini, professore di Politica economica alla Sapienza di Roma, membro del consiglio dell’Istat, che ha presieduto tra l’agosto 2018 e il febbraio 2019, conferma autorevolmente questa analisi: «Il cambiamento forse più rilevante che abbiamo osservato risiede nell’origine della ricchezza» ha detto al Foglio. «Fino a una generazione fa era frutto in larga parte dei risparmi accumulati nell’arco della vita, oggi invece la quota prevalente della ricchezza è frutto di eredità».
Il ceto medio insomma invece di creare valore, se non arriva a rompere il salvadanaio di famiglia comunque riesce a risparmiare molto meno di un tempo. Ecco che a una quota ristretta di persone molto benestanti fa da contraltare un corpo intermedio che, scrive il Censis, “via via scivola verso il basso o, comunque, vive nella paura di scivolare più in basso”. Non per niente non solo cala il reddito disponibile, ma anche la ricchezza netta, che comprende tutti gli asset delle famiglie come immobili, azioni, risparmio, al netto dei debiti, che è scesa del 5,5% nel periodo dal 2014 al 2024.
L’ultimo report dell’Istat sulle condizioni di vita e di reddito delle famiglie conferma il consistente impoverimento del ceto medio. L’Italia, secondo l’Ilo, fa peggio di tutti gli altri Paesi del G20 in termini di perdita di potere d’acquisto dei salari, pari alll’8,7% rispetto al 2008. Il dato è confermato dall’Istat: se nel 2023 i redditi familiari in termini nominali sono cresciuti del 4,2% l’indice dei prezzi al consumo (Ipca) ha fatto un balzo del 5,9% traducendosi in una perdita di valore dell1,6%, analoga a quella precedente.
A essere sparito di scena, salvo le eccezioni che confermano la regola, è l’ascensore sociale. Secondo il Censis, tre quarti degli appartenenti al ceto medio sono convinti che sia sempre più difficile salire nella scala sociale – è quel che pensa anche quasi l’80% del ceto popolare e quasi il 70 di chi è abbiente o benestante. Non sorprende che circa la metà del ceto medio abbia la sensazione di arretrare nella scala sociale, e ritenga che il suo tenore di vita stia calando; e soprattutto che tre quarti tema che le generazioni future staranno peggio di quelle attuali – d’altra parte il risparmio è ridotto, il salvadanaio a rischio. «Cresce così il numero di coloro che hanno paura di rimanere tagliati fuori. Di perdere quello che hanno. Di non farcela» ha affermato il sociologo Mauro Magatti. «Una percezione rafforzata dal fatto che in tante famiglie i giovani non hanno le stesse possibilità dei padri. L’ascensore sociale in Italia è bloccato da anni». Chi può farlo ripartire, se non una nuova primavera dello stesso ceto medio?

Le proposte di federmanager
«Sono convinto che la narrazione sul declino socio economico della nostra categoria, che è un cardine sia del cosiddetto ceto medio che della classe dirigente, sia il frutto di scelte sbagliate compiute dalla politica»: Valter Quercioli, presidente di Federmanager e dirigente industriale attivo in una multinazionale del settore termoelettromeccanico, aveva dedicato a tema una parte corposa del suo programma: «Questa narrazione non è stata contrastata a sufficienza nel tempo da chi, anche fra noi, non ha avuto al centro dei suoi pensieri la tutela e lo sviluppo della categoria ma pensieri di altro tipo, legittimi ma distanti. E gli effetti perversi di questa distrazione sono evidenti. Una categoria da sempre ambita, anche dai giovani, sembra sprofondata nel baratro del disinteresse e delle basse retribuzioni, salvo pochissimi esponenti apicali ben pagati ma imprigionati in una sorta di ruota per criceti. è tempo di cambiare».
Secondo Quercioli, «chi aiuta l’imprenditore a creare ricchezza deve avere il giusto riconoscimento. Ed è tempo di essere noi i promotori attivi di una nuova narrazione positiva della categoria, che deve tornare centrale dopo troppi anni di subalternità: dobbiamo volerci bene. In realtà, siamo una categoria tartassata. Nel nostro Paese chi ha un reddito lordo oltre i 50 mila euro è un contribuente importante, per l’erario. Ma le fasce che rappresentiamo hanno perso più potere d’acquisto di quelle a minor reddito. Il punto, però, è passare dalla fase delle recriminazioni a quella della proposta e del confronto con le istituzioni, che non ci hanno ascoltati abbastanza. Non vogliamo essere bersaglio ulteriore di prelievi. E il fatto di aver saputo creare un nostro sistema di welfare non deve essere considerato una specie di colpa. Abbiamo idee chiare sul nostro ruolo pubblico, e le affermeremo sempre di più. Le istituzioni dovranno capire: non possiamo continuare a essere il bancomat del sistema e ad essere marginali. Siamo un gruppo sociale decisivo per lo sviluppo del sistema». (s.l.)
Una scelta strategica per un’Italia più competitiva
Il ceto medio italiano, storicamente motore della crescita e della stabilità del Paese, oggi si trova in una posizione sempre più critica, schiacciato da un carico fiscale eccessivo e da un sistema che sembra penalizzare chi produce, risparmia e investe. Parliamo, nella su parte medio-alta, di manager, imprenditori e alte professionalità che, con impegno e responsabilità, contribuiscono ogni giorno alla tenuta economica e sociale dell’Italia. Eppure, questo segmento cruciale della popolazione è spesso dimenticato o addirittura ostacolato da politiche miopi che non riconoscono il suo valore strategico per il Paese. L’eccessiva pressione fiscale, che si traduce in aliquote elevate sul reddito, sulla casa, sul risparmio e sull’impresa, disincentiva l’iniziativa privata e frena i consumi. A questo si aggiunge una burocrazia opprimente, che sottrae tempo e risorse a chi vorrebbe investire e creare occupazione. Il risultato è un impoverimento progressivo del ceto medio, che vede erodere il proprio potere d’acquisto, mentre cresce la percezione di essere il vero bersaglio di uno Stato che troppo spesso tassa chi non può evadere. Eppure, è proprio la parte più dinamica e produttiva del ceto medio che dovrebbe essere al centro di una nuova strategia di rilancio del Paese. Favorire chi lavora, innova, ha e sviluppa competenze anche tra gli altri lavoratori e sostiene la domanda interna significa attivare un circolo virtuoso in grado di generare crescita reale e duratura. Serve diminuire l’evasione e il carico fiscale su lavoro. Servono politiche fiscali più eque, che, alleggeriscano il peso sulle spalle di chi produce ricchezza e favoriscano investimenti in capitale umano, tecnologia e innovazione. Rimettere il ceto medio al centro dell’agenda politica non è una concessione: è una scelta strategica per costruire un’Italia più forte, equa e competitiva. Non c’è ripresa possibile senza chi, ogni giorno, tiene in piedi il Paese con il proprio lavoro, la propria visione e il proprio senso di responsabilità.

C’era una volta una classe sociale oggi c’è un processo culturale individuale
Non più propulsione, ma resistenza. Non più creazione di valore, ma tentazione di limitarsi a gestire patrimoni ereditati. Il ceto medio ha cambiato pelle, e per sopravvivere sta cambiando strategia. «Il ceto medio cerca di ricostruire il proprio successo non più con un processo sociale ed economico, bensì culturale; ma su un piano individuale, non più collettivo» dice in questa intervista a Economy Giorgio De Rita, segretario generale del Censis.
Se cerchiamo il ceto medio, dove dobbiamo bussare?
Quel che lo ha caratterizzato negli ultimi 35-40 anni, fino alla grande crisi del 2010 – 2012, è stato lo star dentro alla crescita, al miglioramento del proprio benessere, alla società dei consumi. Questo partecipare ai processi di crescita sociali diventava poi un processo di crescita economico: avere la prima casa, la seconda casa, la lavatrice, la televisione, la macchina, la seconda macchina. Un processo sociale di appartenenza che è diventato un processo economico, che a un certo punto però si è fermato.
Sono arrivate le vacche magre?
La crescita economica non era più garantita per tutti, non era più a portata di mano. Quindi si è cominciato a ridiscutere, a rivedere che cosa voleva dire appartenere al ceto medio, che cosa voleva dire partecipare a un processo di crescita che era oramai depotenziata, che cosa voleva dire per le generazioni precedenti avere immaginato il proprio futuro, il proprio traguardo e oggi vederlo sparire dall’orizzonte. È un po’ la posizione in cui ci troviamo negli ultimi anni, con quest’idea che in fondo l’orizzonte si è offuscato, la crescita economica che era stata la traduzione in pratica di quella crescita sociale si è fermata.
E dunque?
Il futuro diventa sempre meno un progetto da costruire, sempre più invece una tutela, un fronte da proteggere. Quindi quello che era diventato un processo di crescita, di sviluppo individuale e sociale diventa un processo di resistenza, non più di propulsione. Questa è la caratteristica dell’ultima decina di anni. Non più lo spingere avanti dettato da una crescita sociale, ma una forma di resistenza dettata dalla paura dell’impoverimento. Questo è lo scenario, in cui si è inserito un nuovo aspetto: quello dell’identità individuale. L’essere ceto medio non è più, com’era prima, un’identità collettiva, con delle caratteristiche precise: più reddito, più lavoro, più consumi, più investimenti. L’identità non era quella del singolo, era l’identità di un’appartenenza, di una comunità, di un settore imprenditoriale, di un ceto che faceva dell’investimento sul futuro il processo di crescita del benessere.
Cos’è oggi che dà senso di appartenenza al ceto medio, se non è più quella a un processo di benessere?
Non può essere solo la resistenza, il non essersi impoveriti più di tanto. Non può essere nemmeno solamente la gestione di un patrimonio ereditato: diventa qualcosa di più complesso. La risposta che diamo, e che confermiamo, nel rapporto 2025, è che questo processo sociale ed economico è diventato sostanzialmente un processo culturale. La resistenza è una resistenza culturale, così come l’investimento è un investimento culturale. Si appartiene al ceto medio, ci si sente ceto medio, si costruisce collettivamente un senso di futuro del ceto medio, non più attraverso il processo economico, ma attraverso il processo culturale. Attraverso il recupero dell’essere libero professionista, delle professioni intellettuali, del conoscere, del sapere, dell’avere studiato all’estero, del saper stare dentro processi come l’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie. Quella traduzione di posizionamento sociale dettata dal benessere diventa un posizionamento sociale dettato dalla capacità e dalla profondità culturale.
Questo processo culturale può essere l’inizio della riscossa del ceto medio, ponendo le premesse per un ritorno alla propositività che è venuta a mancare?
Certo. Il nostro è uno strano Paese perché in realtà i processi sociali vengono sempre prima dei processi economici. È stato così nella grande corsa degli anni ‘60, è stato così nella crisi del ‘90 ed è così oggi: è la trasformazione sociale che induce poi il fatto economico. In questo momento questa trasformazione sociale, questa crescente attenzione ai temi dell’immateriale, per non usare la parola solo culturale, sta diventando un processo economico. Quindi la risposta alla domanda è sì, sì a condizione però che non si interpreti questo come un puro fatto economico, un puro fatto di ripiegamento, ma come un luogo di investimento vero e proprio. Quindi il ceto medio sta cercando di ricostruire il proprio successo, di ritrovare la visibilità sul proprio traguardo che non è più un traguardo economico, ma diventa un traguardo culturale. È estremamente difficile, non c’è più il senso di appartenenza che ha caratterizzato il lungo ciclo della crescita economica, è diventato molto più individuale: si gioca per sé, non per gli altri.
Quale tema potrebbe ricomporre un’identità collettiva?
Quello fiscale. Oggi il ceto medio si sente aggredito dal fisco in modo eccessivo. Purtroppo molti sentono di pagare due volte, di pagare tanto per la sanità e poi dover tirare fuori i soldi di tasca propria. Genera insofferenza sentire dire: il ceto medio è chi ha un reddito di 50mila euro. Ma se ho un unico reddito, due figli, pago le tasse, non è che sia un reddito da benestanti o da ricchi, e allora perché mi togli la detrazione dei 100 euro per la scuola dei figli? Questo sta già richiamando un senso di movimento collettivo.
Cosa vede oggi il ceto medio nel futuro?
Una traiettoria del benessere sostanzialmente interrotta, difficilmente recuperabile, difficilmente migliorabile nel tempo, e quindi un futuro di resistenza, sostanzialmente. Un futuro in cui la preoccupazione principale diventa come le nuove generazioni possano essere educate a un futuro che è difficile da immaginare. Come trasferire patrimonio materiale, ma anche patrimonio immateriale di valori, di cultura, di sensibilità sociale alle nuove generazioni. Una preoccupazione verso i figli, sia dal punto di vista economico, sia soprattutto dal punto di vista sociale.
Che altro?
Il bisogno di investimento nelle infrastrutture. Il nostro Paese, a furia di resistere, ha reso così fragili le infrastrutture, intese nel senso più largo, cioè la scuola, le reti, le tecnologie, le infrastrutture sanitarie, quelle di previdenza sociale. Quindi non soltanto le reti materiali delle grandi strade, della grande logistica, ma tutte quelle infrastrutture del nostro Paese, che secondo la maggior parte degli italiani sono diventate troppo fragili per sostenere i processi di sviluppo futuro.
Il ceto medio produceva la sua ricchezza, oggi più che altro la eredita…
La crisi demografica vede una riduzione progressiva nel numero dei nati, e oggi fa confrontare le generazioni dei nati degli anni ‘60 con i nati dei primi anni del secolo, cioè papà e figli, grossomodo, in un rapporto di 3 a 1. Questo significa che tanti zii, papà, nonni, genitori trasferiscono a un numero sempre più basso di giovani. In questo il rischio non è di depauperamento dei patrimoni, ma di un trasferimento generazionale da tanti a pochi che spinge verso una società della rendita. Non più la costruzione del futuro, non più nemmeno la resistenza che c’è stata in questi 15-20 anni di crisi, ma piuttosto la tentazione di prendere la casa dello zio e quella della nonna, farci due bed and breakfast e campare tranquilli. Che il cedo medio da costruttore dello sviluppo, a bastione che ha resistito nelle crisi peggiori, diventi poi una sorta di rentier, per il nostro Paese sarebbe pericolosissimo.
Poveri medici, capri espiatori della crisi del sistema
di Guido Quici, presidente nazionale Cimo
I medici ospedalieri sono dirigenti della Pubblica Amministrazione particolari: non solo perché hanno tra le mani la salute delle persone, ma anche perché chi lavora in ospedale oggi ha turni spalmati su 24 ore e 7 giorni a settimana, non conosce il significato della parola ferie, non sa cosa significa riuscire a rispettare l’orario di lavoro, è costantemente vittima di aggressioni fisiche, verbali, mediatiche e giudiziarie, ed è ritenuto spesso e da più parti il capro espiatorio della crisi di un sistema – il Servizio Sanitario Nazionale – che non riesce più a garantire un’assistenza efficace a tutti.
All’interno di un ceto medio sempre più in crisi, quella dei medici ospedalieri è forse una delle categorie che negli anni ha visto peggiorare maggiormente la qualità della propria vita: come dimostrato dalla Federazione Cimo-Fesmed in un sondaggio a cui hanno risposto oltre 2.000 medici, il 38% dei camici bianchi ritiene “pessima” la qualità della propria vita, percentuale che solo tre anni prima si attestava al 30%. E in questo, ovviamente, gioca un ruolo importante la disorganizzazione degli ospedali, causata da anni di tagli indiscriminati e da gravissime carenze di personale sanitario, ma anche il fattore economico e retributivo. I medici italiani hanno le retribuzioni lorde tra le più basse d’Europa: secondo l’Ocse, in media un medico specialista italiano nel 2021 guadagnava 78mila euro lordi a fronte dei 91mila dei medici francesi, dei 117mila dei belgi, dei 148mila dei tedeschi, dei 163mila degli olandesi fino ai 174mila degli irlandesi. A questo gap si aggiunge la pressione fiscale estremamente elevata: pur rappresentando lo 0,2% dei contribuenti italiani, versano il 2% dell’intero ammontare Irpef. Sempre più giovani medici quindi decidono di non lavorare nella sanità pubblica, preferendo il trasferimento all’estero – dove il loro lavoro è senz’altro valorizzato maggiormente – oppure la sanità privata. L’unica soluzione per uscire da questo tunnel è allora rendere nuovamente appetibile il lavoro del medico negli ospedali pubblici, aumentandone le retribuzioni, migliorando l’organizzazione, limitando all’ambito civile la responsabilità professionale, firmando i contratti collettivi entro le scadenze e applicandoli correttamente nelle aziende e, infine, valorizzando il ruolo del medico all’interno delle dinamiche decisionali che riguardano la gestione del Ssn.
Perdendo l’identità sociale si svaluta l’individuo
«La classe media vive un declassamento, con la paura di andare ancora più indietro; e perde anche l’immagine culturale di sé, che non è una cosa da poco». La psicoterapeuta Maria Rita Parsi inquadra così per Economy la condizione psicologica e sociale del ceto medio. «Si perde identità, si perde un valore riferito a se stessi, cioè non si ha consistenza» aggiunge Parsi. «È una svalutazione della persona che fa scappare, o fa deprimere, o fa ammalare.
I passaggi sono questi: più fughe, più rabbia, più malattie, e più indifferenza verso l’illegalità, perché l’illegalità permette di saltare i passaggi». Le conseguenze per la società italiana sono nefaste: «Questa fragilità, che dura ormai da parecchi anni, si è riverberata in maniera incredibile sulla cultura e sulle prospettive italiane di crescita, anche educative e culturali» osserva Parsi. «Prima ci si voleva dotare di strumenti, informarsi di più, leggere, prepararsi per diventare dei laureati, e poi delle persone che hanno un posto di rilievo.
Ma tutto questo impoverimento, tutta questa paura può bloccare questo passaggio, perché a quel punto si tende a mantenere le posizioni che già si hanno». Le soluzioni esistono: «Si deve calmare l’ansia di questa formidabile classe media, dando strumenti, dicendo: sentite, ci interessiamo di voi» conclude Parsi. «C’è bisogno soprattutto di un avanzamento culturale: se non facciamo una cultura del ceto medio, lo perdiamo».
Dalla parte dei dirigenti, a disposizione del paese
di Roberto Caruso, presidente FP Cida
A noi dirigenti, professionisti ed alte professionalità della Federazione Cida Funzione Pubblica, piace essere la parte sindacale che rappresenta la classe dirigente, ma vuole essere a disposizione del sistema, di tutto il sistema. E intendiamo anche così ridare alla dirigenza il senso di appartenenza e l’appeal che giustifichi un’adesione appassionata a un ruolo sistemico chiave. Nel disegno di legge Zangrillo per lo sviluppo delle carriere e la valorizzazione del merito, a cui va riconosciuto il merito di aprire una nuova stagione di reclutamento di personale, si conferma il criterio di selezionare per concorso i dipendenti pubblici, ma per riqualificare il rapporto di questa funzione cruciale con il sistema Paese, è importante chiarire in che modo si fanno i concorsi. Oltre alla possibilità poi del corso/concorso, per una percentuale ben definita, la norma prescrive che l’accesso alla dirigenza potrà essere deciso da una Commissione di Dirigenti previa indicazione del candidato indicato direttamente dal dirigente apicale di riferimento che, quindi, può scegliere tra i suoi colaboratori quelli a suo giudizio più validi, indicandoli per un rapporto dirigenziale massimo di tre anni, indipendentemente dal concorso.
Non facciamo obiezioni di principio: se c’è trasparenza, il criterio può anche andare bene. Ma la trasparenza va garantita. Poi alcune altre questioni incombono sulla categoria. Innanzitutto una più chiara divisione dei confini di potere e responsabilità tra politica e gestione, che un po’ dovunque ma soprattutto negli enti locali, risulta ancora da realizzare pienamente. Allargando l’analisi al ceto medio, il cui nucleo centrale non può che essere costituito e rappresentato dai dirigenti e dalle alte professionalità pubbliche, a fronte di benefici minimi ed anzi spesso destinatario di provvedimenti fiscali e previdenziali sempre più penalizzanti, assistiamo ad un cumulo, peraltro, crescente di responsabilità e di rischi connessi al fatto di essere compresso tra datore di lavoro (sempre più o meno politico), personale e utenza. Sul fronte retributivo, peraltro, c’è ancora una giungla e molte sperequazioni, a fronte del fatto che paghiamo tutti tasse alte con trattenute alla fonte. E non abbiamo la protezione del welfare integrativo che ha il privato. Inoltre, pur comprendendo che le casse dello Stato contengono poche risorse, ed essendo consapevoli che i contratti collettivi nazionali si rinnovano spesso con incrementi risibili, comunque non possiamo accettare che nel 2025 la nostra categoria debba ancora iniziare a negoziare il rinnovo del contratto di lavoro 2022-2024: è per questo che abbiamo chiesto al Ministro della PA ed al Presidente dell’Aran di accorpare i contratti non ancora sottoscritti per due trienni, fino al 2027.
L'articolo Ceto medio alla riscossa proviene da Economy Magazine.