L’era della post-verità o della menzogna?
Sarebbe necessaria un'opinione pubblica dallo spirito critico ben allenato, e che abbia voglia di mettere a tacere quelle che sono in definitiva le sue scimmie, o i suoi giullari: i bullshitter (noi diremmo i contaballe). Il Bloc Notes di Michele Magno
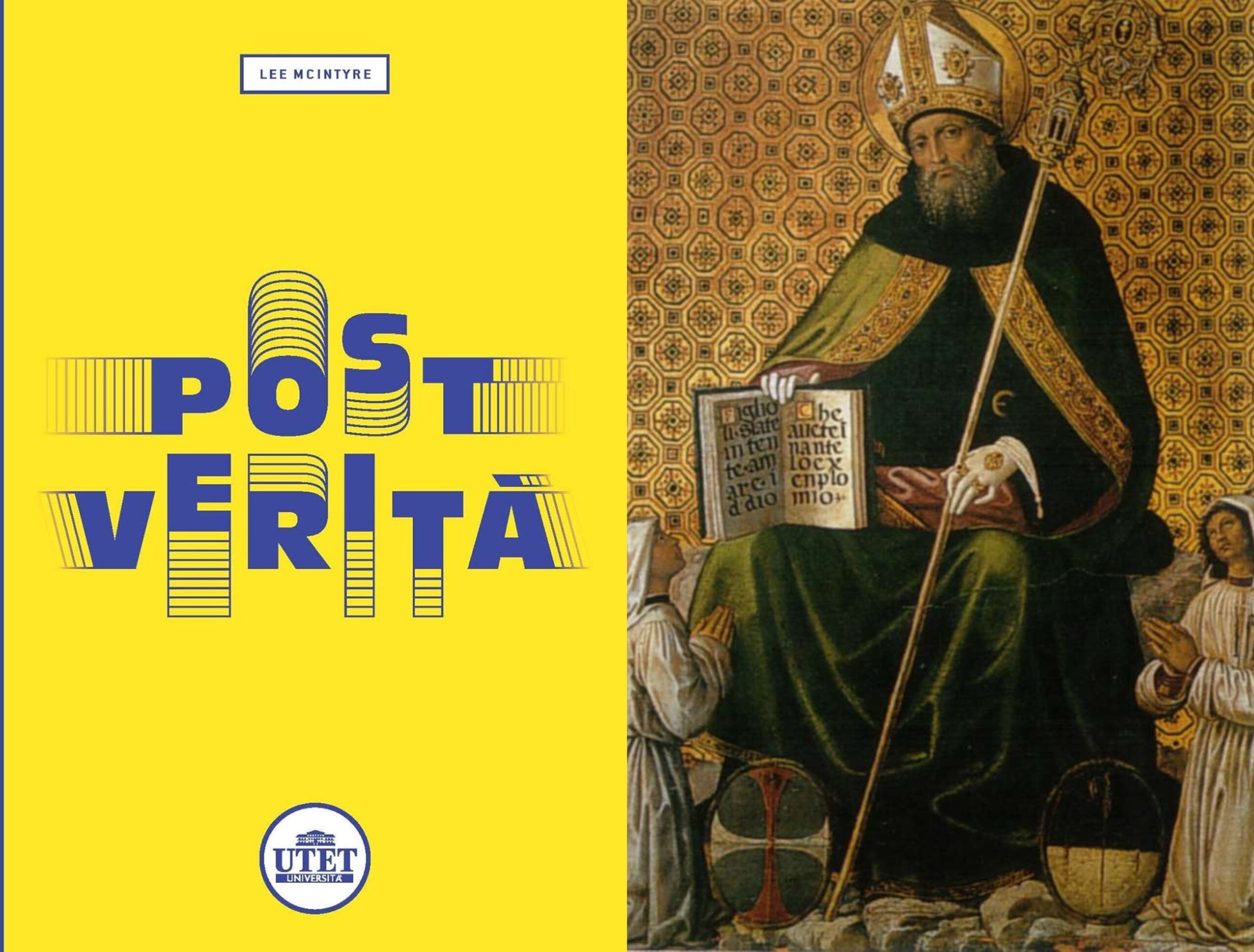
Sarebbe necessaria un’opinione pubblica dallo spirito critico ben allenato, e che abbia voglia di mettere a tacere quelle che sono in definitiva le sue scimmie, o i suoi giullari: i bullshitter (noi diremmo i contaballe). Il Bloc Notes di Michele Magno
“Quid est veritas?” (Che cos’è la verità?), è la celebre domanda con cui Ponzio Pilato ribatte alla dichiarazione di Cristo durante il suo processo: “Chiunque è per la verità ascolta la mia voce sulla verità” (Giovanni,18.38).
Ora, per la logica classica ciò che non è vero è falso, e ciò che è falso non è vero. In realtà, il campo del non vero è piuttosto vasto, vago e multiforme. Infatti, esistono molti modi di mentire. C’è la menzogna semplice (dire semplicemente il falso); la metamenzogna (dire che non si è detto ciò che si è detto); la premenzogna (che prepara le condizioni perché future menzogne siano ritenute vere); la menzogna senza menzogna (dire un vero parziale, che lascia intendere il falso).
Ma cos’è allora la menzogna? La sua definizione forse più comune, da sant’Agostino a oggi, è questa: la menzogna è l’atto linguistico compiuto con lo scopo di far credere vero ciò che si crede essere falso. Certo, c’è anche quello che Tommaso d’Aquino chiamava “pium mendacium” (la buona menzogna). Ti faccio credere il falso, ma a fin di bene: scelta moralmente lecita, tra gli altri, per Benedetto Croce, Dietrich Bonhöffer e Paul Feyerabend.
Un’altra tradizione, che fa riferimento soprattutto a Kant, ritiene invece che la menzogna sia sempre un male in sé, anche quando lo scopo è nobile o altruistico. Infatti, essa viola quella richiesta e aspettativa di verità (corrispondenza delle parole ai fatti) che è requisito basilare di un’etica della retta comunicazione (e, quindi, di una pacifica convivenza).
Diceva un profetico Ennio Flaiano che da quando la menzogna è così a buon mercato, la verità non ha più senso. Ebbene, ci sono dibattiti televisivi in cui predicatori senza abito talare, politici, intellettuali, opinionisti, con i loro giochi linguistici sui vaccini ieri e sul conflitto russo-ucraino (come su quello israelo-palestinese) oggi, dimostrano che si può tranquillamente fare a meno della conoscenza del vero. A decidere è solo l’arte della retorica o, meglio, di inventarsi minchiate.
Ma i talk show del piccolo schermo sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno ben più vasto. Nella Rete ci sono quasi due miliardi di siti web e più della metà della popolazione mondiale naviga su Internet: ogni secondo vengono inviati oltre due milioni e mezzo di messaggi di posta elettronica e vengono effettuate settantamila ricerche su Google. Le fake news invadono le pagine Internet, si diffondono come virus, e spesso riescono a distorcere le notizie e occultare come stanno realmente le cose. Complice il “libero arbitrio” del web, la loro manipolazione trova così un terreno fertile e si diffonde a macchia d’olio.
Come si possono sconfiggere, allora, i professionisti della bugia? Chi è favorevole a provvedimenti restrittivi della libertà di comunicazione, con il nobile scopo di arginare il falso, dovrebbe sapere che così si rischia di mettere a tacere anche il vero. D’altro canto, il vecchio principio del “lasciar crescere la gramigna” perché con essa cresca anche il grano, è nel tempo presente impresa assai ardua.
Chi scrive non ha soluzioni da proporre. Sarebbe necessaria un’opinione pubblica dallo spirito critico ben allenato, e che abbia voglia di mettere a tacere quelle che sono in definitiva le sue scimmie, o i suoi giullari: i bullshitter (noi diremmo i contaballe). Già, ma l’opinione pubblica italiana ne ha davvero voglia?



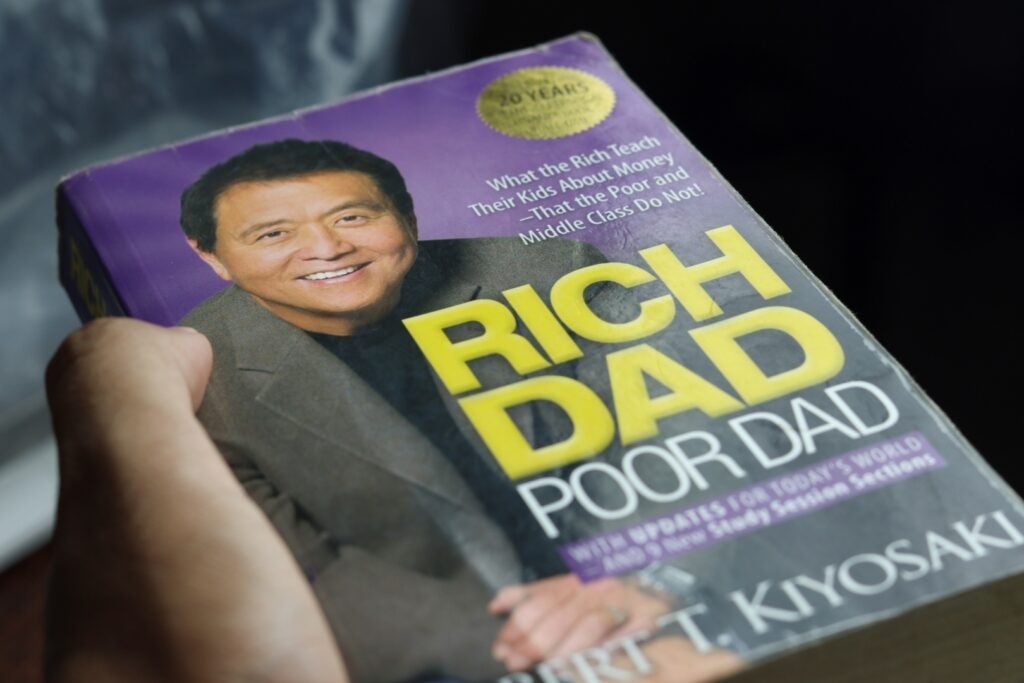






















![Giornata della Terra 2025, alla scoperta di 12 storie di fuoriclasse in campo e in rete per prendersi cura del pianeta e di tutti noi [EBOOK]](https://cdn-magazine.startupitalia.eu/wp-content/uploads/2025/04/18095613/WhatsApp-Image-2025-04-17-at-16.27.25-1-1024x516.jpeg?#)

















![Pino Allievi, Gp Arabia Saudita F1 2025: “Il miracolo di Leclerc” [ VIDEO ]](https://www.circusf1.com/f14/wp-content/uploads/2025/04/Pino_Allievi_Arabia_Saudita_F1_2025.jpg)




